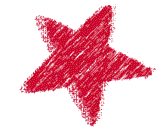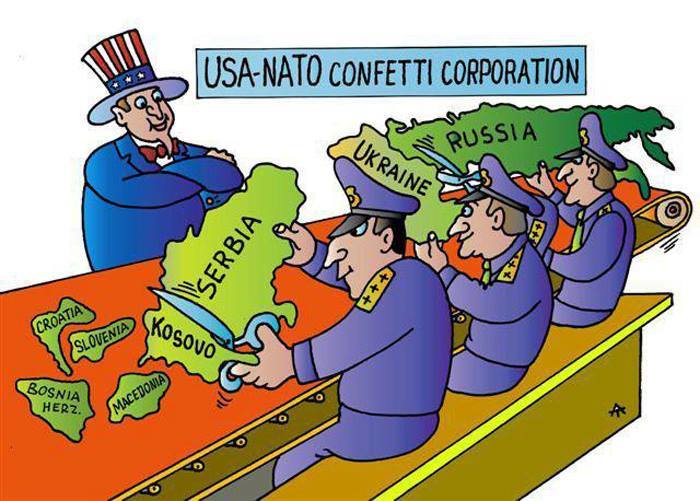Esimio Presidente,
Nella sua visita in Friuli Lei si fermerà anche a Faedis, uno dei paesi della Repubblica partigiana del Friuli Orientale, un’esperienza importantissima ed esaltante della guerra di liberazione, in cui gli abitanti di queste terre poterono, prima della fine della guerra e della vittoria sul nazifascismo, sperimentare alcuni tratti di democrazia e di autogoverno, dopo oltre vent’anni di dittatura fortemente centralistica, che aveva represso in particolare le numerose minoranze presenti nella nostra regione, prime fra tutte quella slovena. A questa esperienza, sviluppatasi dalla collaborazione delle varie componenti della Resistenza, diedero un determinante contributo i partigiani garibaldini, e fra essi molti erano gli aderenti a quel partito comunista italiano, di cui lei stesso ha fatto parte per decenni.
Faedis è anche il comune in cui si trovano le malghe di Topli Uorch, nome effettivo del luogo in cui avvenne l’eccidio che va sotto il nome di Porzûs. Il programma che Lei seguirà non prevede, così è stato detto, la sua salita alle malghe. Io immagino che questo avvenga, molto opportunamente, per evitare il possibile disagio che alla più alta figura istituzionale della Repubblica verrebbe dal rendere omaggio ad una lapide, che contiene molti nomi che non c’entrano con l’eccidio stesso. Penso che un ruolo, in questa scelta, possa aver avuto anche la consapevolezza che, prima di istituire alle malghe un monumento nazionale, quella di Porzûs sia una vicenda che vada ancora indagata e chiarita. Infatti i processi che si susseguirono negli anni cinquanta e che videro imputati e condannati decine di partigiani e di gappisti garibaldini, avvennero nel periodo più buio della guerra fredda, quando l’attacco alla resistenza garibaldina e comunista era, in Italia, nel suo punto più alto, con l’istruzione di centinaia di processi contro partigiani, di cui quello di Porzûs fu sicuramente il più imponente. Questo processo fu finalizzato precisamente alla messa fuori legge del partito comunista sotto l’accusa di “tradimento della patria”, obiettivo che non venne raggiunto soltanto per l’impegno del comitato di difesa, di cui fece parte anche il senatore Terracini, e per la continua mobilitazione antifascista e solidarietà che si creò intorno agli imputati. Solidarietà e impegno che tuttavia non furono sufficienti a evitare la condanna e la prigione preventiva di tanti di essi.
Nei decenni successivi si è detto che la verità processuale È la Verità. Le posso assicurare, signor Presidente, che le cose non stanno così. L’analisi della corposa documentazione processuale e di altra documentazione anche di fonte alleata resa disponibile negli ultimi decenni, dimostrano che le cose intorno all’eccidio di Porzûs sono molto diverse da come sono state riproposte. Purtroppo, ciò che risulta è che, con molta probabilità, alcuni comandanti osovani e fra questi anche Bolla, ebbero comportamenti di intesa con il nemico nazifascista, con trattative che costituirono un serio pericolo per le formazioni garibaldine.
Si è detto, in questi ultimi anni, dopo che queste intese e trattative non poterono più essere nascoste e confuse, che tutto questo fu fatto in difesa dell’italianità delle terre del confine orientale dall’invadenza slava. Ma Lei sa, signor Presidente, che queste terre fra il ’43 e il ’45 non erano già più Italia, essendo state annesse dal Terzo Reich. Lei sa, signor Presidente, che in queste terre esisteva una forte componente slovena che aveva sofferto molto dall’Italia fascista. Lei sa, signor Presidente, che le forze della resistenza jugoslava facevano parte dell’alleanza antinazifascista e che la direttiva del CLNAI era quella della collaborazione con i partigiani “slavi”. Lei sa, signor Presidente, che queste trattative dei comandanti osovani con tedeschi e repubblichini, fra cui la X Mas, avvennero contro quelle che erano le precise direttive del Comitato di Liberazione Alta Italia e del Corpo Volontari della Libertà, che considerarono tradimento, senza mezzi termini, le trattative di qualsiasi tipo con il nemico. Soprattutto se queste trattative avvenivano senza aver avvisato le altre componenti della Resistenza e, anzi, alle spalle di una di queste componenti, come succedeva in queste trattative osovane a danno dei garibaldini. Lei sa che questo processo non sarebbe mai dovuto avvenire perché per farlo dovettero venire violati articoli del trattato di pace e leggi della nuova repubblica, fra cui quell’amnistia che va sotto il nome di Togliatti, che servì alla “pacificazione” liberando i fascisti epurati, ma, a causa di un’applicazione ingiusta di una magistratura a quel tempo ancora molto compromessa con il passato regime, non evitò l’arresto e la detenzione di tanti partigiani.
L’eccidio di Porzûs, compiuto da partigiani gappisti a danno di partigiani osovani, si può giudicare che non sia stato un grande momento della storia della Resistenza, ma isolandolo dal contesto in cui avvenne e accettando in maniera acritica i risultati di una Giustizia che a quel tempo si dimostrò sicuramente non obiettiva, non si fa un grande servizio alla verità e alla giustizia storica.
Le chiedo, quindi, che prima di istituire il monumento nazionale a Porzûs, la sua Presidenza favorisca la formazione di una commissione di ricercatori storici che analizzino la vasta documentazione esistente, onde arrivare a una ricostruzione il più possibile obiettiva della vicenda della malghe di Porzûs, stabilendo anche chi e quanti furono gli uccisi e perché, e arrivare finalmente – se i risultati della ricerca lo consentiranno, come io penso – alla riabilitazione di molti di quei partigiani che furono ingiustamente condannati.
Udine, 27 maggio 2012
Alessandra Kersevan