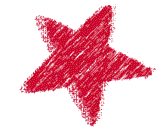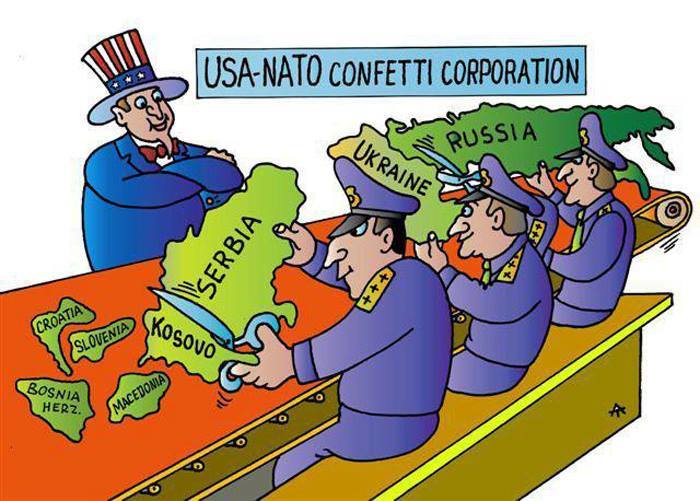Informazione
(Su questo importante libro, qui in fondo un commento di AM per il CNJ)
---
Antonio Evangelista
LA TORRE DEI CRANI
Kosovo 2000-2004
Prefazione di Pino Arlacchi (ex parlamentare, creatore della DIA -
Direzione Investigativa Antimafia)
Introduzione di Antonio Manganelli (attuale Capo della Polizia)
I edizione: marzo 2007
© Copyright Editori Riuniti
di The Media Factory srl
via Pietro della Valle, 13 - 00193 Roma
www.editoririuniti.it
ISBN 10: 88-359-5901-2
ISBN 13: 978-88-359-5901-4
---
Dall'ultima di copertina:
La guerra del Kosovo è stata vissuta dall'opinione pubblica italiana,
per una breve stagione, come un controverso e tragico evento di
politica internazionale. Poi è scomparsa dalle cronache. Ma dietro e
dentro quel conflitto c'è una realtà che non è scomparsa, anzi è
esplosa nella sua dimensione di conflitto etnico e di retroterra
della criminalità albanese in Italia e in Europa. L'autore di questo
libro è stato comandante della missione Unmik in Kosovo, ha diretto
le indagini sui crimini di guerra e guidato la polizia criminale.
Descrive, nelle sue pagine, i riti e le radici degli scontri etnico-
religiosi fra serbi e albanesi. Racconta l'organizzazione e le regole
non scritte dei clan.
La torre dei crani, che si trova in Serbia, vicino al confine con il
Kosovo, è il monumento vivente di un orrendo massacro di seicento
anni fa. Ma anche oggi incriminare qualcuno per un omicidio, in
quella terra disperata, è "come fare una multa per eccesso di
velocità ai piloti sulla pista di Indianapolis".
Antonio Evangelista è funzionario della Polizia di Stato e
attualmente dirige la squadra mobile di Asti. Ha partecipato, tra gli
anni 2000 e 2004, alla missione Onu Unmik in Kosovo, dapprima come
vicecomandante e poi come comandante. Si è occupato di investigazioni
sulla criminalità organizzata, intelligence, crimini di guerra,
terrorismo e mafia kosovara.
---
Indice
7 Prefazione. Le lezioni del Kosovo
di Pino Arlacchi
La torre dei crani
15 Introduzione di Antonio Manganelli
21 Prologo
PARTE PRIMA
23 Kosovo Polie: la valle dei corvi
Il regno di Serbia, p. 26 - La Risoluzione Onu 1244, p. 29 - Il Kanun
nella tradizione, p. 31 - La famiglia, p. 35 - Il Fis, p. 36 - La
donna in Kosovo, p. 40 - La parola data: il sequestro di Shaban
Manaj, p. 42 - La vendetta: hakmarrje/gjakmarrje, p. 44.
PARTE SECONDA
49 Crimine organizzato albanese
Criminali albanesi-kosovari crescono, p. 50 - Fattori criminogeni, p.
51 - L’arruolamento, p. 54 - Struttura organizzativa della mafia
albanese, p. 56 - Operazioni e attività: Stati Uniti, p. 58 -
Operazioni e attività: Italia, p. 63 - Banditi kosovari: mafiosi
vecchio stampo, p. 68 - Attività criminali in Kosovo, p. 69 - Il
traffico degli esseri umani, p. 89 - Il falso passaporto: il Dominion
di Melchizedek, p. 93 - La vittima del traffico di esseri umani, p.
95 - Collegamenti del crimine kosovaro-albanese, p. 97 - Estradizione
e transferring, p. 100.
PARTE TERZA
103 Terrorismo e terroristi
16 settembre 1982: Sabra e Shatila, p. 105 - Terrorismo mediorientale
e martiri, p. 107 - L’attentato suicida, p. 109 - Kosovo 17 marzo
2004: la notte dei cristalli, p. 111 - Disordini a Gjakovica: un
italiano è ferito, p. 114 - Pristina e i roghi di Ulpiana e
Caglavica, p. 115 - L’imboscata, p. 116 - Ushtria Clirimtare e
Kosovës (Uck), p. 117 - Armate Kombetare Shqipetare (Aksh), p. 120.
PARTE QUARTA
123 L’islam balcanico
Bill Clinton boulevard, p. 123 - L’islam balcanico, p. 126 - Le
attività degli estremisti islamici nei Balcani, p. 128 - La
prospettiva operativa di governi e organizzazioni islamiche, p. 130 -
Perchè usare una Ngo come copertura, p. 130 - Identificare le Ngo
illegittime, p. 131 - Balcani-Kosovo: un ponte per l’islam, p. 132 -
Ex premier: "il governo si basa su strutture mafiose...", p. 134.
137 Note
APPENDICE
145 Indice degli acronimi
147 Riferimenti bibliografici
151 Indice dei nomi
155 Ringraziamenti
---
Prefazione
Le lezioni del Kosovo
Il Kosovo è dal 1999 un protettorato delle Nazioni Unite, nonché una
provincia della Serbia sede di qualche miniera, di splendidi
monasteri medievali e di molti miti. La provincia è abitata in
prevalenza da albanesi di religione islamica, discriminati per molti
anni dal governo serbo e in cerca dell’indipendenza completa da
Belgrado. Il Kosovo contiene luoghi e monumenti che fanno parte
dell’identità nazionale dei serbi ma è anche un luogo dalle mille
contraddizioni, che fanno venire in mente il detto di Winston
Churchill che i Balcani producono più storia di quanta ne riescano a
consumare.
Come altrimenti considerare l’incredibile accumulo di grande storia
in un territorio che ha la stessa popolazione della Calabria (2
milioni di abitanti) ed è di un terzo più piccolo, ma che richiede un
seminario di scienza storico-sociale comparata solo per impadronirsi
dei termini elementari dei suoi problemi?
Nella "pianura dei corvi" si sono combattute nei secoli guerre di
ogni genere: di religione e di nazionalità, di conquista e di
liberazione, criminali e tecnologiche, etniche e politiche, tra Nord
e Sud, tra Est e Ovest, nonché svariate combinazioni tra di esse. E
di volta in volta gli aggressori sono diventati aggrediti, le vittime
si sono tramutate in carnefici, e viceversa, in un tragico gioco di
dominio e di risentimenti.
L’ultimo conflitto è del 1999. La NATO ha usato la forza per
obbligare il regime semi-autoritario di Milosevic a cessare la
sanguinosa persecuzione degli albanesi del Kosovo. Ma la guerra ha
prodotto più danni di quelli preesistenti, e ha generato le
condizioni di un nuovo turno di persecuzione, meno violenta di quella
precedente, e a parti invertite: è la maggioranza albanese che adesso
discrimina la minoranza serba.
Il risultato finale delle disgrazie kosovare, tuttavia, non è il caos
né l’avvento di un regno dell’insostenibilità e dell’assurdo. Non è
vero che non esistano ragionevoli vie d’uscita dal groviglio delle
crisi che tormentano il Kosovo. Basterebbe recepire, per individuare
un itinerario di soluzione, anche solo un paio delle lezioni che la
sua Odissea ha impartito a tutti noi. Questo itinerario è faticoso
quanto si vuole, ma interamente commisurato alle possibilità locali e
alle risorse dell’Unione Europea.
La prima e la più importante delle lezioni è che le guerre non
servono a niente. Anche quelle umanitarie e apparentemente
disinteressate come lo scontro tra i paesi Nato e il regime iugoslavo
nel 1999. La guerra del Kosovo è stata, infatti, un facile successo
militare e un completo fallimento politico. Tutte le guerre riservano
sorprese, e finiscono in modo diverso da quanto previsto e voluto
all’inizio, ma qui è stata la guerra in se stessa a costituire un
errore di valutazione politica madornale, del quale si stanno ancora
scontando le conseguenze.
I leader politici occidentali che l’hanno iniziata hanno dichiarato
di combatterla per il bene delle popolazioni locali. Ma queste sono
uscite dal conflitto in condizioni certamente peggiori di prima.
All’inizio della campagna di bombardamenti, i governi Nato hanno
detto di averli decisi per salvare delle vite umane da un progetto di
pulizia etnica in atto. Prima del 24 marzo 1999, le vittime della
guerra civile tra il Fronte di Liberazione del Kosovo (Kla) e le
forze ufficiali e paramilitari serbe erano state circa 3mila, e non
c’era evidenza di un piano di sterminio di massa da parte del governo
di Belgrado. Durante le 11 settimane di bombardamenti sono state
uccise nella provincia oltre 10mila persone. Le vittime sono state in
gran parte civili albanesi assassinati dalle formazioni irregolari e
dall’esercito serbo, ma anche serbi colpiti e messi in fuga per
vendetta. Il tentativo di pulizia etnica, quindi, se c’è stato, è
stato un effetto perverso della guerra e non una sua causa.
Un altro obiettivo della Nato era quello di prevenire lo sradicamento
forzato degli albanesi kosovari. All’inizio delle operazioni belliche
si stimavano in 230mila i kosovari che avevano abbandonato le loro
case. Alla fine della guerra, gli sradicati erano un milione e
quattrocentomila. Di questi, 840mila erano scappati verso i campi
profughi della Macedonia e dell’Albania. Non sappiamo oggi, e forse
non sapremo mai, quanti di questi rifugiati sono scappati per evitare
la furia assassina di Milosevic e quanti per timore delle bombe Nato.
In ogni caso, il capo della missione Onu nel Kosovo, Kouchner, ha
stimato che tra i kosovari in fuga c’erano anche 130mila serbi.
Quello che sappiamo con ragionevole certezza è che esisteva una
alternativa concreta alla guerra: il personale dell’Osce
(l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa)
dislocato nel Kosovo a protezione degli albanesi dopo il cessate il
fuoco tra i serbi e il Kla dell’ottobre 1998, e che poteva essere
impiegato per guadagnare il tempo necessario per una soluzione
pacifica del conflitto, e cioè per cambiare la leadership di Belgrado.
Questo cambiamento non era affatto impossibile. Milosevic non era
inespugnabile. Non era affatto popolare tra i serbi. Non controllava
in modo totalitario il paese, e le dimostrazioni del 1996-’97 lo
avevano quasi fatto cadere. Gli osservatori Osce non sarebbero forse
riusciti a impedire tutte le violenze, ma avrebbero sicuramente
ridotto gli attacchi ai civili e avrebbero evitato il successivo
disastro.
Dirigevo in quegli anni l’Ufficio Onu di Vienna, ed eravamo in
continuo contatto con il quartier generale dell’Osce, collocato nella
stessa città. Ricordo bene che l’opinione più diffusa in ogni rango
dell’Osce e dell’Onu era che il rafforzamento del contingente
internazionale già presente sul campo era l’alternativa più
praticabile alla guerra. Anche altri osservatori, come l’ex-
ambasciatore canadese in Iugoslavia, James Bisset, hanno dichiarato
che la Nato aveva combattuto in Kosovo una guerra "ingiusta e non
necessaria" e che il distaccamento del personale Osce poteva essere
la soluzione in grado di risparmiare le sofferenze umane e i costi
immensi della guerra.
Ma la Nato decise diversamente. Dopo avere convocato le parti nel
castello di Rambouillet, in Francia, nel febbraio-marzo 1999, la
signora Albright, Segretario di Stato americano, presentò loro un
piano di autonomia politica del Kosovo che prevedeva di tenere un
referendum dopo tre anni per decidere lo status finale della
provincia. Dopo il rifiuto dei serbi, iniziarono i bombardamenti.
La guerra terminò con un paradosso. Furono imposte a Milosevic
condizioni per alcuni versi più favorevoli di quelle proposte a
Rambouillet, tra cui la cessione dell’autorità sul Kosovo alle
Nazioni Unite, dove è presente con potere di veto la Russia, che è il
maggiore alleato internazionale della Serbia. Il centro del paradosso
fu che la guerra era stata combattuta dagli albanesi kosovari per
conquistare l’indipendenza del Kosovo dalla Serbia, e dai serbi per
mantenere il Kosovo parte della Iugoslavia. La conclusione fu che la
Nato era intervenuta in una guerra civile a sostegno della parte che
poi aveva vinto, per abbracciare in seguito la causa della parte
perdente sulla questione che aveva dato origine alla guerra. Il
Kosovo, infatti, secondo la risoluzione 1244 del Consiglio di
Sicurezza, è rimasto parte della Serbia. Il fallimento politico fu
perciò senza attenuanti: non erano state salvate vite umane, le
infrastrutture economiche essenziali della Serbia erano stata semi-
distrutte, e il Kosovo era rimasto giuridicamente dov’era prima. La
Nato, infatti, si era attivamente opposta alla sua separazione dalla
Serbia. La guerra non terminò neppure con una vera e propria
dichiarazione di resa, ma con una complessa serie di negoziati
durante i quali Russia e Serbia si adoperarono per strappare non
poche concessioni.
Ma la guerra del Kosovo ha avuto anche un altro aspetto. È stata
presentata come una guerra "giusta" che doveva dare inizio a una
nuova era, quella dell’intervento umanitario attivo e se possibile
preventivo, basato su due pilastri concettuali: l’uso della forza in
nome di valori universali invece che per conto dei ristretti
interessi nazionali che avevano fatto scontrare in passato gli Stati
sovrani, e (sempre in nome degli stessi valori universali)
l’intervento militare negli affari interni degli Stati invece della
solita opposizione alle violazioni dell’integrità territoriale, come
nella guerra del Golfo del 1991.
Il primo di questi concetti è stato applicato in modo incoerente.
Avendo deciso di non mettere a rischio l’incolumità del proprio
personale militare, la campagna del Kosovo fu sostanzialmente una
guerra aerea, fatta di bombardamenti ad alta quota. Nessuno si è
accorto, perciò, che lo scopo della guerra era quello di proteggere
gli albanesi del Kosovo.
Il secondo pilastro della dottrina dell’intervento umanitario era
apertamente illegale dal punto di vista delle fondamenta del diritto
internazionale e degli standard riconosciuti di condotta nelle
relazioni tra Stati. Un paese o un gruppo di paesi non possono
interferire negli affari interni di un altro paese. E tantomeno con
la forza. Se ciò avviene, sono le basi stesse dell’ordine
internazionale che vengono compromesse.
Ma se questa regola è inviolabile, non ci sono più limiti alle
trasgressioni dei diritti umani compiute dai tiranni o da gruppi
delinquenziali entro i confini dei loro Stati. È per questo che la
coscienza universale non si è ribellata quando la comunità
internazionale ha deciso di intervenire per fermare genocidi e
massacri in corso in luoghi come la Somalia, Haiti, il Congo o il
Rwanda. In questi luoghi, però, non si era bombardato da alta quota,
e neppure da bassa. Si erano svolti interventi che rientravano negli
schemi delle operazioni di mantenimento della pace più che in quelli
delle guerre.
L’intervento ispirato dalla protezione dei diritti umani non può
essere attuato con modalità che contraddicono il suo mandato. Deve
essere legittimato da una autorità globale – il Consiglio di
Sicurezza o l’Assemblea delle Nazioni Unite – e non deve lasciare
dubbi sulle sue matrici umanitarie. Il rispetto delle Convenzioni
Internazionali sulla condotta delle guerre, l’uso delle armi e il
risparmio dei civili deve essere più che scrupoloso.
Entrambe queste condizioni sono state violate dalla Nato in occasione
della guerra del Kosovo. La Nato ha agito senza autorizzazione del
Consiglio di Sicurezza. Ciò implica che essa si è arrogata il diritto
di scegliere se obbedire o no alle leggi internazionali, creando un
precedente in base al quale qualunque associazione regionale può
attribuirsi le prerogative delle Nazioni Unite in materia di
salvaguardia dei diritti umani, e intervenire militarmente contro la
violazione dei diritti di una etnia presente in qualunque parte del
pianeta. La Russia, per esempio, potrebbe intervenire in Ucraina,
attraverso il Cis (Commonwealth of Indipendent States), se ad un
certo punto ritenesse che i russi ivi residenti fossero maltrattati.
E la Cina potrebbe fare lo stesso in diversi paesi asiatici dove sono
presenti comunità di immigrati cinesi tramite una delle
organizzazioni di cui fa parte o su cui ha influenza.
La Nato in Kosovo, inoltre, ha violato l’articolo 14 del Protocollo
del 1977 della Convenzione di Ginevra del 1949 che proibisce gli
attacchi contro "obiettivi indispensabili alla sopravvivenza della
popolazione". Una guerra "giusta" si fa risparmiando prima di tutto i
non combattenti. È vero che la Nato ha impiegato una certa cura
nell’evitare gli attacchi diretti alla popolazione serba, nel senso
che non sono state bombardate abitazioni private e luoghi frequentati
dalla gente. Ma ha compiuto vaste distruzioni di infrastrutture
essenziali, inclusi gli impianti dell’acqua e dell’elettricità, che
hanno provocato grandi danni e disagi alla popolazione civile. Le
distruzioni della guerra sono state stimate ammontare a circa 30
miliardi di dollari del 1999, pari a una volta e mezza il Pil della
Serbia e del Montenegro dello stesso anno. La Nato ha perciò punito
invece di aiutare la seconda vittima innocente, dopo gli albanesi del
Kosovo, della brutalità di Milosevic, e cioè la popolazione civile
serba.
La seconda grande lezione della guerra del Kosovo è che non ci sono
più scontri ineluttabili di culture, etnie e civiltà, se non nelle
interpretazioni dei loro fautori. Le motivazioni e i comportamenti
reali dei protagonisti di questi scontri sono molto distanti da
quelli attribuiti loro dalla politica, dalla diplomazia e dal
circuito dell’informazione internazionali. Il Kosovo non è una
provincia di odi etnici secolari e di fanatismo religioso. E il resto
dei Balcani non è diverso.
La lettura della testimonianza di Antonio Evangelista è altamente
istruttiva al riguardo. Si tratta di uno dei pochissimi documenti sul
Kosovo che parte da fatti vissuti in prima persona, e da informazioni
raccolte da una posizione esterna, neutrale, come può essere quella
di un funzionario di polizia che opera nel contesto di una missione
di pace. La sua valutazione del problema principale del Kosovo
attuale è netta. Non esiste in questo territorio alcuna reale
conflittualità di tipo religioso, e neppure di tipo etnico. La
cosiddetta minaccia terroristica è enormemente inflazionata, perchè
la religione islamica non è parte decisiva dell’identità e dei valori
degli albanesi del Kosovo. La versione dell’islam qui diffusa è molto
blanda, incapace perciò di generare fanatismo ed estremismo politico.
Secondo Evangelista, questa identità si fonda molto di più
sull’eredità di una società pastorale basata sul clan e sul diritto
primordiale del Kanun, il codice civile e penale del popolo delle
montagne, vivo e attuale, anche nei suoi tragici risvolti, nel Kosovo
di questi tempi.
Le chiese e i monasteri ortodossi bruciati durante i disordini del
2004 in Kosovo non erano i simboli di una irriducibile alterità
religiosa, ma quelli del potere e della cultura serbi. E i disordini
stessi sono stati tutt’altro che una spontanea eruzione di
malcontento popolare contro l’amministrazione Onu, il governo serbo e
i ritardi del processo di autodeterminazione. La preordinazione e la
regia delle manifestazioni da parte di un centro di potere nascosto
erano evidenti.
Secondo Evangelista, buona parte dell’attuale crisi del Kosovo si
spiega con un fatto che la comunità internazionale e l’opinione
pubblica, sia europea che americana, preferiscono ignorare: la
perdurante e profonda influenza del Kla e delle sue attività in quasi
ogni aspetto della vita del Kosovo. Troviamo anche qui l’eredità di
una guerra sbagliata.
Il Kla è stato fin dalle origini un coacervo di bande dalle origini
più disparate e di discutibile valore militare, emerse in modo quasi
improvviso sulla scena della crisi iugoslava. Sostenuti e armati
dalle forze Nato come forza di ribellione alle atrocità dell’esercito
e dei paramilitari serbi contro gli albanesi, i militanti del Kla si
sono a loro volta macchiati di crimini efferati, molti dei quali
contro cittadini albanesi sommariamente etichettati come traditori o
collaborazionisti. Vari appartenenti al Kla, inoltre, si sono trovati
e sono attualmente nel mirino delle agenzie antidroga europee come
protagonisti di primo piano della rotta balcanica dell’eroina.
Il Kla è oggi parte di un gruppo di potere politico-economico-
criminale composto da 3 mega-clan divisi in 13 sottoclan minori che
controllano le principali istituzioni, nonché l’economia e la società
kosovara. Alcuni tra i capi più noti di questi clan sono accusati
dalla Corte Penale dell’Aia sui crimini commessi nella ex-Iugoslavia,
provengono dalle fila della criminalità, e in essa sono rimasti
durante e dopo la guerra contro il regime di Belgrado.
La fusione e la quasi identificazione del Kla e dei suoi capi con la
mafia kosovaro-albanese, che è la più aggressiva formazione criminale
organizzata dell’Europa odierna, fa del problema del Kosovo una delle
più serie minacce alla sicurezza del continente. E dell’Italia in
modo particolare. L’allarme documentato che Antonio Evangelista
lancia tramite la sua testimonianza non deve passare sotto silenzio.
I diplomatici e gli uomini politici del cosiddetto "Gruppo di
Contatto" – Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Russia – che
discettano assieme all’Onu intorno al futuro assetto dei rapporti tra
il Kosovo e la comunità internazionale, non sembrano tenere conto
delle dure evidenze narrate in questo volume. La questione della
criminalità organizzata, della corruzione politica e del malgoverno
dilaganti nel Kosovo, e i loro sinistri riflessi in molti paesi
europei, non è presente nell’agenda dei negoziati. È come se
l’argomento non esistesse. È superfluo sottolineare come i cittadini
europei, e quelli italiani in prima fila, pagheranno amaramente
questa omissione nei prossimi anni, quando un possibile Kosovo
indipendente regalerà l’immunità diplomatica a molti delinquenti
arrivati ai vertici della politica locale.
Chi legge questo volume e confronta i fatti in esso esposti con gli
standard di legalità vigenti nei paesi occidentali può facilmente
intravedere i contorni di un corso di azione alternativo per la
soluzione della crisi kosovara. Se non si spezza il cerchio di potere
politico-mafioso che domina quella provincia, dalla sua indipendenza
non potrà venire nulla di diverso che l’instaurazione di uno Stato
criminale vicino al centro dell’Europa.
Pino Arlacchi
Roma, 19 gennaio 2007
---
Abbiamo ricevuto e volentieri giriamo la segnalazione di questo libro
recentemente uscito, di grandissimo interesse viste tra l'altro le
funzioni istituzionali svolte dall'autore e da chi ha scritto
Prefazione ed Introduzione.
Abbiamo riportato quest'ultima integralmente: chi segue JUGOINFO può
comprendere quali, tra le opinioni espresse, dal nostro punto di
vista meritino un commento critico. Nel nostro lavoro di
documentazione continuamente argomentiamo sull'ingenuità (o peggio)
delle posizioni per la "difesa dei diritti umani" che omettono di
considerare il contesto geo-strategico e la altrettanto strategica
disinformazione ("guerra psicologica"). Stona dover leggere ancora di
"brutalità" e "sanguinosa persecuzione" cui sarebbero stati
sottoposti gli albanesi-kosovari - e con che presunzione parlarne poi
noi, che abbiamo visto Genova (luglio 2001)? - o della ipotetica
necessità di "cambiare la leadership di Belgrado" come "soluzione
pacifica del conflitto" - imponendo dall'estero un "governo amico"...
Queste posizioni pregiudiziali espresse nell'Introduzione, che
continuiamo a ritenere sbagliate, non inficiano comunque il valore di
un libro che, grazie alla serietà della documentazione e delle
testimonianze presentate, illustra bene un tema tanto scomodo da
essere raramente oggetto di discussione da parte di chi, pure,
dovrebbe occuparsene.
Sullo stesso tema segnaliamo anche "Uck: l'armata dell'ombra" di S.
Provvisionato (Gamberetti 2000).
A cura di AM per il CNJ
---
Antonio Evangelista
LA TORRE DEI CRANI
Kosovo 2000-2004
Prefazione di Pino Arlacchi (ex parlamentare, creatore della DIA -
Direzione Investigativa Antimafia)
Introduzione di Antonio Manganelli (attuale Capo della Polizia)
I edizione: marzo 2007
© Copyright Editori Riuniti
di The Media Factory srl
via Pietro della Valle, 13 - 00193 Roma
www.editoririuniti.it
ISBN 10: 88-359-5901-2
ISBN 13: 978-88-359-5901-4
---
Dall'ultima di copertina:
La guerra del Kosovo è stata vissuta dall'opinione pubblica italiana,
per una breve stagione, come un controverso e tragico evento di
politica internazionale. Poi è scomparsa dalle cronache. Ma dietro e
dentro quel conflitto c'è una realtà che non è scomparsa, anzi è
esplosa nella sua dimensione di conflitto etnico e di retroterra
della criminalità albanese in Italia e in Europa. L'autore di questo
libro è stato comandante della missione Unmik in Kosovo, ha diretto
le indagini sui crimini di guerra e guidato la polizia criminale.
Descrive, nelle sue pagine, i riti e le radici degli scontri etnico-
religiosi fra serbi e albanesi. Racconta l'organizzazione e le regole
non scritte dei clan.
La torre dei crani, che si trova in Serbia, vicino al confine con il
Kosovo, è il monumento vivente di un orrendo massacro di seicento
anni fa. Ma anche oggi incriminare qualcuno per un omicidio, in
quella terra disperata, è "come fare una multa per eccesso di
velocità ai piloti sulla pista di Indianapolis".
Antonio Evangelista è funzionario della Polizia di Stato e
attualmente dirige la squadra mobile di Asti. Ha partecipato, tra gli
anni 2000 e 2004, alla missione Onu Unmik in Kosovo, dapprima come
vicecomandante e poi come comandante. Si è occupato di investigazioni
sulla criminalità organizzata, intelligence, crimini di guerra,
terrorismo e mafia kosovara.
---
Indice
7 Prefazione. Le lezioni del Kosovo
di Pino Arlacchi
La torre dei crani
15 Introduzione di Antonio Manganelli
21 Prologo
PARTE PRIMA
23 Kosovo Polie: la valle dei corvi
Il regno di Serbia, p. 26 - La Risoluzione Onu 1244, p. 29 - Il Kanun
nella tradizione, p. 31 - La famiglia, p. 35 - Il Fis, p. 36 - La
donna in Kosovo, p. 40 - La parola data: il sequestro di Shaban
Manaj, p. 42 - La vendetta: hakmarrje/gjakmarrje, p. 44.
PARTE SECONDA
49 Crimine organizzato albanese
Criminali albanesi-kosovari crescono, p. 50 - Fattori criminogeni, p.
51 - L’arruolamento, p. 54 - Struttura organizzativa della mafia
albanese, p. 56 - Operazioni e attività: Stati Uniti, p. 58 -
Operazioni e attività: Italia, p. 63 - Banditi kosovari: mafiosi
vecchio stampo, p. 68 - Attività criminali in Kosovo, p. 69 - Il
traffico degli esseri umani, p. 89 - Il falso passaporto: il Dominion
di Melchizedek, p. 93 - La vittima del traffico di esseri umani, p.
95 - Collegamenti del crimine kosovaro-albanese, p. 97 - Estradizione
e transferring, p. 100.
PARTE TERZA
103 Terrorismo e terroristi
16 settembre 1982: Sabra e Shatila, p. 105 - Terrorismo mediorientale
e martiri, p. 107 - L’attentato suicida, p. 109 - Kosovo 17 marzo
2004: la notte dei cristalli, p. 111 - Disordini a Gjakovica: un
italiano è ferito, p. 114 - Pristina e i roghi di Ulpiana e
Caglavica, p. 115 - L’imboscata, p. 116 - Ushtria Clirimtare e
Kosovës (Uck), p. 117 - Armate Kombetare Shqipetare (Aksh), p. 120.
PARTE QUARTA
123 L’islam balcanico
Bill Clinton boulevard, p. 123 - L’islam balcanico, p. 126 - Le
attività degli estremisti islamici nei Balcani, p. 128 - La
prospettiva operativa di governi e organizzazioni islamiche, p. 130 -
Perchè usare una Ngo come copertura, p. 130 - Identificare le Ngo
illegittime, p. 131 - Balcani-Kosovo: un ponte per l’islam, p. 132 -
Ex premier: "il governo si basa su strutture mafiose...", p. 134.
137 Note
APPENDICE
145 Indice degli acronimi
147 Riferimenti bibliografici
151 Indice dei nomi
155 Ringraziamenti
---
Prefazione
Le lezioni del Kosovo
Il Kosovo è dal 1999 un protettorato delle Nazioni Unite, nonché una
provincia della Serbia sede di qualche miniera, di splendidi
monasteri medievali e di molti miti. La provincia è abitata in
prevalenza da albanesi di religione islamica, discriminati per molti
anni dal governo serbo e in cerca dell’indipendenza completa da
Belgrado. Il Kosovo contiene luoghi e monumenti che fanno parte
dell’identità nazionale dei serbi ma è anche un luogo dalle mille
contraddizioni, che fanno venire in mente il detto di Winston
Churchill che i Balcani producono più storia di quanta ne riescano a
consumare.
Come altrimenti considerare l’incredibile accumulo di grande storia
in un territorio che ha la stessa popolazione della Calabria (2
milioni di abitanti) ed è di un terzo più piccolo, ma che richiede un
seminario di scienza storico-sociale comparata solo per impadronirsi
dei termini elementari dei suoi problemi?
Nella "pianura dei corvi" si sono combattute nei secoli guerre di
ogni genere: di religione e di nazionalità, di conquista e di
liberazione, criminali e tecnologiche, etniche e politiche, tra Nord
e Sud, tra Est e Ovest, nonché svariate combinazioni tra di esse. E
di volta in volta gli aggressori sono diventati aggrediti, le vittime
si sono tramutate in carnefici, e viceversa, in un tragico gioco di
dominio e di risentimenti.
L’ultimo conflitto è del 1999. La NATO ha usato la forza per
obbligare il regime semi-autoritario di Milosevic a cessare la
sanguinosa persecuzione degli albanesi del Kosovo. Ma la guerra ha
prodotto più danni di quelli preesistenti, e ha generato le
condizioni di un nuovo turno di persecuzione, meno violenta di quella
precedente, e a parti invertite: è la maggioranza albanese che adesso
discrimina la minoranza serba.
Il risultato finale delle disgrazie kosovare, tuttavia, non è il caos
né l’avvento di un regno dell’insostenibilità e dell’assurdo. Non è
vero che non esistano ragionevoli vie d’uscita dal groviglio delle
crisi che tormentano il Kosovo. Basterebbe recepire, per individuare
un itinerario di soluzione, anche solo un paio delle lezioni che la
sua Odissea ha impartito a tutti noi. Questo itinerario è faticoso
quanto si vuole, ma interamente commisurato alle possibilità locali e
alle risorse dell’Unione Europea.
La prima e la più importante delle lezioni è che le guerre non
servono a niente. Anche quelle umanitarie e apparentemente
disinteressate come lo scontro tra i paesi Nato e il regime iugoslavo
nel 1999. La guerra del Kosovo è stata, infatti, un facile successo
militare e un completo fallimento politico. Tutte le guerre riservano
sorprese, e finiscono in modo diverso da quanto previsto e voluto
all’inizio, ma qui è stata la guerra in se stessa a costituire un
errore di valutazione politica madornale, del quale si stanno ancora
scontando le conseguenze.
I leader politici occidentali che l’hanno iniziata hanno dichiarato
di combatterla per il bene delle popolazioni locali. Ma queste sono
uscite dal conflitto in condizioni certamente peggiori di prima.
All’inizio della campagna di bombardamenti, i governi Nato hanno
detto di averli decisi per salvare delle vite umane da un progetto di
pulizia etnica in atto. Prima del 24 marzo 1999, le vittime della
guerra civile tra il Fronte di Liberazione del Kosovo (Kla) e le
forze ufficiali e paramilitari serbe erano state circa 3mila, e non
c’era evidenza di un piano di sterminio di massa da parte del governo
di Belgrado. Durante le 11 settimane di bombardamenti sono state
uccise nella provincia oltre 10mila persone. Le vittime sono state in
gran parte civili albanesi assassinati dalle formazioni irregolari e
dall’esercito serbo, ma anche serbi colpiti e messi in fuga per
vendetta. Il tentativo di pulizia etnica, quindi, se c’è stato, è
stato un effetto perverso della guerra e non una sua causa.
Un altro obiettivo della Nato era quello di prevenire lo sradicamento
forzato degli albanesi kosovari. All’inizio delle operazioni belliche
si stimavano in 230mila i kosovari che avevano abbandonato le loro
case. Alla fine della guerra, gli sradicati erano un milione e
quattrocentomila. Di questi, 840mila erano scappati verso i campi
profughi della Macedonia e dell’Albania. Non sappiamo oggi, e forse
non sapremo mai, quanti di questi rifugiati sono scappati per evitare
la furia assassina di Milosevic e quanti per timore delle bombe Nato.
In ogni caso, il capo della missione Onu nel Kosovo, Kouchner, ha
stimato che tra i kosovari in fuga c’erano anche 130mila serbi.
Quello che sappiamo con ragionevole certezza è che esisteva una
alternativa concreta alla guerra: il personale dell’Osce
(l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa)
dislocato nel Kosovo a protezione degli albanesi dopo il cessate il
fuoco tra i serbi e il Kla dell’ottobre 1998, e che poteva essere
impiegato per guadagnare il tempo necessario per una soluzione
pacifica del conflitto, e cioè per cambiare la leadership di Belgrado.
Questo cambiamento non era affatto impossibile. Milosevic non era
inespugnabile. Non era affatto popolare tra i serbi. Non controllava
in modo totalitario il paese, e le dimostrazioni del 1996-’97 lo
avevano quasi fatto cadere. Gli osservatori Osce non sarebbero forse
riusciti a impedire tutte le violenze, ma avrebbero sicuramente
ridotto gli attacchi ai civili e avrebbero evitato il successivo
disastro.
Dirigevo in quegli anni l’Ufficio Onu di Vienna, ed eravamo in
continuo contatto con il quartier generale dell’Osce, collocato nella
stessa città. Ricordo bene che l’opinione più diffusa in ogni rango
dell’Osce e dell’Onu era che il rafforzamento del contingente
internazionale già presente sul campo era l’alternativa più
praticabile alla guerra. Anche altri osservatori, come l’ex-
ambasciatore canadese in Iugoslavia, James Bisset, hanno dichiarato
che la Nato aveva combattuto in Kosovo una guerra "ingiusta e non
necessaria" e che il distaccamento del personale Osce poteva essere
la soluzione in grado di risparmiare le sofferenze umane e i costi
immensi della guerra.
Ma la Nato decise diversamente. Dopo avere convocato le parti nel
castello di Rambouillet, in Francia, nel febbraio-marzo 1999, la
signora Albright, Segretario di Stato americano, presentò loro un
piano di autonomia politica del Kosovo che prevedeva di tenere un
referendum dopo tre anni per decidere lo status finale della
provincia. Dopo il rifiuto dei serbi, iniziarono i bombardamenti.
La guerra terminò con un paradosso. Furono imposte a Milosevic
condizioni per alcuni versi più favorevoli di quelle proposte a
Rambouillet, tra cui la cessione dell’autorità sul Kosovo alle
Nazioni Unite, dove è presente con potere di veto la Russia, che è il
maggiore alleato internazionale della Serbia. Il centro del paradosso
fu che la guerra era stata combattuta dagli albanesi kosovari per
conquistare l’indipendenza del Kosovo dalla Serbia, e dai serbi per
mantenere il Kosovo parte della Iugoslavia. La conclusione fu che la
Nato era intervenuta in una guerra civile a sostegno della parte che
poi aveva vinto, per abbracciare in seguito la causa della parte
perdente sulla questione che aveva dato origine alla guerra. Il
Kosovo, infatti, secondo la risoluzione 1244 del Consiglio di
Sicurezza, è rimasto parte della Serbia. Il fallimento politico fu
perciò senza attenuanti: non erano state salvate vite umane, le
infrastrutture economiche essenziali della Serbia erano stata semi-
distrutte, e il Kosovo era rimasto giuridicamente dov’era prima. La
Nato, infatti, si era attivamente opposta alla sua separazione dalla
Serbia. La guerra non terminò neppure con una vera e propria
dichiarazione di resa, ma con una complessa serie di negoziati
durante i quali Russia e Serbia si adoperarono per strappare non
poche concessioni.
Ma la guerra del Kosovo ha avuto anche un altro aspetto. È stata
presentata come una guerra "giusta" che doveva dare inizio a una
nuova era, quella dell’intervento umanitario attivo e se possibile
preventivo, basato su due pilastri concettuali: l’uso della forza in
nome di valori universali invece che per conto dei ristretti
interessi nazionali che avevano fatto scontrare in passato gli Stati
sovrani, e (sempre in nome degli stessi valori universali)
l’intervento militare negli affari interni degli Stati invece della
solita opposizione alle violazioni dell’integrità territoriale, come
nella guerra del Golfo del 1991.
Il primo di questi concetti è stato applicato in modo incoerente.
Avendo deciso di non mettere a rischio l’incolumità del proprio
personale militare, la campagna del Kosovo fu sostanzialmente una
guerra aerea, fatta di bombardamenti ad alta quota. Nessuno si è
accorto, perciò, che lo scopo della guerra era quello di proteggere
gli albanesi del Kosovo.
Il secondo pilastro della dottrina dell’intervento umanitario era
apertamente illegale dal punto di vista delle fondamenta del diritto
internazionale e degli standard riconosciuti di condotta nelle
relazioni tra Stati. Un paese o un gruppo di paesi non possono
interferire negli affari interni di un altro paese. E tantomeno con
la forza. Se ciò avviene, sono le basi stesse dell’ordine
internazionale che vengono compromesse.
Ma se questa regola è inviolabile, non ci sono più limiti alle
trasgressioni dei diritti umani compiute dai tiranni o da gruppi
delinquenziali entro i confini dei loro Stati. È per questo che la
coscienza universale non si è ribellata quando la comunità
internazionale ha deciso di intervenire per fermare genocidi e
massacri in corso in luoghi come la Somalia, Haiti, il Congo o il
Rwanda. In questi luoghi, però, non si era bombardato da alta quota,
e neppure da bassa. Si erano svolti interventi che rientravano negli
schemi delle operazioni di mantenimento della pace più che in quelli
delle guerre.
L’intervento ispirato dalla protezione dei diritti umani non può
essere attuato con modalità che contraddicono il suo mandato. Deve
essere legittimato da una autorità globale – il Consiglio di
Sicurezza o l’Assemblea delle Nazioni Unite – e non deve lasciare
dubbi sulle sue matrici umanitarie. Il rispetto delle Convenzioni
Internazionali sulla condotta delle guerre, l’uso delle armi e il
risparmio dei civili deve essere più che scrupoloso.
Entrambe queste condizioni sono state violate dalla Nato in occasione
della guerra del Kosovo. La Nato ha agito senza autorizzazione del
Consiglio di Sicurezza. Ciò implica che essa si è arrogata il diritto
di scegliere se obbedire o no alle leggi internazionali, creando un
precedente in base al quale qualunque associazione regionale può
attribuirsi le prerogative delle Nazioni Unite in materia di
salvaguardia dei diritti umani, e intervenire militarmente contro la
violazione dei diritti di una etnia presente in qualunque parte del
pianeta. La Russia, per esempio, potrebbe intervenire in Ucraina,
attraverso il Cis (Commonwealth of Indipendent States), se ad un
certo punto ritenesse che i russi ivi residenti fossero maltrattati.
E la Cina potrebbe fare lo stesso in diversi paesi asiatici dove sono
presenti comunità di immigrati cinesi tramite una delle
organizzazioni di cui fa parte o su cui ha influenza.
La Nato in Kosovo, inoltre, ha violato l’articolo 14 del Protocollo
del 1977 della Convenzione di Ginevra del 1949 che proibisce gli
attacchi contro "obiettivi indispensabili alla sopravvivenza della
popolazione". Una guerra "giusta" si fa risparmiando prima di tutto i
non combattenti. È vero che la Nato ha impiegato una certa cura
nell’evitare gli attacchi diretti alla popolazione serba, nel senso
che non sono state bombardate abitazioni private e luoghi frequentati
dalla gente. Ma ha compiuto vaste distruzioni di infrastrutture
essenziali, inclusi gli impianti dell’acqua e dell’elettricità, che
hanno provocato grandi danni e disagi alla popolazione civile. Le
distruzioni della guerra sono state stimate ammontare a circa 30
miliardi di dollari del 1999, pari a una volta e mezza il Pil della
Serbia e del Montenegro dello stesso anno. La Nato ha perciò punito
invece di aiutare la seconda vittima innocente, dopo gli albanesi del
Kosovo, della brutalità di Milosevic, e cioè la popolazione civile
serba.
La seconda grande lezione della guerra del Kosovo è che non ci sono
più scontri ineluttabili di culture, etnie e civiltà, se non nelle
interpretazioni dei loro fautori. Le motivazioni e i comportamenti
reali dei protagonisti di questi scontri sono molto distanti da
quelli attribuiti loro dalla politica, dalla diplomazia e dal
circuito dell’informazione internazionali. Il Kosovo non è una
provincia di odi etnici secolari e di fanatismo religioso. E il resto
dei Balcani non è diverso.
La lettura della testimonianza di Antonio Evangelista è altamente
istruttiva al riguardo. Si tratta di uno dei pochissimi documenti sul
Kosovo che parte da fatti vissuti in prima persona, e da informazioni
raccolte da una posizione esterna, neutrale, come può essere quella
di un funzionario di polizia che opera nel contesto di una missione
di pace. La sua valutazione del problema principale del Kosovo
attuale è netta. Non esiste in questo territorio alcuna reale
conflittualità di tipo religioso, e neppure di tipo etnico. La
cosiddetta minaccia terroristica è enormemente inflazionata, perchè
la religione islamica non è parte decisiva dell’identità e dei valori
degli albanesi del Kosovo. La versione dell’islam qui diffusa è molto
blanda, incapace perciò di generare fanatismo ed estremismo politico.
Secondo Evangelista, questa identità si fonda molto di più
sull’eredità di una società pastorale basata sul clan e sul diritto
primordiale del Kanun, il codice civile e penale del popolo delle
montagne, vivo e attuale, anche nei suoi tragici risvolti, nel Kosovo
di questi tempi.
Le chiese e i monasteri ortodossi bruciati durante i disordini del
2004 in Kosovo non erano i simboli di una irriducibile alterità
religiosa, ma quelli del potere e della cultura serbi. E i disordini
stessi sono stati tutt’altro che una spontanea eruzione di
malcontento popolare contro l’amministrazione Onu, il governo serbo e
i ritardi del processo di autodeterminazione. La preordinazione e la
regia delle manifestazioni da parte di un centro di potere nascosto
erano evidenti.
Secondo Evangelista, buona parte dell’attuale crisi del Kosovo si
spiega con un fatto che la comunità internazionale e l’opinione
pubblica, sia europea che americana, preferiscono ignorare: la
perdurante e profonda influenza del Kla e delle sue attività in quasi
ogni aspetto della vita del Kosovo. Troviamo anche qui l’eredità di
una guerra sbagliata.
Il Kla è stato fin dalle origini un coacervo di bande dalle origini
più disparate e di discutibile valore militare, emerse in modo quasi
improvviso sulla scena della crisi iugoslava. Sostenuti e armati
dalle forze Nato come forza di ribellione alle atrocità dell’esercito
e dei paramilitari serbi contro gli albanesi, i militanti del Kla si
sono a loro volta macchiati di crimini efferati, molti dei quali
contro cittadini albanesi sommariamente etichettati come traditori o
collaborazionisti. Vari appartenenti al Kla, inoltre, si sono trovati
e sono attualmente nel mirino delle agenzie antidroga europee come
protagonisti di primo piano della rotta balcanica dell’eroina.
Il Kla è oggi parte di un gruppo di potere politico-economico-
criminale composto da 3 mega-clan divisi in 13 sottoclan minori che
controllano le principali istituzioni, nonché l’economia e la società
kosovara. Alcuni tra i capi più noti di questi clan sono accusati
dalla Corte Penale dell’Aia sui crimini commessi nella ex-Iugoslavia,
provengono dalle fila della criminalità, e in essa sono rimasti
durante e dopo la guerra contro il regime di Belgrado.
La fusione e la quasi identificazione del Kla e dei suoi capi con la
mafia kosovaro-albanese, che è la più aggressiva formazione criminale
organizzata dell’Europa odierna, fa del problema del Kosovo una delle
più serie minacce alla sicurezza del continente. E dell’Italia in
modo particolare. L’allarme documentato che Antonio Evangelista
lancia tramite la sua testimonianza non deve passare sotto silenzio.
I diplomatici e gli uomini politici del cosiddetto "Gruppo di
Contatto" – Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Russia – che
discettano assieme all’Onu intorno al futuro assetto dei rapporti tra
il Kosovo e la comunità internazionale, non sembrano tenere conto
delle dure evidenze narrate in questo volume. La questione della
criminalità organizzata, della corruzione politica e del malgoverno
dilaganti nel Kosovo, e i loro sinistri riflessi in molti paesi
europei, non è presente nell’agenda dei negoziati. È come se
l’argomento non esistesse. È superfluo sottolineare come i cittadini
europei, e quelli italiani in prima fila, pagheranno amaramente
questa omissione nei prossimi anni, quando un possibile Kosovo
indipendente regalerà l’immunità diplomatica a molti delinquenti
arrivati ai vertici della politica locale.
Chi legge questo volume e confronta i fatti in esso esposti con gli
standard di legalità vigenti nei paesi occidentali può facilmente
intravedere i contorni di un corso di azione alternativo per la
soluzione della crisi kosovara. Se non si spezza il cerchio di potere
politico-mafioso che domina quella provincia, dalla sua indipendenza
non potrà venire nulla di diverso che l’instaurazione di uno Stato
criminale vicino al centro dell’Europa.
Pino Arlacchi
Roma, 19 gennaio 2007
---
Abbiamo ricevuto e volentieri giriamo la segnalazione di questo libro
recentemente uscito, di grandissimo interesse viste tra l'altro le
funzioni istituzionali svolte dall'autore e da chi ha scritto
Prefazione ed Introduzione.
Abbiamo riportato quest'ultima integralmente: chi segue JUGOINFO può
comprendere quali, tra le opinioni espresse, dal nostro punto di
vista meritino un commento critico. Nel nostro lavoro di
documentazione continuamente argomentiamo sull'ingenuità (o peggio)
delle posizioni per la "difesa dei diritti umani" che omettono di
considerare il contesto geo-strategico e la altrettanto strategica
disinformazione ("guerra psicologica"). Stona dover leggere ancora di
"brutalità" e "sanguinosa persecuzione" cui sarebbero stati
sottoposti gli albanesi-kosovari - e con che presunzione parlarne poi
noi, che abbiamo visto Genova (luglio 2001)? - o della ipotetica
necessità di "cambiare la leadership di Belgrado" come "soluzione
pacifica del conflitto" - imponendo dall'estero un "governo amico"...
Queste posizioni pregiudiziali espresse nell'Introduzione, che
continuiamo a ritenere sbagliate, non inficiano comunque il valore di
un libro che, grazie alla serietà della documentazione e delle
testimonianze presentate, illustra bene un tema tanto scomodo da
essere raramente oggetto di discussione da parte di chi, pure,
dovrebbe occuparsene.
Sullo stesso tema segnaliamo anche "Uck: l'armata dell'ombra" di S.
Provvisionato (Gamberetti 2000).
A cura di AM per il CNJ
http://en.fondsk.ru/article.php?id=910
Strategic Cultural Foundation (Russia)
August 17, 2007
Russia’s Response to Kosovo Independence
Pyotr Iskenderov
The first Balkan visit of the “Three”, a group of
international middlemen, ended quite like it could
have been predicted.
Aleksandr Botzan-Kharchenko, a special envoy of the
Russian foreign minister for the Balkans, Frank
Wisner, a special envoy of the White House for the
problems of the Kosovo settlement, and Wolfgang
Ischinger, a German diplomat representing the EU, were
accorded the highest-level reception in Belgrade and
Prisitina.
They had talks with the leaders of Serbia and Kosovo,
presidents Boris Tadic and Fatmirko Seidiu, prime
ministers Voislav Kostunica and Agim Ceku. Much was
said about the difficulty and responsibility of the
diplomatic mission. But again no concrete results were
reported.
The gap between the positions of Belgrade and the
Albanian separatists in Kosovo did not become
narrower.
The other way about, the unwillingness of the
Albanians to agree to any concessions or compromise
became even clearer. As Mssrs. Seidu and Ceku quite
arrogantly stated, neither the issue of independence
of the province nor its – even hypothetical -
breakdown into the Serbian and Albanian parts that
Herr Ischinger made a slip of as a version, could be
on the agenda on negotiations with authorities in
Belgrade.
And Veton Surroi, the leader of the “Ora” faction of
the Kosovo Assembly and, incidentally, a member of the
Kosovo delegation at the planned negotiations, went as
far as say that the 120 days the world community has
given Pristina to continue negotiations could be put
to better use to attend to more important things, like
preparing the province for getting its independence,
working out its Constitution and adopting other laws,
approving Kosovo’s state symbols, its flag and anthem.
Given that their supporters in the West have for more
than eight years been hammering into the heads of the
Albanian separatists the idea that Kosovo should no
longer be a part of Serbia, it would have been hard to
imagine that the results of the visits would be
different.
In the end, the intention to unilaterally proclaim the
province independent has changed nothing in the
situation. Are there not enough other self-proclaimed
entities? What really counts is the response of the
international community to the hint Herr Ischinger
dropped and the nature of the conclusion to be made of
it in the world’s capitals, including Moscow.
The course of the development of the situation is such
that by the year-end Kosovo can be acknowledged
independent by not just a single country (as was the
case with Turkey acknowledging the Turkish Republic of
North Cyprus) or a little more than twenty nations
(the case of Taiwan), but by rather several dozens of
the world’s biggest states, including the United
States, Great Britain, France, the Netherlands and
Belgium.
This would radically change the very essence of the
problem of the non-acknowledged states, opening new
vistas for different versions and scenarios.
And the current supporters of the idea of Kosovo’s
independence could find themselves in a situation
whereby simultaneously with the clearly pro-Western
state, Eurasia can witness the emergence of other
full-fledged subjects that would never feel
sympathetic about either the United States, NATO or
the European Union.
It is not accidental that the western diplomats who
refer to Kosovo as “the unique case” that has nothing
to do with either the Transdniester Republic,
Abkhazia, South Ossetia or Nagorno Karabakh, are
trying to avoid detailed subject-matter discussions of
the “uniqueness” of the Kosovo situation.
The author of this article has had enough reasons to
conclude this, talking both officially and in private
with officials at the EU and NATO headquarters, as
well as with people at the UN Mission for Kosovo’s
temporary administration.
As a rule, Western officials tend to reduce the
problem to declarations of the complexity of the
historical roots of the Kosovo problem and the
impossibility for Serbs and Albanians to live side by
side in a state they share.
The conventionality of such formulations is seen with
the naked eye.
The deep historical roots are typical of all the
ethnic problems of the Balkan states including Bosnia,
Macedonia, Montenegro and Albania.
Should they be solved by way of separation of certain
territories, the Balkans would turn into an image of
Germany of the days of the feudal suzerainty.
After all is said and done, relations between Greeks
and Albanians on the eve of World War I were much
worse than those of Serbs and Kosovars, however much
the official Tirana that suggests that Serbia discard
Kosovo does not look prepared to give its territory to
adjacent Greece.
And in terms of fierceness, the ethnic civil war in
Bosnia and Herzegovina was never like any conflict in
the former Yugoslavia. Nevertheless the West did not
acknowledge the right of independence of any of the
self-proclaimed formations in that land, be it the
Croatian Republic of Herzeg-Bosna, or West Bosnia
(Tzazin Kraina) or the Republic of Serbia.
But whenever a western vis-a-vis hears anything about
the doubts of the “unique character” of the Kosovo
conflict we express in this article as well as
information about the anti-Abkhazian and anti-Ossetian
ethnic mopping-up operations the regular Georgian army
was involved in in the 1990s, they immediately get
bored and do their best to quit the conversation.
Only a few recall the role of the UN civil
administration in Kosovo.
According to some officials at the NATO headquarters
in Brussels (who insisted on hiding behind the screen
of anonymity as people unauthorized to comment on the
future status of the province), “the uniqueness” of
the Kosovo case boils down to the fact that unlike the
situation with the post-Soviet space, the UN mission
is there.
But then similar missions were in their time enacted
in Namibia and East Timor, and both territories later
turned from UN mandate territories into sovereign
states.
The transformation of the status of Namibia and East
Timor as UN wards was very real.
But not all the truth was told.
The international representation there was introduced
in the conditions of the factual occupation by the
neighbouring countries, correspondingly South Africa
and Indonesia.
The Kosovo case is totally different.
The UN mission was installed in a sovereign state, the
Federal Republic of Yugoslavia (FRY).
Yugoslavia exists no longer, but it its place at the
United Nations automatically became Serbia’s.
In other words, the goal of the international presence
was not putting an end to occupation but rendering
assistance to the normalisation of the situation in
the province, which according to Resolution 1244 dated
June 10, 1999 of the UN Security Council was
recognized as a part of the FRY.
Therefore, the UN mandate does not give anyone the
right to change Kosovo’s international legal status.
As soon as the West acknowledges Kosovo’s independence
proclaimed by the Albanian separatists, the problem
would automatically move onto a principally new plane.
The destiny of all the self-proclaimed states in the
contemporary world will be an issue on the
international agenda.
Should the United States and the EU decide to
unilaterally acknowledge Pristina, they would deprive
themselves of the right to have a say in the
settlement of the conflicts in the Transdniester
Republic, Abkhazia and South Ossetia as unbiased
middlemen.
That would give Russia the aces unbeatable by either
Javier Solana, or Condoleezza Rice, or Gordon Brown
who are so fond of delivering lectures on objectivity
and legality to Russia.
It is clear that the Albanian leaders in Kosovo think
nothing of such complicated geopolitical scenarios.
They are in a rush to legalise the black criminal
“hole” in the middle of the Balkans, laundering their
profits from drug trafficking, prostitution and trade
in “live commodities”, gaining as well a direct access
to IMF and World Bank funds.
But it appears that the West has so far failed to
calculate the strategic aftermath of its present-day
alliance with persons like Seidiu and Ceku.
The United States, NATO and EU are gradually stepping
into a trap, the keys to which will be Russia’s.
It was not Moscow that launched the mechanism of
reviewing the principles of the present-day world
order. But it can and should speak its mind in the new
situation. Not only Serbs are awaiting it. Other
nations that are tired of the impunity and hypocrisy
of the Western Pharisees are also in that number.
If for the sake of its Albanian wards the West is
ready to endanger all the world order, why should
Moscow not summon courage to protect the nations that
do not think they can do without Russia?
While Veton Surroi and his like-minded Albanian
associates instead of negotiating are openly sneering
at the international middlemen, composing the anthem
and sewing the flag of an independent Kosovo, it is
time for the Russian diplomacy to come up with its
response, the acknowledgement of independence of key
Russia’s allies in the post-Soviet space.
Source: R. Rozoff via Stop NATO - http://groups.yahoo.com/group/stopnato
Strategic Cultural Foundation (Russia)
August 17, 2007
Russia’s Response to Kosovo Independence
Pyotr Iskenderov
The first Balkan visit of the “Three”, a group of
international middlemen, ended quite like it could
have been predicted.
Aleksandr Botzan-Kharchenko, a special envoy of the
Russian foreign minister for the Balkans, Frank
Wisner, a special envoy of the White House for the
problems of the Kosovo settlement, and Wolfgang
Ischinger, a German diplomat representing the EU, were
accorded the highest-level reception in Belgrade and
Prisitina.
They had talks with the leaders of Serbia and Kosovo,
presidents Boris Tadic and Fatmirko Seidiu, prime
ministers Voislav Kostunica and Agim Ceku. Much was
said about the difficulty and responsibility of the
diplomatic mission. But again no concrete results were
reported.
The gap between the positions of Belgrade and the
Albanian separatists in Kosovo did not become
narrower.
The other way about, the unwillingness of the
Albanians to agree to any concessions or compromise
became even clearer. As Mssrs. Seidu and Ceku quite
arrogantly stated, neither the issue of independence
of the province nor its – even hypothetical -
breakdown into the Serbian and Albanian parts that
Herr Ischinger made a slip of as a version, could be
on the agenda on negotiations with authorities in
Belgrade.
And Veton Surroi, the leader of the “Ora” faction of
the Kosovo Assembly and, incidentally, a member of the
Kosovo delegation at the planned negotiations, went as
far as say that the 120 days the world community has
given Pristina to continue negotiations could be put
to better use to attend to more important things, like
preparing the province for getting its independence,
working out its Constitution and adopting other laws,
approving Kosovo’s state symbols, its flag and anthem.
Given that their supporters in the West have for more
than eight years been hammering into the heads of the
Albanian separatists the idea that Kosovo should no
longer be a part of Serbia, it would have been hard to
imagine that the results of the visits would be
different.
In the end, the intention to unilaterally proclaim the
province independent has changed nothing in the
situation. Are there not enough other self-proclaimed
entities? What really counts is the response of the
international community to the hint Herr Ischinger
dropped and the nature of the conclusion to be made of
it in the world’s capitals, including Moscow.
The course of the development of the situation is such
that by the year-end Kosovo can be acknowledged
independent by not just a single country (as was the
case with Turkey acknowledging the Turkish Republic of
North Cyprus) or a little more than twenty nations
(the case of Taiwan), but by rather several dozens of
the world’s biggest states, including the United
States, Great Britain, France, the Netherlands and
Belgium.
This would radically change the very essence of the
problem of the non-acknowledged states, opening new
vistas for different versions and scenarios.
And the current supporters of the idea of Kosovo’s
independence could find themselves in a situation
whereby simultaneously with the clearly pro-Western
state, Eurasia can witness the emergence of other
full-fledged subjects that would never feel
sympathetic about either the United States, NATO or
the European Union.
It is not accidental that the western diplomats who
refer to Kosovo as “the unique case” that has nothing
to do with either the Transdniester Republic,
Abkhazia, South Ossetia or Nagorno Karabakh, are
trying to avoid detailed subject-matter discussions of
the “uniqueness” of the Kosovo situation.
The author of this article has had enough reasons to
conclude this, talking both officially and in private
with officials at the EU and NATO headquarters, as
well as with people at the UN Mission for Kosovo’s
temporary administration.
As a rule, Western officials tend to reduce the
problem to declarations of the complexity of the
historical roots of the Kosovo problem and the
impossibility for Serbs and Albanians to live side by
side in a state they share.
The conventionality of such formulations is seen with
the naked eye.
The deep historical roots are typical of all the
ethnic problems of the Balkan states including Bosnia,
Macedonia, Montenegro and Albania.
Should they be solved by way of separation of certain
territories, the Balkans would turn into an image of
Germany of the days of the feudal suzerainty.
After all is said and done, relations between Greeks
and Albanians on the eve of World War I were much
worse than those of Serbs and Kosovars, however much
the official Tirana that suggests that Serbia discard
Kosovo does not look prepared to give its territory to
adjacent Greece.
And in terms of fierceness, the ethnic civil war in
Bosnia and Herzegovina was never like any conflict in
the former Yugoslavia. Nevertheless the West did not
acknowledge the right of independence of any of the
self-proclaimed formations in that land, be it the
Croatian Republic of Herzeg-Bosna, or West Bosnia
(Tzazin Kraina) or the Republic of Serbia.
But whenever a western vis-a-vis hears anything about
the doubts of the “unique character” of the Kosovo
conflict we express in this article as well as
information about the anti-Abkhazian and anti-Ossetian
ethnic mopping-up operations the regular Georgian army
was involved in in the 1990s, they immediately get
bored and do their best to quit the conversation.
Only a few recall the role of the UN civil
administration in Kosovo.
According to some officials at the NATO headquarters
in Brussels (who insisted on hiding behind the screen
of anonymity as people unauthorized to comment on the
future status of the province), “the uniqueness” of
the Kosovo case boils down to the fact that unlike the
situation with the post-Soviet space, the UN mission
is there.
But then similar missions were in their time enacted
in Namibia and East Timor, and both territories later
turned from UN mandate territories into sovereign
states.
The transformation of the status of Namibia and East
Timor as UN wards was very real.
But not all the truth was told.
The international representation there was introduced
in the conditions of the factual occupation by the
neighbouring countries, correspondingly South Africa
and Indonesia.
The Kosovo case is totally different.
The UN mission was installed in a sovereign state, the
Federal Republic of Yugoslavia (FRY).
Yugoslavia exists no longer, but it its place at the
United Nations automatically became Serbia’s.
In other words, the goal of the international presence
was not putting an end to occupation but rendering
assistance to the normalisation of the situation in
the province, which according to Resolution 1244 dated
June 10, 1999 of the UN Security Council was
recognized as a part of the FRY.
Therefore, the UN mandate does not give anyone the
right to change Kosovo’s international legal status.
As soon as the West acknowledges Kosovo’s independence
proclaimed by the Albanian separatists, the problem
would automatically move onto a principally new plane.
The destiny of all the self-proclaimed states in the
contemporary world will be an issue on the
international agenda.
Should the United States and the EU decide to
unilaterally acknowledge Pristina, they would deprive
themselves of the right to have a say in the
settlement of the conflicts in the Transdniester
Republic, Abkhazia and South Ossetia as unbiased
middlemen.
That would give Russia the aces unbeatable by either
Javier Solana, or Condoleezza Rice, or Gordon Brown
who are so fond of delivering lectures on objectivity
and legality to Russia.
It is clear that the Albanian leaders in Kosovo think
nothing of such complicated geopolitical scenarios.
They are in a rush to legalise the black criminal
“hole” in the middle of the Balkans, laundering their
profits from drug trafficking, prostitution and trade
in “live commodities”, gaining as well a direct access
to IMF and World Bank funds.
But it appears that the West has so far failed to
calculate the strategic aftermath of its present-day
alliance with persons like Seidiu and Ceku.
The United States, NATO and EU are gradually stepping
into a trap, the keys to which will be Russia’s.
It was not Moscow that launched the mechanism of
reviewing the principles of the present-day world
order. But it can and should speak its mind in the new
situation. Not only Serbs are awaiting it. Other
nations that are tired of the impunity and hypocrisy
of the Western Pharisees are also in that number.
If for the sake of its Albanian wards the West is
ready to endanger all the world order, why should
Moscow not summon courage to protect the nations that
do not think they can do without Russia?
While Veton Surroi and his like-minded Albanian
associates instead of negotiating are openly sneering
at the international middlemen, composing the anthem
and sewing the flag of an independent Kosovo, it is
time for the Russian diplomacy to come up with its
response, the acknowledgement of independence of key
Russia’s allies in the post-Soviet space.
Source: R. Rozoff via Stop NATO - http://groups.yahoo.com/group/stopnato
SANSONETTI, LA NOCIONI COPIA!
lunedì 13 agosto 2007 - Riprovo con scarse speranze a scrivere al
direttore di Liberazione, Piero Sansonetti. L'allarme sulla qualità
del giornalismo italiano, quello "di sinistra" soprattutto, sale
sempre di più.
Gentile direttore Piero Sansonetti,
le scrivo per domandarle se risponde al vero quanto affermato nel
blog di Annalisa Melandri riguardo l'articolo pubblicato dal suo
giornale a tema Venezuela il 10 agosto, a firma Angela Nocioni.
In particolare vorrei sapere se le risulta che l'articolo in
questione sia stato copiato di sana pianta da un articolo pubblicato
più di due settimane fa, il 27 luglio, dal quotidiano El País di
Madrid, a firma Clodovaldo Hernández e che, come afferma in maniera
convincente la Melandri, è evidente che la Nocioni non abbia neanche
letto la trascrizione del discorso del generale Baduel al quale
l'articolo si riferisce.
Le pongo infine due quesiti:
1) Se il suo giornale ha bisogno di pubblicare articoli di seconda
mano, non sarebbe più corretto indicare la fonte invece di farsi
accusare di plagio?
2) Il quotidiano El País da molti anni appoggia sistematicamente in
America latina i candidati e i governi di destra, da Manuel Rosales
in Venezuela, a Felipe Calderón in Messico, contro i candidati e i
governi di sinistra. Non trova curioso che il suo giornale lo
consideri un riferimento così importante da arrivare a copiarne linea
ed articoli?
cordialmente
Gennaro Carotenuto
http://www.gennarocarotenuto.it
(Sulla deriva del quotidiano Liberazione, da mesi scatenato in una
campagna diffamatoria contro il Venezuela e contro Cuba, si veda
anche la documentazione raccolta alle pagine:
http://it.groups.yahoo.com/group/crj-mailinglist/message/5503
http://it.groups.yahoo.com/group/crj-mailinglist/message/5504
http://it.groups.yahoo.com/group/crj-mailinglist/message/5511
http://it.groups.yahoo.com/group/crj-mailinglist/message/5534 )
lunedì 13 agosto 2007 - Riprovo con scarse speranze a scrivere al
direttore di Liberazione, Piero Sansonetti. L'allarme sulla qualità
del giornalismo italiano, quello "di sinistra" soprattutto, sale
sempre di più.
Gentile direttore Piero Sansonetti,
le scrivo per domandarle se risponde al vero quanto affermato nel
blog di Annalisa Melandri riguardo l'articolo pubblicato dal suo
giornale a tema Venezuela il 10 agosto, a firma Angela Nocioni.
In particolare vorrei sapere se le risulta che l'articolo in
questione sia stato copiato di sana pianta da un articolo pubblicato
più di due settimane fa, il 27 luglio, dal quotidiano El País di
Madrid, a firma Clodovaldo Hernández e che, come afferma in maniera
convincente la Melandri, è evidente che la Nocioni non abbia neanche
letto la trascrizione del discorso del generale Baduel al quale
l'articolo si riferisce.
Le pongo infine due quesiti:
1) Se il suo giornale ha bisogno di pubblicare articoli di seconda
mano, non sarebbe più corretto indicare la fonte invece di farsi
accusare di plagio?
2) Il quotidiano El País da molti anni appoggia sistematicamente in
America latina i candidati e i governi di destra, da Manuel Rosales
in Venezuela, a Felipe Calderón in Messico, contro i candidati e i
governi di sinistra. Non trova curioso che il suo giornale lo
consideri un riferimento così importante da arrivare a copiarne linea
ed articoli?
cordialmente
Gennaro Carotenuto
http://www.gennarocarotenuto.it
(Sulla deriva del quotidiano Liberazione, da mesi scatenato in una
campagna diffamatoria contro il Venezuela e contro Cuba, si veda
anche la documentazione raccolta alle pagine:
http://it.groups.yahoo.com/group/crj-mailinglist/message/5503
http://it.groups.yahoo.com/group/crj-mailinglist/message/5504
http://it.groups.yahoo.com/group/crj-mailinglist/message/5511
http://it.groups.yahoo.com/group/crj-mailinglist/message/5534 )
AL-QAIDA-VIDEOS MADE BY PENTAGON
www.jungewelt.de
Junge Welt, 04.08.2007 / Ausland / Seite 2
Al-Qaida-Videos made by Pentagon
US-Computerexperte weist Manipulationen an Aufnahmen nach
Von Rainer Rupp
Der amerikanische Computerexperte Neal Krawetz hat auf der »BlackHat-
Konferenz« für Computersicherheit, die bis Freitag in Las Vegas
stattfand, Beweise dafür vorgelegt, daß sogenannte Al-Qaida-Videos in
der Regel digital manipuliert wurden. Urheber sei die Firma
IntelCenter, die dem Pentagon nahesteht und für die Herausgabe der
Videobänder verantwortlich zeichnet. Mit der von Krawetz
vorgestellten neuen Technologie läßt sich zurückverfolgen, wann und
mit welcher Kamera ein digitales Bild aufgenommen wurde sowie wann
und wie es mit welchem Bildbearbeitungsprogramm geändert wurde.
Seinen Coup präsentierte Krawetz bei der Analyse eines Videos von
2006, auf dem Bin-Laden-Stellvertreter Aiman Al Zawahiri gezeigt
wird. Neben anderen Manipulationen konnte Krawetz nachweisen, daß
sowohl das As-Sa hab-Logo der angeblichen Medienabteilung von Al
Qaida als auch das Logo von IntelCenter zu genau der gleichen Zeit
dem Video beigefügt wurden.
IntelCenter ist eine Privatfirma für nachrichtendienstliche
»Dienstleistungen«, spezialisiert auf die Überwachung von Videos und
Bandaufnahmen mit »terroristischem« Hintergrund im Internet. Das
Unternehmen arbeitet dabei in engem Schulterschluß mit dem Pentagon,
sein Personal besteht vorwiegend aus ehemaligen Mitarbeitern des US-
Militärgeheimdienstes, weshalb es auch als »zivile« Frontorganisation
des Pentagon betrachtet werden kann. In der Vergangenheit trat
IntelCenter immer wieder als Mittler zwischen der angeblichen
»Medienabteilung von Al Qaida« und der westlichen Presse auf. Auch
für die Veröffentlichung des jüngsten »Bin-Laden-Videos« war
IntelCenter verantwortlich. Die Aufnahmen des Bandes stammten
allerdings aus dem Jahr 2001 und waren mit neuem Text versehen
worden. Bereits zweimal habe IntelCenter in den letzten fünf Jahren
dieses Video zurechtgeschnitten und als neue Botschaft von Bin Laden
präsentiert, belegte die US-Antikriegsgruppe »Prison Planet«, die die
Aktivitäten der Firma verfolgt, bereits im Oktober 2006.
Die Tatsache aber, daß das As-Sahab-Logo von Al Qaida zur gleichen
Zeit wie das Firmenlogo von IntelCenter dem Al-Zawahiri-Video
beigefügt wurde, beweist, daß IntelCenter die Videos zumindest
manipuliert, wenn nicht sogar produziert hat. Damit wird der alte
Verdacht bekräftigt, daß das Pentagon selbst hinter den Al-Qaida-
Drohungen steckt. Diese tauchten immer zu einem Zeitpunkt auf, an dem
sie für die Bush-Administration von höchstem Nutzen waren.
www.jungewelt.de
Junge Welt, 04.08.2007 / Ausland / Seite 2
Al-Qaida-Videos made by Pentagon
US-Computerexperte weist Manipulationen an Aufnahmen nach
Von Rainer Rupp
Der amerikanische Computerexperte Neal Krawetz hat auf der »BlackHat-
Konferenz« für Computersicherheit, die bis Freitag in Las Vegas
stattfand, Beweise dafür vorgelegt, daß sogenannte Al-Qaida-Videos in
der Regel digital manipuliert wurden. Urheber sei die Firma
IntelCenter, die dem Pentagon nahesteht und für die Herausgabe der
Videobänder verantwortlich zeichnet. Mit der von Krawetz
vorgestellten neuen Technologie läßt sich zurückverfolgen, wann und
mit welcher Kamera ein digitales Bild aufgenommen wurde sowie wann
und wie es mit welchem Bildbearbeitungsprogramm geändert wurde.
Seinen Coup präsentierte Krawetz bei der Analyse eines Videos von
2006, auf dem Bin-Laden-Stellvertreter Aiman Al Zawahiri gezeigt
wird. Neben anderen Manipulationen konnte Krawetz nachweisen, daß
sowohl das As-Sa hab-Logo der angeblichen Medienabteilung von Al
Qaida als auch das Logo von IntelCenter zu genau der gleichen Zeit
dem Video beigefügt wurden.
IntelCenter ist eine Privatfirma für nachrichtendienstliche
»Dienstleistungen«, spezialisiert auf die Überwachung von Videos und
Bandaufnahmen mit »terroristischem« Hintergrund im Internet. Das
Unternehmen arbeitet dabei in engem Schulterschluß mit dem Pentagon,
sein Personal besteht vorwiegend aus ehemaligen Mitarbeitern des US-
Militärgeheimdienstes, weshalb es auch als »zivile« Frontorganisation
des Pentagon betrachtet werden kann. In der Vergangenheit trat
IntelCenter immer wieder als Mittler zwischen der angeblichen
»Medienabteilung von Al Qaida« und der westlichen Presse auf. Auch
für die Veröffentlichung des jüngsten »Bin-Laden-Videos« war
IntelCenter verantwortlich. Die Aufnahmen des Bandes stammten
allerdings aus dem Jahr 2001 und waren mit neuem Text versehen
worden. Bereits zweimal habe IntelCenter in den letzten fünf Jahren
dieses Video zurechtgeschnitten und als neue Botschaft von Bin Laden
präsentiert, belegte die US-Antikriegsgruppe »Prison Planet«, die die
Aktivitäten der Firma verfolgt, bereits im Oktober 2006.
Die Tatsache aber, daß das As-Sahab-Logo von Al Qaida zur gleichen
Zeit wie das Firmenlogo von IntelCenter dem Al-Zawahiri-Video
beigefügt wurde, beweist, daß IntelCenter die Videos zumindest
manipuliert, wenn nicht sogar produziert hat. Damit wird der alte
Verdacht bekräftigt, daß das Pentagon selbst hinter den Al-Qaida-
Drohungen steckt. Diese tauchten immer zu einem Zeitpunkt auf, an dem
sie für die Bush-Administration von höchstem Nutzen waren.