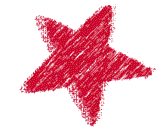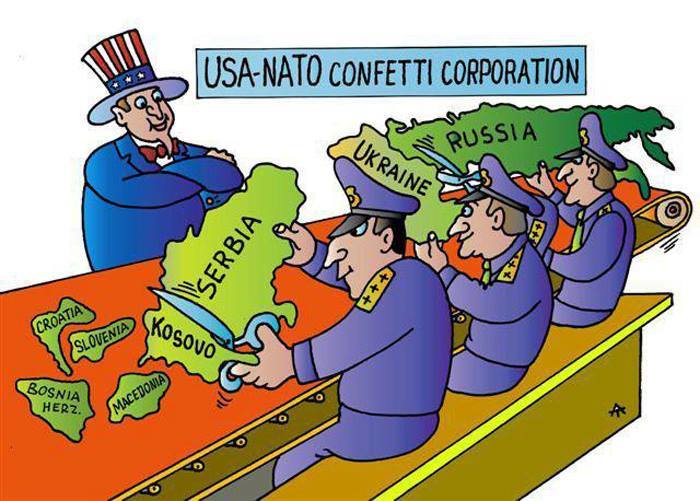Informazione
2007:11:32&log=invites
L’Union européenne survivra-t-elle au Kosovo ?
Georges Berghezan
Face à la menace de proclamation unilatérale de l’indépendance par
les autorités albanaises du Kosovo, l’unité de façade de l’Union
européenne est en train de s’effondrer. Entre l’indépendance promise
par Washington et les menaces de veto russe, Bruxelles n’a pas trouvé
de cap et son engagement dans les Balkans est remis en question.
Bulletin trimestriel du Comité de surveillance OTAN,
Numéro 27, juillet-septembre 2007
Alors que certains n’y voyaient qu’une simple formalité – une pilule
amère, une de plus, à faire avaler par la Serbie –, le processus de
détermination du statut futur du Kosovo s’est enlisé au plus haut
niveau. Après des discussions infructueuses entre Belgrade et
Pristina, l’émissaire de l’ONU Martti Ahtisaari a présenté en mars
dernier au Conseil de sécurité un rapport prônant l’« indépendance
supervisée » de la province serbe, une position qu’il avait
d’ailleurs exprimée avant même que les « négociations » ne débutent.
Le Kosovo serait doté des attributs d’un Etat indépendant, mais
continuerait à être occupé par des troupes de l’OTAN, tandis que
l’actuelle mission de l’ONU serait remplacée par une administration
de l’Union européenne qui exercerait des « fonctions d’encadrement,
de surveillance et de conseil » dans les matières civiles et
policières. Après six projets de résolution, tous rejetés par la
Russie qui défend le principe d’une solution agréée par toutes les
parties – et non imposée à Belgrade comme dans le plan Ahtisaari –,
le Conseil de sécurité a délégué la suite du processus à une troïka,
composée des Etats-Unis, de la Russie et de l’UE, chargée de relancer
d’« ultimes » négociations entre Belgrade et Pristina et de rendre un
rapport un Secrétaire général de l’ONU pour le 10 décembre.
Alors que Serbes et Albanais n’ont toujours pas repris leurs
pourparlers1 et qu’aucun signe n’indique le moindre assouplissement
de leurs positions – tout sauf l’indépendance pour les uns, rien
d’autre que l’indépendance pour les autres –, les leaders albanais du
Kosovo ont annoncé qu’ils proclameraient l’indépendance du territoire
avant la fin de l’année, avec ou sans la caution du Conseil de
sécurité. Récusée par l’UE et la Russie, la menace a reçu des
encouragements explicites de Washington où un représentant du
Département d’Etat a déclaré le 8 septembre que les Etats-Unis
reconnaîtraient l’indépendance du Kosovo. Même si, depuis de nombreux
mois, les responsables de Washington se sont faits les hérauts de
l’indépendance kosovare, jamais ils n’avaient encore aussi clairement
annoncé qu’ils étaient prêts à court-circuiter le Conseil de sécurité.
Le cauchemar de Solana
Une proclamation unilatérale d’indépendance suivie de sa
reconnaissance par les Etats-Unis provoquerait de grosses fissures,
non seulement au Conseil de sécurité, où plusieurs de 15 membres (la
Chine, qui dispose aussi du droit de veto, mais également l’Indonésie
ou l’Afrique du Sud) partagent l’opposition russe à une indépendance
du Kosovo imposée à la Serbie, mais aussi au sein de l’UE. Malgré les
craintes d’une « contagion sécessionniste », une certaine unanimité
prévalait pour accepter une indépendance reconnue « dans les règles
», c’est-à-dire avec l’aval du Conseil de sécurité de l’ONU. Comme
cette éventualité devient de plus en plus improbable, la question
d’une reconnaissance d’une indépendance autoproclamée divise
profondément le club européen, ainsi que celle de l’envoi de la
mission civilo-policière devant remplacer celle de l’ONU, en train de
plier bagages.
Lors d’un sommet les 7 et 8 septembre à Viana Do Castelo (Portugal),
les 27 ministres des Affaires étrangères n’ont pu accorder leurs
violons. Si la Grande-Bretagne et, singulièrement, la France se
rangent sur la position états-unienne, plusieurs pays ont exprimé de
nettes réserves ou leur opposition à une reconnaissance
d’indépendance sans accord du Conseil de sécurité. Parmi ces
derniers, on trouve l’Espagne, la Slovaquie, la Grèce, Chypre, la
Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie. Davantage que l’attachement aux
principes du droit international ou le désir de ne pas s’aliéner
durablement la Serbie, c’est surtout la crainte d’un précédent qui
motive la plupart de ces Etats, confrontés aux revendications
indépendantistes de leurs propres minorités. Et même au-delà de ces
nations, dans divers milieux européens, grandit la crainte que les «
indépendances autoproclamées » deviennent la règle, alors que, du
Pays Basque au Nagorny Karabakh, le cas du Kosovo est suivi avec
intérêt. Mais, au cabinet de notre ministre belge De Gucht, c’est
l’allégeance au grand George qui semble prévaloir, bien que
l’actuelle « crise institutionnelle » belge devrait plutôt l’inciter
à la réflexion.
Si une position commune devait s’imposer, celle de l’Allemagne serait
déterminante. Berlin a eu, depuis plus de quinze ans, une influence
capitale sur les événements d’ex-Yougoslavie. Rappelons la
reconnaissance unilatérale, avec le Vatican, de l’indépendance de la
Croatie à la fin 1991, forçant le reste de la Communauté européenne,
puis les Etats-Unis, à la suivre sur un chemin qui précipita quelques
mois plus tard la Bosnie-Herzégovine dans une guerre sanglante. Dès
la paix revenue dans ce pays, les services de renseignement allemands
se lançaient dans un programme d’armement et d’entraînement des
indépendantistes kosovars de l’Armée de libération du Kosovo. Depuis,
aux yeux des Albanais, l’aura américaine a bien supplanté l’attrait
exercé par la patrie du Deutsche Mark, mais l’Allemagne n’en garde
pas moins des positions clé au Kosovo : avec 2.500 soldats, son
contingent est le principal au sein de la KFOR, la force sous
commandement OTAN déployée au Kosovo, et, surtout, le représentant
européen au sein de la troïka chargée de la reprise des pourparlers
serbo-albanais n’est autre que le diplomate allemand Wolfgang Ischinger.
Le tabou de la partition
Or, en 2007, l’Allemagne ne semble plus vouloir jouer le rôle de
boutefeu des Balkans, observant une position plutôt réservée dans les
déchirements euro-atlantiques et intra-européens. Certains attribuent
cette prudence à une autre caractéristique de la politique allemande
de ces dernières décennies, la nécessité de ménager un voisin russe
qui n’est plus disposé à être le laissé-pour-compte des arrangements
entre grandes puissances dans les Balkans. Aussi, tout en maintenant
d’étroits liens avec les Etats-Unis, Berlin ne peut ignorer sa
dépendance envers les approvisionnements énergétiques russes et doit
donc manifester un minimum de compréhension envers la position serbe.
Ischinger a provoqué une mini-tempête en déclarant, en août, qu’une
partition du Kosovo – le nord (majoritairement serbe) demeurant en
Serbie, le reste devenant indépendant – n’était pas exclue par la
troïka. Ecartée d’emblée avant le début des négociations2, cette
option a été à nouveau rejetée avec véhémence par Washington et le «
gouvernement intérimaire » de Pristina. Par contre, la diplomatie
russe emboîtait le pas à la proposition d’Ischinger, alors que
Belgrade répétait son opposition à toute amputation de la Serbie, que
ce soit de l’ensemble ou d’une partie de sa province du Kosovo.
Il n’empêche que la partition du territoire, bien qu’elle
entraînerait le sacrifice des enclaves serbes (et de nombre de chefs
d’œuvre de l’architecture religieuse byzantine qu’elles recèlent)
dans la partie majoritairement albanaise, pourrait être, dans la
situation actuelle, la seule possibilité de compromis entre Belgrade
et Pristina. Une telle voie entraînerait bien des marchandages et des
revendications. Ainsi, les Albanais kosovars exigeraient, en
compensation, le rattachement de la vallée de Presevo, une région de
Serbie centrale adjacente au Kosovo et majoritairement albanaise. En
Macédoine, alors que les réformes des dernières années ont
considérablement accru la décentralisation et les droits des Albanais
(un tiers de la population, concentrée dans le nord-ouest), certains
n’hésiteraient pas à demander un scénario similaire à celui du
Kosovo, soit la création d’un troisième Etat albanais dans les
Balkans. Ce qui rendrait beaucoup plus crédible le projet de « Grande
Albanie », voire d’autres recompositions sur base ethnique dans la
région ou au-delà.
Cependant, le scénario d’une partition du Kosovo, pour improbable
qu’il soit, serait moins risqué pour la stabilité de l’Europe et du
monde que celui de l’indépendance. Pour une simple raison : une
solution acceptée par les Etats et les peuples directement concernés
est plus durable qu’une solution imposée par les grandes puissances,
même avec l’assentiment de l’ONU. Et ensuite parce que, si le
principe d’une solution convenant aux deux parties était retenu, cela
devrait freiner les ardeurs sécessionnistes de bon nombre de
candidats à l’indépendance et favoriser la recherche de compromis.
Empêtrés, divisés et saisis de doutes, les leaders occidentaux sont
en train de payer leurs erreurs au Kosovo. D’une part, ils ont laissé
le territoire devenir un haut lieu du crime organisé et du nettoyage
ethnique, un contre-exemple parfait de la « bonne gouvernance » et
des « droits de l’homme » qu’ils prêchent aux quatre coins du globe.
D’autre part, ils ont largement sous-estimé à la fois l’opiniâtreté
russe, aiguillonnée par le bouclier antimissile des Etats-Unis et
l’élargissement continu de l’OTAN, et l’attachement des Serbes au
Kosovo, berceau de leur histoire. Les promesses d’adhésion, «
carottes » offertes par l’UE et l’OTAN, contre le Kosovo, n’ont pas
eu les effets escomptés. Huit ans après les bombardements,
l’organisation atlantique est plus impopulaire que jamais à Belgrade.
Quant à l’adhésion à l’UE, même le très pro-occidental président
Tadic a assuré qu’elle ne servirait pas de lot de consolation pour la
perte du Kosovo. Décidément, les mirages de la mondialisation ont
perdu beaucoup de leurs vertus anesthésiantes…
Georges Berghezan
1 La nouvelle série de négociations devait commencer le 28 septembre
à New York, dans le cadre de l’Assemblée générale de l’ONU
2 Les 3 « ni » d’Ahtisaari : ni retour à la situation d’avant 1999,
ni rattachement (à un autre pays), ni partition
------------------------------------------------------------------------
L’opposition à l’OTAN grandit à Belgrade
Comme dans la plupart des pays d’Europe centrale et orientale, le
sentiment prévalait en Serbie que l’adhésion à l’OTAN représentait
une étape de l’« intégration euro-atlantique », un préalable d’une
adhésion à l’UE, donc un pas vers la relative prospérité dont jouit
l’ouest du continent. Evidemment, la Serbie a la particularité
d’avoir subi, pendant près de dix ans, de sévères sanctions
économiques de la part de l’Occident et d’avoir été bombardée pendant
78 jours par l’aviation de l’OTAN. Ces souvenirs sont encore vivaces
dans la population.
Néanmoins, depuis le renversement de Milosevic en 2000, les divers
gouvernements successifs ont tous ardemment défendu l’adhésion à
l’OTAN et à l’UE auprès de leur population. Dans ce but, ils ont cédé
à la plupart des exigences de l’Occident, privatisant de larges pans
de leur économie et livrant au Tribunal de La Haye la plupart des
inculpés pour crimes de guerre réfugiés en Serbie. En récompense, le
pays a accédé fin 2006 au Partenariat pour la Paix, programme de
coopération militaire considéré comme une antichambre de l’OTAN. Avec
une profonde restructuration de son armée en cours et le
développement d’une coopération étroite avec les Etats-Unis (en
particulier avec la Garde nationale d’Ohio), la Serbie semblait bien
placée pour une adhésion accélérée à l’OTAN. Seul caillou dans la
chaussure, le cas du général Mladic, toujours en liberté, peut-être
en Serbie.
Notons qu’un processus similaire est en cours dans les relations avec
l’UE. Après une année d’interruption pour cause de mauvaise
coopération avec le Tribunal de La Haye, Bruxelles et Belgrade ont
repris leurs pourparlers et sont sur le point de conclure un Accord
de stabilisation et d’association, préalable à une candidature
officielle à l’Union. Entre-temps, Carla Del Ponte, procureure du
Tribunal de La Haye, avait remis des rapports – enfin positifs – sur
la coopération serbe avec son institution. Il est clair que tout cela
visait d’abord à amadouer Belgrade et à l’amener à adoucir son refus
de concéder l’indépendance au Kosovo. En vain, car la position serbe
ne s’est pas infléchie et semble même plus ferme que jamais.
En outre, l’objectif de l’adhésion à l’OTAN ne fait plus l’unanimité
dans la coalition gouvernementale. A partir du mois d’août, les
ministres du Parti démocratique serbe (DSS), puis le Premier ministre
Kostunica, ont fortement critiqué le soutien de l’OTAN au plan
Ahtisaari et, en particulier, l’annexe 11 du plan prévoyant
privilèges et immunité aux troupes de l’OTAN. Certains ministres y
ont vu la volonté de créer, autour de la méga-base de Camp Bondsteel,
un « Etat-OTAN », un « Etat fantoche militarisé ». Les bombardements
« illégaux » et « impitoyables » de 1999 ont été rappelés et,
finalement, le DSS décidait le 15 septembre de s’opposer à l’adhésion
du pays à l’OTAN et se contenter du Partenariat pour la Paix. Dix
jours plus tôt, le gouvernement avait retiré l’adhésion à
l’organisation euro-atlantique de la liste de ses objectifs dans le
cadre de ce programme. Un geste qui n’a pas la portée de celui de De
Gaulle en 1966, mais qui n’en demeure pas moins une première parmi
les Etats candidats.
Les deux autres partis gouvernementaux, nettement plus pro-
occidentaux, ont dénoncé la « rhétorique anti-OTAN » du DSS et
certaines rumeurs évoquent une coalition de rechange entre ce dernier
et la principale force de l’opposition, le Parti radical (SRS), dont
le chef croupit à La Haye, accusé d’avoir organisé des milices
pendant les guerres de Croatie et de Bosnie.
Si les motivations politiciennes sont loin d’être absentes et si
l’annexe 11 apparaît comme un prétexte (le DSS a commencé à protester
près de cinq mois après la publication du rapport d’Ahtisaari qui,
concernant la force de l’OTAN, ne faisait que confirmer les
conditions en vigueur depuis le début de l’occupation),
l’impopularité de l’OTAN est plus perceptible que jamais en Serbie.
Pour expliquer le choix de son parti, Kostunica a souligné
l’importance de la neutralité militaire et assuré que son pays ne
participerait jamais aux aventures de l’OTAN en Irak et Afghanistan.
Mais, avant tout, c’est le rôle néfaste joué par cette organisation
au Kosovo qui a été rappelé. Après tant d’humiliations, une telle
réaction peut apparaître bien naturelle. Mais elle laisse aussi
présager que la « bataille du Kosovo » est loin d’être terminée et
qu’elle marquera, quoi qu’il advienne, de profondes empreintes sur
l’avenir de l’Europe.
Georges Berghezan
«Seminò coscienza nel mondo»: Fidel ricorda il Che
di Fidel Castro Ruz *
su Il Manifesto del 09/10/2007
Il leader cubano celebra sul Granma «l'eccezionale combattente caduto un 8 ottobre di 40 anni fa», il «messaggero dell' internazionalismo militante» che «combatté con noi e per noi»
Mi fermo un istante nella mia lotta quotidiana per chinare la testa, con rispetto e gratitudine, davanti all'eccezionale combattente che cadde un 8 ottobre di 40 anni fa. Per l'esempio che ci ha lasciato con la sua Columna invasora che attraversò i terreni pantanosi a sud delle antiche province di Oriente e Camagüey inseguito dalle forze nemiche, liberatore della città di Santa Clara, creatore del lavoro volontario, protagonista di onorevoli missioni politiche all'estero, messaggero dell' internazionalismo militante nell'est del Congo e in Bolivia, seminatore di coscienze nella nostra America e nel mondo. Lo ringrazio per quello che cercò di fare e non poté fare nel suo paese natale, perché fu come un fiore strappato prematuramente dal suo stelo.
Ci ha lasciato il suo stile inconfondibile di scrivere, con eleganza, brevità e sincerità, ogni dettaglio di quello che gli passava per la mente. Era un predestinato, ma non lo sapeva.
Combatté con noi e per noi.
Ieri si è compiuto il trentunesimo anniversario della strage dei passeggeri e del personale dell'equipaggio dell'aereo cubano fatto saltare in pieno volo ed entriamo nel decimo anniversario della crudele e ingiusta incarcerazione dei cinque eroi anti-terroristi cubani. Anche davanti a tutti loro chiniamo la testa. Con grande emozione ho visto e ascoltato in televisione l'atto commemorativo.
*Dal Granma del 7 ottobre
---
Qualsiasi cosa cerchi di scrivere *
di Italo Calvino
su Granma del 25/09/2007
Pensando a Che Guevara
Qualsiasi cosa io cerchi di scrivere per esprimere la mia ammirazione per Ernesto Che Guevara, per come visse e per come morì, mi pare fuori tono. Sento la sua risata che mi risponde, piena d'ironia e di commiserazione. Io sono qui, seduto nel mio studio, tra i miei libri, nella finta pace e finta prosperità dell'Europa, dedico un breve intervallo del mio lavoro a scrivere, senza alcun rischio, d'un uomo che ha voluto assumersi tutti i rischi, che non ha accettato la finzione d'una pace provvisoria, un uomo che chiedeva a sè e agli altri il massimo spirito di sacrificio, convinto che ogni risparmio di sacrifici oggi si pagherà domani con una somma di sacrifici ancor maggiori.
Guevara è per noi questo richiamo alla gravità assoluta di tutto ciò che riguarda la rivoluzione e l'avvenire del mondo, questa critica radicale a ogni gesto che serva soltanto a mettere a posto le nostre coscienze.
In questo senso egli resterà al centro delle nostre discussioni e dei nostri pensieri, così ieri da vivo come oggi da morto. E' una presenza che non chiede a noi né consensi superficiali né atti di omaggio formali; essi equivarrebbero a misconoscere, a minimizzare l'estremo rigore della sua lezione. La "linea del Che" esige molto dagli uomini; esige molto sia come metodo di lotta sia come prospettiva della società che deve nascere dalla lotta. Di fronte a tanta coerenza e coraggio nel portare alle ultime conseguenze un pensiero e una vita, mostriamoci innanzitutto modesti e sinceri, coscienti di quello che la "linea del Che" vuol dire -una trasformazione radicale non solo della società ma della "natura umana", a cominciare da noi stessi- e coscienti di che cosa ci separa dal metterla in pratica.
La discussione di Guevara con tutti quelli che lo avvicinarono, la lunga discussione che per la sua non lunga vita (discussione-azione, discussione senz'abbandonare mai il fucile), non sarà interrotta dalla morte, continuerà ad allargarsi. Anche per un interlocutore occasionale e sconosciuto (come potevo esser io, in un gruppo d'invitati, un pomeriggio del 1964, nel suo ufficio del Ministero dell'Industria) il suo incontro non poteva restare un episodio marginale. Le discussioni che contano sono quelle che continuano poi silenziosamente, nel pensiero. Nella mia mente la discussione col Che è continuata per tutti questi anni, e più il tempo passava più lui aveva ragione.
Anche adesso, morendo nel mettere in moto una lotta che non si fermerà, egli continua ad avere sempre ragione.
* ottobre 1967
http://www.esserecomunisti.it/index.aspx?m=77&f=2&IDArticolo=18798
---
Hasta siempre, Comandante!
Aprendimos a quererte,
Desde la histórica altura,
Donde el sol de tu bravura
Le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara,
La entrañable transparencia
De tu querida presencia,
Comandante Che Guevara.
Tu mano gloriosa y fuerte
Sobre la historia dispara,
Cuando todo Santa Clara
Se despierta para verte.
Aquí se queda la clara,
La entrañable transparencia
De tu querida presencia,
Comandante Che Guevara.
Vienes quemando la brisa
Con soles de primavera
Para plantar la bandera
Con la luz de tu sonrisa
Aquí se queda la clara,
La entrañable transparencia
De tu querida presencia,
Comandante Che Guevara.
Tu amor revolucionario
Te conduce a nueva empresa,
Donde esperan la firmeza
De tu brazo libertario.
Aquí se queda la clara,
La entrañable transparencia
De tu querida presencia,
Comandante Che Guevara.
Seguiremos adelante
Como junto a tí seguimos
Y con Fidel te decimos :
"¡hasta siempre comandante!"
Aquí se queda la clara,
La entrañable transparencia
De tu querida presencia,
Comandante Che Guevara.
(Carlos Puebla)
traduzione in italiano:
Arrivederci, Comandante!
Abbiamo imparato ad amarti
dalla storica altura
dove il sole del tuo coraggio
ha messo limite alla morte
Rimane qui la chiara,
l'affettuosa trasparenza
della tua amata presenza
Comandante Che Guevara.
La tua mano gloriosa e forte
spara sulla storia
quando tutta Santa Clara
si sveglia per vederti
Qui rimane la chiara,
l'affettuosa trasparenza
della tua amata presenza
Comandante Che Guevara.
Vieni bruciando la brina
con soli di primavera
per piantare la bandiera
con la luce del tuo sorriso
Qui rimane la chiara,
l'affettuosa trasparenza
della tua amata presenza
Comandante Che Guevara.
Il tuo amore rivoluzonario
riconduce a nuove imprese
dove aspettano la fermezza
del tuo braccio libertario
Qui rimane la chiara,
l'affettuosa trasparenza
della tua amata presenza
Comandante Che Guevara.
Andremo avanti
continueremo come insieme a te
e con Fidel ti diciamo
"Arrivederci, Comandante!"
Rimane qui la chiara,
l'affettuosa trasparenza
della tua amata presenza
Comandante Che Guevara.
La sconfinata e colpevole ignoranza di Walter Veltroni sulle
questioni internazionali si è palesata una volta di più nel corso di
un intervento pubblico tenuto pochi giorni orsono.
"Tra il 1991 e il 1992 - ha spiegato Veltroni - le speranze nate con
la caduta del muro di Berlino si sgretolarono: nel 1994 con il
genocidio in Ruanda, poi con i settemila musulmani massacrati a
Srebrenica e piu' tardi i Balcani."
Parlando di fronte alla lobby di Diplomatia, club esclusivo che
riunisce esponenti del mondo dell'imprenditoria e del ceto politico
attorno alle tematiche dei rapporti internazionali, Veltroni ha
nuovamente rivendicato la aggressione armata contro i popoli jugoslavi:
"In Kosovo abbiamo fatto nostro il principio che se uno stato viola i
diritti umani cio' non puo avvenire nell'indifferenza della comunita'
internazionale".
Se potesse, Veltroni tornerebbe a lanciare un "adeguato"
bombardamento "umanitario" anche in Myanmar: "un paese nel quale anni
ininterrotti di dittatura militare e la repressione delle
mobilitazioni di questi giorni hanno trovato una posizione della
comunita' internazionale assolutamente e totalmente inadeguata".
Se solo ci fossero grandi petrolchimici anche nei pressi di Rangoon,
ah! Che goduria che sarebbe, per Walter Veltroni!
(a cura di Italo Slavo. Fonte: AGI, 8 ottobre 2007)
http://espresso.repubblica.it/dettaglio/Operazione-sciame-di-fuoco/1796788
Operazione sciame di fuoco
L'Italia combatte già
“Euroil. La borsa iraniana del petrolio e il declino dell’impero americano” di Paolo G. Conti e Elido Fazi (Fazi Editore)
Capire i meccanismi economici è capire scelte politiche, azioni di governo, manovre all’apparenza non chiare, notizie riportate dai media che, se analizzati sotto la lente delle relazioni economiche e valutarie, si contestualizzano e spiegano parecchie cose, creando collegamenti tra fatti che all’apparenza potrebbero non essere così vicini.
Che l’ostilità – per adesso solo diplomatica – degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran non avesse niente a che vedere con il nucleare lo sapevamo già, senza bisogno che Kissinger lo confermasse. Ma il fatto è che non ha a che fare solo con il petrolio. C’è un altro elemento – che al greggio è certamente legato – che gli U.S.A. hanno intenzione di difendere con ogni mezzo: il dollaro. Questo è ciò che ci spiega Euroil, libro appena uscito a firma di Paolo G. Conti ed Elido Fazi, e lo fa con molta chiarezza, anche per chi è digiuno di economia, riuscendo a sintetizzare i fatti della storia economica mondiale, gli accadimenti degli ultimi anni che ne stanno cambiando gli equilibri, e le prospettive future per uscirne senza arrivare al tracollo economico (e non solo) del pianeta.
Due le condizioni che minano la supremazia del dollaro nell’economia mondiale: la crescita dell’euro che si presenta sempre più stabile e forte e la diminuzione delle fonti energetiche non rinnovabili. Molti Paesi stanno passando parte delle loro riserve valutarie dal biglietto verde alla moneta europea, causando preoccupazione a Washington. Non solo. L’euro si sta affermando nel dibattito tra i membri dell’OPEC come possibile valuta alternativa per il petrolio. Questi due elementi insieme contribuiscono a rendere meno stabile l’economia americana, in posizione privilegiata dagli accordi di Bretton Woods in avanti, ma che presenta il disavanzo della bilancia dei pagamenti e il debito estero più alti del mondo.
In più c’è un altro fattore, di cui poco si è sentito sui media: l’Iran sta portando avanti un progetto per realizzare una borsa del petrolio sull’Isola di Kish nel Golfo Persico, in cui utilizzare l’euro come valuta, che si andrebbe ad aggiungere alle due già esistenti (New York e Londra): un colpo politico ed economico al cuore dell’impero americano, che non potrà rimanere indifferente.
Tanti gli altri elementi che entrano in questo quadro, a partire da Cina e Russia, e gli autori del libro prospettano un unico scenario per un futuro in cui dollaro e petrolio non saranno difesi solo dagli eserciti: un nuovo ordine monetario internazionale, gestito da organizzazioni realmente indipendenti (Fondo monetario internazionale e Banca mondiale sono ormai parte della politica statunitense, e scambiano in dollari) che si basi su una valuta capace di maggiore sicurezza, democrazia e collegialità rispetto ai bigliettoni verdi; spinta al rinnovamento che potrebbe giungere probabilmente solo dall’Europa. Ma gli Stati Uniti saranno disposti ad abdicare alla supremazia economica senza rinunciare a combattere?
Euroil. La borsa iraniana del petrolio e il declino dell’impero americano
Paolo G. Conti, Elido Fazi
Fazi Editore
Pag. 154, Euro 14