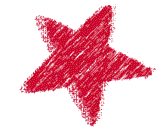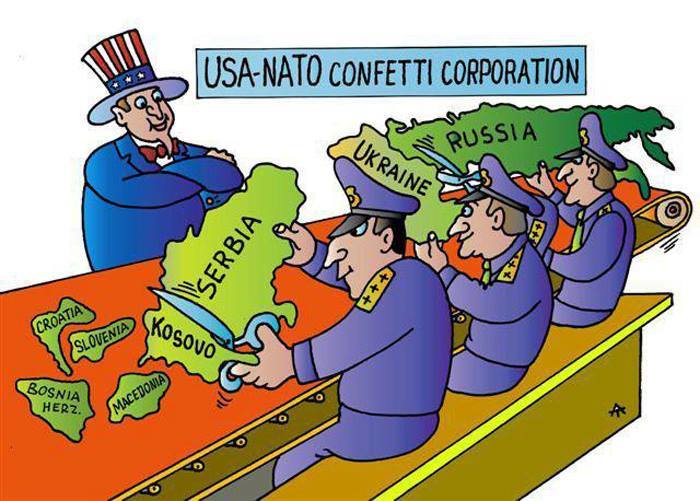Informazione
Lunedì 13 febbraio ore 21
Piazza Castello, Salone Tartara nel Mercato Pavia
Casale Monferrato (AL)
conferenza di Giacomo Scotti,
giornalista, scrittore, vice presidente dell'Unione Italiani
dell'Istria e di Fiume:
"Venezia Giulia, Istria e Dalmazia
durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale"
Martedì 14 febbraio
il giornalista terrà due incontri per gli studenti negli Istituti
Superiori.
Organizzano:
Città di Casale Monterrato,
Consulta per la Pace, la Giustizia e la Cooperazione Internazionale,
A.N.P.I.
Piazza Castello, Salone Tartara nel Mercato Pavia
Casale Monferrato (AL)
conferenza di Giacomo Scotti,
giornalista, scrittore, vice presidente dell'Unione Italiani
dell'Istria e di Fiume:
"Venezia Giulia, Istria e Dalmazia
durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale"
Martedì 14 febbraio
il giornalista terrà due incontri per gli studenti negli Istituti
Superiori.
Organizzano:
Città di Casale Monterrato,
Consulta per la Pace, la Giustizia e la Cooperazione Internazionale,
A.N.P.I.
ALTRI TEMPI ... ALTRI UOMINI ... ALTRI PRESIDENTI
Fonte: resistenza_partigiana @ yahoogroups.com
---
UN UOMO DELLA RESISTENZA
Scrivo queste righe il giorno 10 febbraio 2006,
il cosiddetto " Giorno del Ricordo ", istituito nell´anno 2005 dal
governo di centro destra per accontentare le frange più estremiste
delle organizzazioni degli esuli e per strumentalizzare la tragedia
delle foibe. Sulle foibe iniziarono a raccontare le loro menzogne i
nazifascisti già nel 1944, mentre per gli esuli istriani tutto ebbe
inizio con il maledetto esodo di Pola del 1947, una fuga generale
insensata provocata dalla propaganda anticomunista che già aveva
incominciato ad imperversare dopo l´inizio della cosiddetta " Guerra
Fredda ". Da parte mia io preferisco ricordare altre cose, come la
visita a Trieste di uno degli uomini migliori che l´Italia abbia mai
avuto come Presidente della Repubblica : l´onorevole Sandro Pertini.
E´ la primavera del 1983. Viene annunciata a Trieste la visita del
Presidente della Repubblica. Già alla mattina presto la piazza Unità è
piena di gente. Oltre agli striscioni portati dagli operai delle
fabbriche e le bandiere sindacali, si notano numerosissimi simboli
della Lista per Trieste, formazione politica allora fortissima ed
alcuni manifesti con scritte di contestazione. In particolare un
striscione nero portato da alcune donne colpisce la mia attenzione :
vi è scritto sopra, in lettere verdastre : " Presidente Pertini,
ricordati
delle foibe ! " Pertini arriva con l´elicottero sul Molo Audace, si
reca in Prefettura acclamato dalla folla e poi ritorna a fare un giro
della piazza a piedi. La gente, trattenuta dalle transenne lo applaude
e mille mani si tendono per toccarlo. I rappresentanti della Lista del
Melòn se ne stanno in cupo silenzio. Io sono in prima fila. Mi passa
davanti quest´ uomo magro, quasi rachitico, più piccolo di me che già
non sono un gigante e quando gli tendo la mano allunga un braccio
sottile come un fuscello e me la stringe con forza insospettata. Non me
la sono lavata per un mese. Poi il Presidente si reca sul palco
allestito davanti al Municipio dove si trova il sindaco Richetti
assieme alle massime autorità. Succede un po´ di confusione. Sembra che
le " vedove della Lista ", quelle con lo striscione sulle foibe,
vogliano parlare con lui. C´ è anche pronta una delegazione della "
Lista per Trieste ". Qualcuno comincia a fischiare ed a urlare
improperi. A questo punto Pertini dice all´orecchio del sindaco
Richetti qualcosa che nessuno sente, poi rimane zitto. Il sindaco di
Trieste dice poche parole di circostanza, e la manifestazione si
scioglie senza che il Presidente della Repubblica in visita alla città
di Trieste abbia detto una sola parola. Poi i giornali scrissero che
il protocollo della visita non prevedeva che il Presidente della
Repubblica facesse alcun discorso in piazza a Trieste, ma i bene
informati fecero sapere in giro che le parole che Pertini aveva
sussurrato nell´orecchio del sindaco Richetti erano : " Io con questi
MATTI non ci parlo ". Successivamente nella stessa giornata Sandro
Pertini si recò in visita ai cantieri navali di Monfalcone e davanti
agli operai metalmeccanici riuniti in assemblea nella mensa aziendale
fece un comizio memorabile, tanto che in seguito fu portato in giro in
trionfo dagli stessi operai, alla faccia del protocollo e dei
regolamenti, e con grande preoccupazione delle sue guardie del corpo. L´
indomani, come al solito, iniziò una lunga serie di polemiche sulle
pagine della rubrica " Segnalazioni " del quotidiano " Il Piccolo " di
Trieste. Ma questa è un´ altra storia.
Gianni Ursini
---
dal sito http://www.quirinale.it
INTERVENTO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
CARLO AZEGLIO CIAMPI
IN OCCASIONE DEL "GIORNO DEL RICORDO".
Palazzo del Quirinale, 8 febbraio 2006
Signor Presidente della Corte Costituzionale,
Signor Vice Presidente del Senato della Repubblica,
Signor Vice Presidente del Consiglio dei Ministri,
Signori Ministri,
Onorevoli Parlamentari,
Autorità,
Signore e Signori,
sono oggi qui con voi, per onorare le finalità della Legge che, con
decisione pressoché unanime del Parlamento, ha istituito il "Giorno
del Ricordo". Le cito:
"conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e
di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli
istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più
complessa vicenda del confine orientale".
E' giusto che agli anni del silenzio faccia seguito la solenne
affermazione del ricordo.
La celebrazione di quest'anno si arricchisce di un momento di grande
significato: la prima consegna a congiunti delle vittime di una
medaglia dedicata a quanti perirono in modo atroce, nelle foibe, al
termine della seconda guerra mondiale.
Il riconoscimento del supplizio patito è un atto di giustizia nei
confronti di ognuna di quelle vittime, restituisce le loro esistenze
alla realtà presente perché le custodisca nella pienezza del loro
valore, come individui e come cittadini italiani.
L'evocazione delle loro sofferenze, e del dolore di quanti si videro
costretti ad allontanarsi per sempre dalle loro case in Istria, nel
Quarnaro e nella Dalmazia, ci unisce oggi nel rispetto e nella
meditazione.
Questo nostro incontro non ha valore puramente simbolico; testimonia
la presa di coscienza dell' intera comunità nazionale.
L'Italia non può e non vuole dimenticare: non perché ci anima il
risentimento, ma perché vogliamo che le tragedie del passato non si
ripetano in futuro.
La responsabilità che avvertiamo nei confronti delle giovani
generazioni ci impone di tramandare loro la consapevolezza di
avvenimenti che costituiscono parte integrante della storia della
nostra patria.
La memoria ci aiuta a guardare al passato con interezza di
sentimenti, a riconoscerci nella nostra identità, a radicarci nei
suoi valori fondanti per costruire un futuro nuovo e migliore.
L'odio e la pulizia etnica sono stati l'abominevole corollario
dell'Europa tragica del Novecento, squassata da una lotta senza
quartiere fra nazionalismi esasperati.
La Seconda guerra mondiale, scatenata da regimi dittatoriali
portatori di perverse ideologie razziste, ha distrutto la vita di
milioni di persone nel nostro continente, ha dilaniato intere
nazioni, ha rischiato di inghiottire la stessa civiltà europea.
Questa civiltà - alla quale noi italiani abbiamo dato, nel corso dei
secoli, uno straordinario contributo intellettuale e spirituale - è
fatta di umanità, rispetto per "l'altro", fede nella ragione e nel
diritto, solidarietà. Le prevaricazioni dei totalitarismi non sono
riuscite a distruggere questi principi: essi sono risorti, più forti
che mai, sulle devastazioni della guerra; hanno cementato la volontà
degli europei di perseguire, uniti, obiettivi di pace e di progresso.
L'Italia, riconciliata nel nome della democrazia, ricostruita dopo i
disastri della Seconda Guerra Mondiale anche con il contributo di
intelligenza e di lavoro degli esuli istriani, fiumani e dalmati, ha
compiuto una scelta fondamentale. Ha identificato il proprio destino
con quello di un'Europa che si è lasciata alle spalle odi e rancori,
che ha deciso di costruire il proprio futuro sulla collaborazione
fra i suoi popoli basata sulla fiducia, sulla libertà, sulla
comprensione.
In questa Europa di fratellanza e di pace, le minoranze non sono più
vittime di divisioni e di esclusione, ma sono fonte e simbolo di
rispetto e di arricchimento reciproco, di dialogo e di costruttiva
collaborazione. Animata da questo spirito, l'Italia ha rafforzato il
proprio impegno per favorire il processo di rinascita e di
riaffermazione dei diritti delle minoranze italiane in Slovenia e
Croazia, in base ai principi cui debbono attenersi tutti i Paesi
membri dell'Unione Europea.
Il nostro europeismo non nega, anzi rafforza l'amore per la patria,
radicato negli ideali del Risorgimento. Essi ci hanno trasmesso,
insieme alla ritrovata coscienza dell'unità nazionale, il sentimento
profondo di fraternità fra tutte le nazioni, libere e indipendenti.
A oltre cinquant'anni di distanza dall'inizio del progetto politico
europeo, la consapevolezza delle ragioni che lo determinarono, la
memoria dei rischi fatali corsi dai popoli europei sono necessarie
per mantenere vigile la difesa delle fondamenta del vivere civile,
del rispetto per la dignità della persona umana.
Nel ricordare il cammino percorso da allora, possiamo rivendicare
con orgoglio, dopo gli immani travagli del secolo scorso, gli
straordinari avanzamenti compiuti.
Il ricordo di quei travagli e dell'indicibile fardello di dolore che
essi hanno addossato ai popoli europei rafforza la coscienza dei
valori di civiltà in cui si sostanzia l'identità europea. Il
presente e il futuro dell'Europa si fondano sul sentimento di comune
appartenenza di tutti gli europei e sul consolidamento di un unico
spazio in cui i principi e le libertà dell'Unione Europea siano da
tutti pienamente condivisi. La volontà di popoli un tempo fieramente
avversi di vivere insieme, nell'Unione Europea, assicura un futuro
di comune progresso, nella democrazia e nella libertà.
Fonte: resistenza_partigiana @ yahoogroups.com
---
UN UOMO DELLA RESISTENZA
Scrivo queste righe il giorno 10 febbraio 2006,
il cosiddetto " Giorno del Ricordo ", istituito nell´anno 2005 dal
governo di centro destra per accontentare le frange più estremiste
delle organizzazioni degli esuli e per strumentalizzare la tragedia
delle foibe. Sulle foibe iniziarono a raccontare le loro menzogne i
nazifascisti già nel 1944, mentre per gli esuli istriani tutto ebbe
inizio con il maledetto esodo di Pola del 1947, una fuga generale
insensata provocata dalla propaganda anticomunista che già aveva
incominciato ad imperversare dopo l´inizio della cosiddetta " Guerra
Fredda ". Da parte mia io preferisco ricordare altre cose, come la
visita a Trieste di uno degli uomini migliori che l´Italia abbia mai
avuto come Presidente della Repubblica : l´onorevole Sandro Pertini.
E´ la primavera del 1983. Viene annunciata a Trieste la visita del
Presidente della Repubblica. Già alla mattina presto la piazza Unità è
piena di gente. Oltre agli striscioni portati dagli operai delle
fabbriche e le bandiere sindacali, si notano numerosissimi simboli
della Lista per Trieste, formazione politica allora fortissima ed
alcuni manifesti con scritte di contestazione. In particolare un
striscione nero portato da alcune donne colpisce la mia attenzione :
vi è scritto sopra, in lettere verdastre : " Presidente Pertini,
ricordati
delle foibe ! " Pertini arriva con l´elicottero sul Molo Audace, si
reca in Prefettura acclamato dalla folla e poi ritorna a fare un giro
della piazza a piedi. La gente, trattenuta dalle transenne lo applaude
e mille mani si tendono per toccarlo. I rappresentanti della Lista del
Melòn se ne stanno in cupo silenzio. Io sono in prima fila. Mi passa
davanti quest´ uomo magro, quasi rachitico, più piccolo di me che già
non sono un gigante e quando gli tendo la mano allunga un braccio
sottile come un fuscello e me la stringe con forza insospettata. Non me
la sono lavata per un mese. Poi il Presidente si reca sul palco
allestito davanti al Municipio dove si trova il sindaco Richetti
assieme alle massime autorità. Succede un po´ di confusione. Sembra che
le " vedove della Lista ", quelle con lo striscione sulle foibe,
vogliano parlare con lui. C´ è anche pronta una delegazione della "
Lista per Trieste ". Qualcuno comincia a fischiare ed a urlare
improperi. A questo punto Pertini dice all´orecchio del sindaco
Richetti qualcosa che nessuno sente, poi rimane zitto. Il sindaco di
Trieste dice poche parole di circostanza, e la manifestazione si
scioglie senza che il Presidente della Repubblica in visita alla città
di Trieste abbia detto una sola parola. Poi i giornali scrissero che
il protocollo della visita non prevedeva che il Presidente della
Repubblica facesse alcun discorso in piazza a Trieste, ma i bene
informati fecero sapere in giro che le parole che Pertini aveva
sussurrato nell´orecchio del sindaco Richetti erano : " Io con questi
MATTI non ci parlo ". Successivamente nella stessa giornata Sandro
Pertini si recò in visita ai cantieri navali di Monfalcone e davanti
agli operai metalmeccanici riuniti in assemblea nella mensa aziendale
fece un comizio memorabile, tanto che in seguito fu portato in giro in
trionfo dagli stessi operai, alla faccia del protocollo e dei
regolamenti, e con grande preoccupazione delle sue guardie del corpo. L´
indomani, come al solito, iniziò una lunga serie di polemiche sulle
pagine della rubrica " Segnalazioni " del quotidiano " Il Piccolo " di
Trieste. Ma questa è un´ altra storia.
Gianni Ursini
---
dal sito http://www.quirinale.it
INTERVENTO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
CARLO AZEGLIO CIAMPI
IN OCCASIONE DEL "GIORNO DEL RICORDO".
Palazzo del Quirinale, 8 febbraio 2006
Signor Presidente della Corte Costituzionale,
Signor Vice Presidente del Senato della Repubblica,
Signor Vice Presidente del Consiglio dei Ministri,
Signori Ministri,
Onorevoli Parlamentari,
Autorità,
Signore e Signori,
sono oggi qui con voi, per onorare le finalità della Legge che, con
decisione pressoché unanime del Parlamento, ha istituito il "Giorno
del Ricordo". Le cito:
"conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e
di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli
istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più
complessa vicenda del confine orientale".
E' giusto che agli anni del silenzio faccia seguito la solenne
affermazione del ricordo.
La celebrazione di quest'anno si arricchisce di un momento di grande
significato: la prima consegna a congiunti delle vittime di una
medaglia dedicata a quanti perirono in modo atroce, nelle foibe, al
termine della seconda guerra mondiale.
Il riconoscimento del supplizio patito è un atto di giustizia nei
confronti di ognuna di quelle vittime, restituisce le loro esistenze
alla realtà presente perché le custodisca nella pienezza del loro
valore, come individui e come cittadini italiani.
L'evocazione delle loro sofferenze, e del dolore di quanti si videro
costretti ad allontanarsi per sempre dalle loro case in Istria, nel
Quarnaro e nella Dalmazia, ci unisce oggi nel rispetto e nella
meditazione.
Questo nostro incontro non ha valore puramente simbolico; testimonia
la presa di coscienza dell' intera comunità nazionale.
L'Italia non può e non vuole dimenticare: non perché ci anima il
risentimento, ma perché vogliamo che le tragedie del passato non si
ripetano in futuro.
La responsabilità che avvertiamo nei confronti delle giovani
generazioni ci impone di tramandare loro la consapevolezza di
avvenimenti che costituiscono parte integrante della storia della
nostra patria.
La memoria ci aiuta a guardare al passato con interezza di
sentimenti, a riconoscerci nella nostra identità, a radicarci nei
suoi valori fondanti per costruire un futuro nuovo e migliore.
L'odio e la pulizia etnica sono stati l'abominevole corollario
dell'Europa tragica del Novecento, squassata da una lotta senza
quartiere fra nazionalismi esasperati.
La Seconda guerra mondiale, scatenata da regimi dittatoriali
portatori di perverse ideologie razziste, ha distrutto la vita di
milioni di persone nel nostro continente, ha dilaniato intere
nazioni, ha rischiato di inghiottire la stessa civiltà europea.
Questa civiltà - alla quale noi italiani abbiamo dato, nel corso dei
secoli, uno straordinario contributo intellettuale e spirituale - è
fatta di umanità, rispetto per "l'altro", fede nella ragione e nel
diritto, solidarietà. Le prevaricazioni dei totalitarismi non sono
riuscite a distruggere questi principi: essi sono risorti, più forti
che mai, sulle devastazioni della guerra; hanno cementato la volontà
degli europei di perseguire, uniti, obiettivi di pace e di progresso.
L'Italia, riconciliata nel nome della democrazia, ricostruita dopo i
disastri della Seconda Guerra Mondiale anche con il contributo di
intelligenza e di lavoro degli esuli istriani, fiumani e dalmati, ha
compiuto una scelta fondamentale. Ha identificato il proprio destino
con quello di un'Europa che si è lasciata alle spalle odi e rancori,
che ha deciso di costruire il proprio futuro sulla collaborazione
fra i suoi popoli basata sulla fiducia, sulla libertà, sulla
comprensione.
In questa Europa di fratellanza e di pace, le minoranze non sono più
vittime di divisioni e di esclusione, ma sono fonte e simbolo di
rispetto e di arricchimento reciproco, di dialogo e di costruttiva
collaborazione. Animata da questo spirito, l'Italia ha rafforzato il
proprio impegno per favorire il processo di rinascita e di
riaffermazione dei diritti delle minoranze italiane in Slovenia e
Croazia, in base ai principi cui debbono attenersi tutti i Paesi
membri dell'Unione Europea.
Il nostro europeismo non nega, anzi rafforza l'amore per la patria,
radicato negli ideali del Risorgimento. Essi ci hanno trasmesso,
insieme alla ritrovata coscienza dell'unità nazionale, il sentimento
profondo di fraternità fra tutte le nazioni, libere e indipendenti.
A oltre cinquant'anni di distanza dall'inizio del progetto politico
europeo, la consapevolezza delle ragioni che lo determinarono, la
memoria dei rischi fatali corsi dai popoli europei sono necessarie
per mantenere vigile la difesa delle fondamenta del vivere civile,
del rispetto per la dignità della persona umana.
Nel ricordare il cammino percorso da allora, possiamo rivendicare
con orgoglio, dopo gli immani travagli del secolo scorso, gli
straordinari avanzamenti compiuti.
Il ricordo di quei travagli e dell'indicibile fardello di dolore che
essi hanno addossato ai popoli europei rafforza la coscienza dei
valori di civiltà in cui si sostanzia l'identità europea. Il
presente e il futuro dell'Europa si fondano sul sentimento di comune
appartenenza di tutti gli europei e sul consolidamento di un unico
spazio in cui i principi e le libertà dell'Unione Europea siano da
tutti pienamente condivisi. La volontà di popoli un tempo fieramente
avversi di vivere insieme, nell'Unione Europea, assicura un futuro
di comune progresso, nella democrazia e nella libertà.
(Una recentissima intervista allo scrittore tedesco Peter Handke "sul
piacere di scrivere, sulla guerra jugoslava e sulle passeggiate nei
boschi")
http://www.zeit.de/2006/06/L-Handke-Interv_?page=all
DIE ZEIT 01.02.2006 Nr.6
Ich komme aus dem Traum
Ein ZEIT-Gespräch mit dem Schriftsteller Peter Handke über die Lust
des Schreibens, den jugoslawischen Krieg und das Gehen in den Wäldern
DIE ZEIT: Es war an einem späten Abend im Januar 1988, als wir
einander aus schierem Zufall in der Pariser Metro begegnet sind. Bei
einem Glas Wein erzählten Sie mir, Sie kämen aus Ägypten und hätten
schon seit vielen Wochen mit keinem Menschen mehr gesprochen. Es war
die Zeit, von der Sie in Ihrem Tagebuch Gestern unterwegs erzählen.
Von Ägypten ist darin wenig die Rede.
Peter Handke: Dort konnte ich nur wenig notieren. Ich war ein bisschen
krank. Und ich konnte nicht für mich sein, weil ich mich ständig von
Händlern und Bettlern bedrängt sah. Ich habe mich dadurch gerettet,
dass ich in eines dieser Teehäuser ging, mich zu den anderen setzte
und an der Wasserpfeife sog oder vielmehr so tat, als ob. Da fand ich
Ruhe.
ZEIT: Sie sind dann drei Jahre lang quer durch die halbe Welt gereist,
nach Japan, Alaska, Schottland, Frankreich, Spanien, Slowenien und
noch weiter. Ich hatte beim Lesen den Eindruck, dass Sie auf
irgendwelche Flughäfen gegangen sind und einfach den nächsten Flug
genommen haben.
Handke: Manchmal war das so.
ZEIT: 1989 brach die DDR zusammen und damit eine ganze Welt. In Ihrem
Tagebuch verlieren Sie darüber fast kein Wort.
Handke: Ich kann nur dann etwas aufschreiben, wenn mir Sprache
zufliegt, Dinglichkeit. Es war mir nie im Sinn, ein zeitgenössisches
Journal zu schreiben. Es sind Reflexe, die erweitert sind, nicht
gerade zu Reflexionen, aber zu Läufen, zu Sprachläufen.
ZEIT: Sie schreiben nicht über persönliche Dinge, über Kopfschmerzen
oder schlechte Betten.
Handke: Ich fand das nicht beschreibenswert. Was ich spüre, muss
festgehalten werden in der Form, in der es sich jetzt zeigt. Dem gehe
ich nach, dem gebe ich Luft durch Sprache, und zugleich verfestige ich
es. Oft waren die Erlebnisse so überwältigend, dass ich eine Scheu
hatte mitzuschreiben. Mein Tagebuch Das Gewicht der Welt war eine
Reportage des Bewusstseins. In Gestern unterwegs habe ich manches
mitgeschrieben, anderes für den nächsten Morgen aufgehoben, bis es
durch den Kopf, durch den Körper gegangen war. Pythagoras hat seine
Schüler dazu angehalten, so lange in den Betten zu bleiben, bis sie
sich vergegenwärtigen konnten, was am Vortag gewesen war.
ZEIT: Wird es dadurch klarer?
Handke: Das Aufschreiben hat mich ortsfest gemacht. Oft wusste ich
nicht, wo ich aufgewacht bin. Man kommt in der Nacht an und sieht nur
Umrisse. Und wenn ich mich am nächsten Morgen in irgendeinem Hotel
hingesetzt habe, um den Vortag aufzuschreiben, war das wie einkaufen
gehen oder das Kind zur Schule bringen.
ZEIT: Ihre Reisen wirken wie Exerzitien. Könnten Sie sich vorstellen,
als Mönch zu leben?
Handke: Oh nein. Ich bin ein Epikuräer. Warum sollte ich auf die Dinge
verzichten, die mir Freude machen? Der Wein zum Beispiel ist eine der
schönsten Erfindungen, er hat mir schon oft gut getan.
ZEIT: Aber Ihre Reisen waren doch keine Vergnügungsreisen.
Handke: Eigentlich schon, ich bin ja zum Vergnügen auf der Welt.
ZEIT: Im Schneesturm durch Hokkaido zu wandern ist ein Vergnügen?
Handke: Aber natürlich. Wenn man dann in Sicherheit ist, die Schwelle
überschritten hat zur Wärme, wird es ein Vergnügen gewesen sein, um im
Futurum exaktum zu sprechen. Jedes Mal wenn man sich aus einer
brenzligen Situation befreit, wenn man denkt, es geht nicht weiter,
wenn man total minimalisiert ist als Mensch und dann über die Schwelle
kommt, merkt man plötzlich, was Leben ist. Diese Übergänge sind das
Fruchtbarste überhaupt. Das schöne Problem der Schwelle beschäftigt
mich seit über 30 Jahren, und es hilft mir immer noch weiter. Es
schubst mich weiter. Schon für mich als Schüler war das Lernen ein
Vergnügen, das Betrachten, Schauen, Übergehen in das Gesehene. Nein,
es ist nicht Vergnügen, es ist Freude. Manchmal ist es das Einswerden
mit den Formen. Man empfindet nicht mehr, dass man der Gefangene der
Historie ist. Man sieht die andere Geschichte, die mich seit je
beschäftigt hat.
ZEIT: Was ist die andere Geschichte?
Handke: Die Historie der Farben, des Versmaßes, der Formen,
japanischer Tuschzeichnungen etwa oder romanischer Skulpturen, auch
des Geschichtenerzählens. Das ist nicht zu realisieren, außer eben im
poetischen Machen.
ZEIT: Ist Ihnen das einmal gelungen?
Handke: Ich erzähle davon. Darauf geht alles hin, was ich schreibe. Es
ist nicht nur Utopie, es ist auch real, das Realste überhaupt. Es ist
ein Vorschlag, ein Traum von Geschichte. Sonst gäbe es ja auch die
Evangelien nicht, gäbe es das Buch Hiob nicht, wenn das Erzählen nicht
auf eine andere Welt zuginge, auf eine Hinterwelt im besseren Sinne,
wie eine Hinterglasmalerei.
ZEIT: Eine Revolte gegen Geschichtsphilosophie?
Handke: Ich bin fast der Überzeugung, ich betone das Wort fast, dass
der philosophische Begriff von Geschichte ein Euphemismus ist.
Geschichte ist nicht zu denken. Hegel hat daraus einen Denkbegriff
gemacht, das ist für mich ein Schmäh. So wird Geschichte nur zum
ewigen Kreislauf von Schweinereien. Ja, es gibt Fortschritte,
Fortschritte der Menschenrechte, auch technische Fortschritte, aber
jeder Fortschritt erzeugt woanders eine Katastrophe. Ich glaube nicht,
dass die Urzeit schlimmer war. Heute ist es nur anders schlimm oder
anders gut.
ZEIT: Denken Sie an das Glücksrad der Fortuna?
Handke: Man könnte es eher ein Lichtrad nennen: Wenn das Licht hierhin
fällt, wird es anderswo umso finsterer. Ich mache daraus keine
Ideologie, aber ich spüre es in mir.
ZEIT: Kommt daher Ihr Wunsch, dem Augenblick Geltung zu verschaffen?
Handke: Das ist kein Vorsatz. So bin ich halt gemacht. Vielleicht ist
es eine Art Krankheit, aber ich mag meine Krankheit.
ZEIT: Wenn man Ihre Bücher liest, ertappt man sich bei seiner eigenen
Unaufmerksamkeit und denkt, das hättest du auch sehen können, wenn du
dir die Zeit genommen hättest. Aber die hat man oft nicht.
Handke: Das nehme ich Ihnen nicht ab. Jeder hat genug Zeit.
ZEIT: Man hat sie, aber man nimmt sie sich nicht.
Handke: Jeder hat eine andere Natur, Gott sei Dank. Ich bin nicht da,
um anderen ein Beispiel zu geben, ich will mich nur selber ermahnen,
mir selber die Bilder geben, den Rhythmus geben. Wenn ich zum Beispiel
einen Tag nicht gelesen habe, schreibe ich: »Tag ohne lesen«, und das
ist wie eine Sünde. Lesen verstanden als Entziffern, Nachspüren. Oder
ich notiere: »Tag ohne Gang in die Wälder.« Ich nehme extra den
Plural, weil der Wald hier sehr verschieden ist, sich für mich in
verschiedene Wälder aufteilt. Ein Tag ohne den Gang in die Wälder ist
ein Versäumnis.
ZEIT: Und Schreiben?
Handke: Ich bin kein fanatischer Schreiber. Nur wenn ich dann im Tun
bin, wird es ausschließlich. Vorher drücke ich mich, solange ich kann.
Indem Sie jetzt hier sind, berauben Sie mich der Wälder. Sonst wäre
ich längst unterwegs. Morgen werde ich schreiben: »Tag ohne Wälder,
nur gequasselt.«
ZEIT: Schade, dass es so früh dunkel wird, sonst hätten wir den Gang
durch die Wälder gemeinsam noch machen können.
Handke: Ich gehe nicht mehr mit anderen, außer mit meiner Tochter. Der
will ich die Wälder nicht gerade zeigen, aber doch anmuten lassen. Ich
mag nicht sagen: Schau mal das oder das, ich gehe mit ihr langsam, in
der Hoffnung, dass sie etwas wahrnimmt, und manchmal sieht sie sogar
besser als ich. Natürlich möchte ich ihr die Stellen, wo man
Steinpilze findet, zeigen, so wie früher die Großväter die Enkel in
die Wälder mitgenommen haben, damit sie, wenn die Großväter einmal
nicht mehr da sind, die Stellen kennen. Ich hatte einmal vor, einen
Plan der Wälder zu machen, wo die Kostbarkeiten aufzuspüren sind, so
wie der Plan der Schatzinsel von Stevenson. Diese Insel habe ich als
Kind total wörtlich genommen, ich dachte, das stimmt alles.
ZEIT: Manche glauben, dass es die Insel gegeben hat.
Handke: In der Hauptsache ist sie wohl erfunden. Es gibt nichts
Schöneres, als, wie Hesse gesagt hat, das Wagnis der Fiktion
einzugehen. Wenn das Schiff der Fiktion parallel zur Realität fährt …
das ist für mich ein universelles Erlebnis.
ZEIT: Dann erzählen Sie eine Geschichte.
Handke: Ich erfinde nicht nur Geschichten, auch Wörter. Und natürlich
spielen Träume eine Rolle. Die Träume sind ja verschwunden aus der
Literatur, dabei sind sie ihr Ursprung. Bei den meisten
Schriftstellern sehe ich keinen Traum mehr. Ich komme aus dem Traum.
ZEIT: Wandern, lesen, schreiben – machen Sie das vor allem für sich
selber, oder sehen Sie auch den Leser vor sich?
Handke: Als ich das aus der Luft herausgegriffen habe – um ein anderes
Wort für notieren zu nehmen –, habe ich keineswegs an irgendeinen
Leser gedacht. Vor einem Jahr ungefähr hatte ich gerade den Versuch
über das Gericht in Den Haag und den Besuch bei Milo∆eviƒ hinter mir,
und ich verspürte das Bedürfnis, weiterzutun im Schreiben, und da habe
ich mir die 15 Jahre alten Notizbücher hergenommen. Nach zwei, drei
Seiten war ich begeistert – nicht von mir, sondern von der Bewegung
der Reisestationen. Das hat mich lebendig gemacht, und zugleich habe
ich mir gesagt, das soll nicht dich lebendig machen, sondern andere,
und dann habe ich das Ganze kopiert, aber vieles weggelassen. Sonst
lese ich meine früheren Sachen nie, es sei denn, es kommt mal eine
fremdsprachige Ausgabe daher, dann schaut man hinein, und zu seiner
eigenen Schande bleibt man doch länger drin.
ZEIT: Warum Schande?
Handke: Ich bin dann immer gerührt von mir selbst.
ZEIT: Und das mögen Sie nicht.
Handke: Im Moment schon, aber dann geht's immer weiter, und ich bin
immer gerührter, es kommen mir die Tränen, über die Welt, über mein
Tun, was ich gemacht hab.
ZEIT: Es ist jetzt genau 40 Jahre her, dass Ihr erstes Buch erschienen
ist, Die Hornissen. Sie sind dann sehr schnell ein Star der
Literaturszene geworden.
Handke: Aber nicht durch die Hornissen. Durch Princeton, wo ich
blöderweise das Maul aufgerissen habe, und durch die
Publikumsbeschimpfung.
ZEIT: Sie haben damals einen Brief an Ihre Mutter geschrieben. »Mach
Dir keine Sorgen um mich, ich werde sicher weltberühmt.« Haben Sie das
geglaubt?
Handke: Ich habe nie gedacht, dass ich je eine Chance hätte, nie. Ich
habe mich mit den Hornissen einfach retten wollen. Im Studium habe ich
die schwarze Wolke des Nichts vor mir gesehen. Ich habe immer Kafka
bewundert, der es geschafft hat, sein Studium zu vollenden und in den
Beruf zu gehen. Ich konnte das nicht. Dabei war ich ein guter
Jurastudent, ich habe sehr viel auf eigene Faust gelernt, aber ich
habe keine Antwort bekommen von den Professoren. Man braucht ja
irgendwie eine Erotik. Dann habe ich die Hornissen geschrieben. Man
muss sich vorstellen, was das damals bedeutete, aus dem Winkel, aus
dem ich kam, ein Buch bei Suhrkamp zu machen.
ZEIT: Jedenfalls sind Sie sehr rasch erfolgreich geworden. Sie konnten
sich eine Wohnung leisten, Reisen unternehmen.
Handke: Ja, zum Glück. Der größte Erfolg war ganz einfach der, dass
ich schreiben konnte und publiziert wurde. Sich die Zeit zu nehmen,
sie fruchten zu lassen, das ist schon ein Erfolg. Und dann die Sache
zu Ende zu bringen. Die Hornissen zu schreiben war ja nicht leicht,
denn damals gab es eine große Krise. Man fragte zu Recht: Was ist
Schreiben, wie schreibt man, warum schreibt man, ist Schreiben noch
erlaubt? Heute fragt man das nicht mehr. Ich empfinde diese Schwelle
immer noch, den Gedanken, dass das Schreiben eigentlich nicht sein
darf. Heute ist eine ungeheure Geläufigkeit da, einerseits erfreulich,
andererseits fragwürdig. Diese Schwelle überwunden zu haben, das war
Erfolg. Das erste Buch, das einen Auflagenerfolg hatte, war die Angst
des Tormanns beim Elfmeter, vier Jahre später. Aber was ist Erfolg
beim In-die-Welt-Gehen der Bücher? Ich habe selten wirklich gespürt,
dass die Bücher gelesen wurden. Vielleicht der Kurze Brief und
Wunschloses Unglück – doch, ja, man spürt es an den Briefen von
Lesern. Ich habe den Eindruck, es werden immer weniger Briefe geschrieben.
ZEIT: Heute schreibt man meist E-Mails.
Handke: Damit habe ich nichts zu tun. Aber es gibt immer noch
herrliche Briefe von Lesern, und wenn ich ein oder zwei im Monat
erhalte… Nicht, dass ich davon lebe, aber die kann ich manchmal gar
nicht beantworten, so schön sind sie.
ZEIT: Leiden Sie unter dem Älterwerden?
Handke: Nein. Ich habe zwar nicht gerade heiter die Räume
durchschritten, wie Goethe das gerne von sich gehabt hätte, aber ich
habe die Räume durchstöbert. In meinen Büchern kann man das vergehende
und das sich entwerfende Leben ziemlich genau ahnen. Man kann sehen,
was ein Schriftsteller ist, was Schreiben ist, was Leben im Schreiben
ist. Sonst hätte das alles ja keinen Sinn. Ich bin nie ein Profi
geworden. Ich bin ein Handwerker nur in dem, was ich nicht tue, nur im
Vermeiden.
ZEIT: Lesen Sie gegenwärtige Autoren?
Handke: Ich lese gerne und bin neugierig. Ich bin zutraulich wie ein
Tier, das zum Futtertrog geht, ich freue mich, wenn ich Joseph Zoderer
lese oder Ralf Rothmann oder Walter Kappacher oder Florian Lipus. Das
sind wertvolle Sachen. Wertvoll ist ein dummer Ausdruck, ich weiß,
aber immer noch besser als das, was ihr Kritiker immer sagt,
»wunderbar« oder »großartig«. Solche Wörter müsste man euch verbieten.
ZEIT: Sie haben gesagt, eine Möglichkeit bestehe für Sie immer nur
einmal. Schreiben Sie mit jedem Buch etwas Neues?
Handke: Ein neuen Ansatz vielleicht. Man kann die Comédie humaine
nicht noch mal schreiben. Balzac hat den neuen Menschen des 19.
Jahrhunderts beschrieben, mit der Kraft eines Titanen, voller Sanftmut
und Unbarmherzigkeit. Dieses horizontale Gemälde geht nicht mehr,
heute muss man vertikal schreiben. Aber es wird dadurch vermutlich
enger, vielleicht auch tiefer. Auch ich habe, so kommt es mir vor,
eine Art Comédie humaine dahergestümpert, aber sie ist subjektiv.
Balzac wollte ja objektiv sein. Auch Flaubert, was nicht immer von
Vorteil war. Er hat sich in seinen späteren Büchern verirrt. Wer hat
sich nicht verirrt? Vielleicht Goethe nicht. Es hätte ihm nicht geschadet.
ZEIT: Sie haben sich lange nicht mehr mit ihm beschäftigt.
Handke: Ja, er muss bald wieder drankommen.
ZEIT: Mögen Sie ihn?
Handke: Nach ein paar Sätzen von ihm, ähnlich wie bei Hölderlin,
kriegt man Lichtadern eingezogen. Man spürt, wie sich's gehört. Aber
mögen? Ich kenne ihn nicht. Ich würde ihn gerne kennen lernen,
spiritistisch vielleicht.
ZEIT: Auch er hat gerne Wein getrunken. Ich glaube, keinen besonders
guten.
Handke: Wer weiß. Oft ist der alltägliche Wein der beste. Ich mag
Schriftsteller nicht bewundern. Aber ab und zu bin ich voller
Verehrung für Geschriebenes, voller Freude und auch Sportsgeist. Es
gibt so viele gute Bücher, die kein Mensch mehr liest.
ZEIT: Die meisten Romane heute sind irgendwie realistisch. Das sind
Ihre Bücher eigentlich nie.
Handke: Ich kann nicht nacherzählen, ich kann nur vorerzählen. Bei der
langen Geschichte vom Bildverlust wollte ich möglichst genau die
Geschichte der Sierra de Gredos erzählen. Je näher ich ihr kam, desto
klarer wurde mir: Ich muss alles erfinden.
ZEIT: Warum müssen Sie erfinden?
Handke: Das Erfinden gibt mir ein Triumphgefühl. Wenn ich spüre, es
gibt eine Gegenwelt, die nicht unbedingt der tagtäglichen Welt
widerspricht, aber sie beleuchtet, dann habe ich ein Gefühl von…
ZEIT: …Macht?
Handke: …nicht Macht, sondern von Etwas-gemacht-Haben. Und letzten
Endes das Gefühl, jetzt habe ich das Recht zu leben, zu schreiben. Nur
durch die Erfindung habe ich dieses Recht. Bei Gestern unterwegs habe
ich dieses Gefühl nicht, es ist, als ob es gar nicht von mir wäre, es
mir zugeflogen, durch mich durchgeflogen und wieder aus mir
herausgeflogen wäre.
ZEIT: Der Realismus ist auch eine Erfindung.
Handke: Ja, schon, aber ich bin kein Realist. Cervantes ist auch kein
Realist. Die mittelalterlichen Epen sind auch nicht realistisch. Sie
sind märchenhaft, aber märchenhaft in einem schneidenden Sinn. In der
Abwesenheit habe ich den Parzival fast kopiert. Als ich ihn damals
las, dachte ich, das ist die Form, so lässt die Welt sich erzählen,
so, wie ich sie sehe, fühle und vor allem träume. Denken kann man die
Welt eh nicht. Die Abwesenheit ist im Grunde die gekürzte Fassung von
Wolframs Parzival.
ZEIT: Das habe ich, offen gestanden, nicht gemerkt.
Handke: Soll man ja auch nicht. Bei euch in der ZEIT stand neulich ein
Interview mit dem Sekretär der Schwedischen Akademie. Der Herr sagte,
die Literatur habe sich geändert, Fiktion sei zweitrangig geworden.
Ohne Fiktion aber kann man die Literatur abschaffen. Es sind
ehrenwerte Schreiber, die er genannt hat, wie etwa Kapuczynski, der
aufschlussreiche Reportagen schreibt, aber das kann man doch nicht
Literatur nennen. Man darf nicht alles vermischen, das ist skandalös.
Man muss nur eine Seite von einem Buch lesen, und man sieht: Das ist
Sprache oder eben nicht. Sprache, nicht Stil, das ist ein Unterschied.
Sie lesen eine Seite und wissen: endlich Sprache, endlich Zittern,
aber auch die Sprachlosigkeit in der Sprache. Beides.
ZEIT: Kann man das lernen?
Handke: Es ist kein Handwerk. Das kommt später dazu. Aber der Anfang
ist nie mit Handwerk zu schaffen. Ich verstehe nicht, wie man das
Schreiben in Schreibschulen lernen will.
ZEIT: Korrigieren Sie viel?
Handke: Sehr viel. Ich schreibe seit fünfzehn Jahren mit Bleistift –
außer die Theaterstücke, die ich mit der Maschine tippe. Wenn
gesprochen wird, dann muss irgendetwas knallen. Die Prosa schreibe ich
mit Bleistift, und da radiere ich viel. Die Gefahr, mit Bleistift zu
schreiben, besteht darin, dass man in der Stille des Schreibens
vergisst abzusetzen, also Absätze zu machen. Sie hinterher einzufügen
ist nicht gut. Dafür ist die Maschine oder der Computer besser. Aber
die Chance ist eben, dass es eine ganz andere epische Bewegung gibt.
Es spielt auch eine Rolle, dass ich die beiden letzten dicken Bücher,
Die Niemandsbucht und den Bildverlust, oftmals im Freien geschrieben
habe. Im Freien haben sich mir immer wieder neue Räume gezeigt, die
ich nur antupfen musste. Ich habe das als ungeheuer erfreulich
empfunden. Dass es ausschwingen kann in die Räume, die sich im Freien
auftun.
ZEIT: Was war denn die Grundfigur beim Bildverlust? Ich habe das nicht
verstanden.
Handke: Sie haben einen großen Blödsinn darüber geschrieben, so
achtlos, fahrlässig. Bevor Sie kamen heute, habe ich gedacht: Es ist
eigentlich eine Schande, dass dieser Mensch mein Haus betritt. Ich
habe ja immer von Bildern gelebt, von Traumbildern, von Anschauung,
und mit der Zeit bekam ich das Gefühl, dass die Bilder ihre
Gültigkeit, ihre Realität verlieren. Dem wollte ich nachspüren. Ich
erinnerte mich an junge Leute voller Enthusiasmus, voller Unschuld,
denen ich zwanzig Jahre später wieder begegnet bin, und ich sah, dass
diese Begeisterung verschwunden war.
ZEIT: Weil sie älter geworden waren.
Handke: Ja, ich habe mich für Momente wiedererkannt. Es hat mich zu
der Frage gebracht: Wo ist eigentlich die Begeisterung unserer Jugend
geblieben, als wir geschrien haben vor Freude: Wir sind doch alle
aufgebrochen, irgendwohin. Und da habe ich die Geschichte dieser Frau
geschrieben, die die Leute wiederfindet, mit denen sie zusammen war
und deren Begeisterung verschwunden ist, aber vielleicht wieder
geweckt werden kann.
ZEIT: Woher kommen die Kriegsbilder?
Handke: Das hat auch etwas mit Jugoslawien zu tun. Ich hatte die
Vorstellung, dass sich die letzten Menschen da oben im Hochgebirge
sammeln und eine Art Kolonie bilden.
ZEIT: Die Menschen fangen noch einmal von vorn an?
Handke: Ja, die Menschen dort wollen keine Bilder mehr haben, die
Geschichte der Menschheit wird hier wirklich Geschichte. Es geht um
den Konflikt zwischen Bilderglauben und Bildersturm. Ich spüre
manchmal, dass ein neuer Bildersturm an der Zeit wäre. Es geht nicht
so weiter, es ist eine Beleidigung, eine Entseelung, eine
Entleiblichung, was die Bilder mit uns machen. Die Menschen meines
Buchs sind auf der Suche: Wie kann man sich vor den Bildern retten?
ZEIT: Ich als Leser bin verwirrt, weil es in Ihrem Roman keine
Orientierung gibt. Jeder Ort ist zugleich ein anderer.
Handke: Sie sollten nicht sagen: Ich als Leser. Sondern: Der Leser als
Ich. Ja, das glaube ich Ihnen. Wenn Sie Faulkner lesen oder Cervantes,
das ist ab und zu steinig, mühsam. Aber sobald man Vertrauen fasst,
geht man durch die Bewegung hindurch. Das ist Literatur, das ist
Lesen, nicht etwas, was so glatt daherkommt. Ich bemühe mich um
Klarheit, ich möchte nicht dunkel sein. Als ich noch ein junger
Schriftsteller war, stand in irgendeiner Rezension »Der dunkle
Handke«, es hat mir geschmeichelt. Aber das ist lange vorbei. Ich will
Licht sein. Aber ich möchte forschen im Schreiben. Ich will nicht
amerikanisch aufbereitet schreiben. Die deutsche Sprache hat ihr
eigenes Recht, aber auch ihre Schlingen. Wenn man sich ihren
Assoziationen, ihren Klängen völlig hingibt, kann man sich leicht
verlieren. Nicht wenigen Schriftstellern ist das ja passiert.
Andererseits sind wir eben deutschsprachige Schriftsteller, und das
muss man auch merken. Wir können nicht schreiben wie die Amerikaner,
wie die Franzosen. Hätte Eichendorff schreiben sollen wie Flaubert
oder Stendhal?
ZEIT: Eichendorff kann man sich eigentlich in einer anderen Literatur
gar nicht vorstellen.
Handke: Ja, der ist herrlich, die deutsche Literatur hat ihre eigenen
Geschichten, ihren eigenen Fortgang. Das muss man bewahren. Das müssen
Kretins wie ich praktizieren. Und das ist spannend, ist herrlich.
Prosaschreiben ist meine Heimat. Einmal habe ich zwei Jahre lang fast
nur übersetzt. Mit einer bitteren Sehnsucht bin ich zwei Jahre lang um
meinen Schreibtisch herumgeschlichen und dachte, du musst endlich
wieder Prosa schreiben. Aber für mich ist es wichtig, monate- oder
auch mal zwei Jahre lang ohne Schreiben auszukommen, damit Lust und
Bedürfnis sich wieder vereinen.
ZEIT: Ist es nicht so, dass nach langer Pause die Fertigkeit verloren
gehen kann?
Handke: Das nicht, aber eine Geschichte, eine Idee, die man hatte,
kann in dieser Zeit vermodern. Dann kann es passieren, dass man den
Pfingsttag versäumt, um den Anfang zu machen.
ZEIT: Sie haben viele Autoren entdeckt oder wiederentdeckt, Emmanuel
Bove oder Hermann Lenz zum Beispiel.
Handke: Ja, das hatte eine große Wirkung, aber wenn ich heute einen
solchen Autor in der SZ oder der ZEIT vorstellen würde, hätte das fast
keine Wirkung mehr.
ZEIT: Warum?
Handke: Die Aufmerksamkeit ist erschöpft. Die Hinweise auf vergessene
Autoren, die Wiederentdeckungen sind Mode, und der Nutzen wird immer
geringer. Auch habe ich nicht mehr die Stimme wie früher.
ZEIT: Vielleicht liegt das an Ihrer Verteidigung der Serben im
jugoslawischen Krieg.
Handke: Vorsicht, Sie sind hier in meinem Haus.
ZEIT: Ich habe zwar gerade das Messer hier genommen, aber wirklich
nur, um mir ein Stück Käse abzuschneiden.
Handke: Sie werden mich nicht in eine Verteidigung bringen. Ich habe
da nichts zu erklären.
ZEIT: Es gibt viele Buchhandlungen in Österreich, die Ihre Bücher
nicht mehr führen.
Handke: Nicht nur in Österreich, auch in der Schweiz und Deutschland.
Daran seid auch ihr Kritiker schuld. Auf der einen Seite macht ihr im
Feuilleton, wenn ich jetzt mal im Plural reden darf, einen Text wie
den über meinen Besuch bei Milo∆eviƒ oder über meine Reise zu den
Flüchtlingen in Serbien nieder, noch bevor ihr ihn gelesen habt, ihr
blockt ab; und auf der anderen Seite, wenn Gestern unterwegs
erscheint, seid ihr ganz offen und zeigt euch als feine, aufmerksame,
sprachbewusste Leser. Vorher aber habt ihr den Weg zu den Lesern
abgeschnitten, also zu den Buchhandlungen. Die Buchhändler werden
zunehmend moralistisch und gebärden sich als Richter. Eine Bekannte
erzählte mir, sie habe in vier Buchhandlungen gehen müssen, bis sie
endlich Gestern unterwegs erhielt. Ein Buchhändler sagte mir voller
Stolz, er habe alle meine Bücher, als die Winterliche Reise erschien,
aus seinem Laden entfernt.
ZEIT: Das ist idiotisch, das muss ich zugeben, obwohl ich in der Sache
anderer Meinung bin.
Handke: Sie müssen gar nichts zugeben, es geht auch nicht um Meinung.
Meinung haben hat nichts mit Schreiben zu tun. Hat jemals jemand in
einer westlichen Zeitung von den Flüchtlingen, mehr als einer halben
Million, in Serbien erzählt? Nie habe ich etwas darüber gelesen, wie
die vegetieren. Und zum ersten Mal habe ich deren Geschichte erzählt.
Warum geht nicht einer der Reporter der ZEIT, die die Geschichte vom
serbischen Adolf zum siebzigsten Mal als Dossier aufmöbeln, wo doch
die bosnischen Muselmanen und die Kroaten genauso viel Blut am Stecken
haben, zu den serbischen Flüchtlingen? Die kommen aus dem Kosovo, aus
Kroatien, aus Bosnien und werden von den eigenen Landsleuten in
Serbien verachtet. Ich habe darüber geschrieben, ohne irgendeine
Ideologie damit zu verbinden, und ich werde dafür niedergemacht. Zum
ersten Mal kommt einer wie ich nach Srebrenica und erzählt von einer
Mutter, nicht von den Müttern. Ja, es ist ein unverzeihlicher
Racheakt, was die serbische Armee da veranstaltet hat. Aber es ist
eine Rache gewesen an den zerstörten Dörfern rund um Srebrenica. Für
mich habt ihr Deutschen eine große Schuld auf euch geladen, schon mit
der Anerkennung Kroatiens. Euer Herausgeber Joffe hat gesagt, dass das
Wort Auschwitz als Schlagwort verwendet wurde. Aber wer hat damit
angefangen? Es war euer Außenminister Fischer. Scharping hat von KZs
in Prishtina geredet, was ein Unsinn ist. Die Knüppelwörter stammen
von euren Offiziellen. Und die haben den Knüppel benützt, indem sie
den Bombenkrieg mitverantwortet haben.
ZEIT: Es gibt viele Kriege auf der Welt, warum regen Sie sich gerade
über den in Jugoslawien auf?
Handke: Jeder hat sein Land. Der Schriftsteller Péter Esterházy, der
für den Bombenkrieg war, hat gesagt: Ach, dem Peter Handke hat man
sein Spielzeug weggenommen, deswegen ist er so beleidigt. Und der
Esterházy kriegt den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.
Verkehrte Welt. Serbien wurde nie erzählt, und ich habe nur erzählt,
was ich in Serbien gesehen habe.
ZEIT: Mussten Sie den Büchnerpreis zurückgeben?
Handke: Der Büchnerpreis hat ja nichts mit Büchner zu tun, das ist ein
repräsentativer Preis der Bundesrepublik Deutschland.
ZEIT: Was haben Sie gegen die Deutschen?
Handke: Mein Vater war ein Deutscher, er stammte aus einer
Bäckerfamilie im Harz. Ich habe keinen Hass auf Deutschland. Es gibt
viele Deutschlands, das krachlederne Großdeutschland und das
Deutschland der Provinzen, das Deutschland »nebendraußen«, um es mit
einem Wort von Hermann Lenz zu sagen. Das ist mein Deutschland und
wird es bleiben.
ZEIT: Warum sind Sie aus der Kirche ausgetreten?
Handke: Was mich auf die Palme oder vielmehr auf die Serbische Fichte
gebracht hat, war ein Sendschreiben des Bischofs von Amiens. Er hat
den Bombenkrieg gegen Jugoslawien gerechtfertigt mit dem Satz: Wenn
ein Waldbrand herrsche, genüge es nicht, mit dem Eimer zu kommen, man
benötige Löschflugzeuge. Ich scheue mich, mich einen Christen zu
nennen. Aber ich fühle mich in der Nachfolge Christi, ohne dass ich
sein Nachfolger wäre. Er ist für mich die größte Gestalt in der
Geschichte. Der war kein Nazarener, der hatte auch seinen Zorn.
ZEIT: In Gestern unterwegs stößt man immer wieder auf Zitate aus dem
Neuen Testament.
Handke: In der ersten Fassung standen da Seiten um Seiten auf
Griechisch. Ich habe nur weniges übernommen, vor allem, um Lust zu
machen, Griechisch zu lernen. – Es ist fast dunkel geworden, soll ich
ein Licht machen?
ZEIT: Nein, so kann ich besser den Garten sehen, die schöne Zeder.
Handke: Es sind zwei, die eine ist eine Libanon-Zeder, die andere eine
Atlantik-Zeder. Links Libanon, rechts Atlantik. – Machen wir jetzt
Schluss, ich hole noch einen Wein.
Das Gespräch führte Ulrich Greiner
© DIE ZEIT 01.02.2006 Nr.6
AUS DEM ARCHIV
ZEIT 24/1999: Ein lieber Gast
Peter Handke findet in Serbien andersgelbe Nudelnester und redet
seinen Freunden nach dem Mund ...
http://www.zeit.de/1999/24/199924.handke_.xml
ZEIT 16/1999: Kriegsschauplatz Handke
Der Schriftsteller Michael Scharang fürchtet, daß die poltitischen
Attacken auf Handke dessen Werk beschädigen sollen ...
http://www.zeit.de/1999/16/199916.handke_.xml
piacere di scrivere, sulla guerra jugoslava e sulle passeggiate nei
boschi")
http://www.zeit.de/2006/06/L-Handke-Interv_?page=all
DIE ZEIT 01.02.2006 Nr.6
Ich komme aus dem Traum
Ein ZEIT-Gespräch mit dem Schriftsteller Peter Handke über die Lust
des Schreibens, den jugoslawischen Krieg und das Gehen in den Wäldern
DIE ZEIT: Es war an einem späten Abend im Januar 1988, als wir
einander aus schierem Zufall in der Pariser Metro begegnet sind. Bei
einem Glas Wein erzählten Sie mir, Sie kämen aus Ägypten und hätten
schon seit vielen Wochen mit keinem Menschen mehr gesprochen. Es war
die Zeit, von der Sie in Ihrem Tagebuch Gestern unterwegs erzählen.
Von Ägypten ist darin wenig die Rede.
Peter Handke: Dort konnte ich nur wenig notieren. Ich war ein bisschen
krank. Und ich konnte nicht für mich sein, weil ich mich ständig von
Händlern und Bettlern bedrängt sah. Ich habe mich dadurch gerettet,
dass ich in eines dieser Teehäuser ging, mich zu den anderen setzte
und an der Wasserpfeife sog oder vielmehr so tat, als ob. Da fand ich
Ruhe.
ZEIT: Sie sind dann drei Jahre lang quer durch die halbe Welt gereist,
nach Japan, Alaska, Schottland, Frankreich, Spanien, Slowenien und
noch weiter. Ich hatte beim Lesen den Eindruck, dass Sie auf
irgendwelche Flughäfen gegangen sind und einfach den nächsten Flug
genommen haben.
Handke: Manchmal war das so.
ZEIT: 1989 brach die DDR zusammen und damit eine ganze Welt. In Ihrem
Tagebuch verlieren Sie darüber fast kein Wort.
Handke: Ich kann nur dann etwas aufschreiben, wenn mir Sprache
zufliegt, Dinglichkeit. Es war mir nie im Sinn, ein zeitgenössisches
Journal zu schreiben. Es sind Reflexe, die erweitert sind, nicht
gerade zu Reflexionen, aber zu Läufen, zu Sprachläufen.
ZEIT: Sie schreiben nicht über persönliche Dinge, über Kopfschmerzen
oder schlechte Betten.
Handke: Ich fand das nicht beschreibenswert. Was ich spüre, muss
festgehalten werden in der Form, in der es sich jetzt zeigt. Dem gehe
ich nach, dem gebe ich Luft durch Sprache, und zugleich verfestige ich
es. Oft waren die Erlebnisse so überwältigend, dass ich eine Scheu
hatte mitzuschreiben. Mein Tagebuch Das Gewicht der Welt war eine
Reportage des Bewusstseins. In Gestern unterwegs habe ich manches
mitgeschrieben, anderes für den nächsten Morgen aufgehoben, bis es
durch den Kopf, durch den Körper gegangen war. Pythagoras hat seine
Schüler dazu angehalten, so lange in den Betten zu bleiben, bis sie
sich vergegenwärtigen konnten, was am Vortag gewesen war.
ZEIT: Wird es dadurch klarer?
Handke: Das Aufschreiben hat mich ortsfest gemacht. Oft wusste ich
nicht, wo ich aufgewacht bin. Man kommt in der Nacht an und sieht nur
Umrisse. Und wenn ich mich am nächsten Morgen in irgendeinem Hotel
hingesetzt habe, um den Vortag aufzuschreiben, war das wie einkaufen
gehen oder das Kind zur Schule bringen.
ZEIT: Ihre Reisen wirken wie Exerzitien. Könnten Sie sich vorstellen,
als Mönch zu leben?
Handke: Oh nein. Ich bin ein Epikuräer. Warum sollte ich auf die Dinge
verzichten, die mir Freude machen? Der Wein zum Beispiel ist eine der
schönsten Erfindungen, er hat mir schon oft gut getan.
ZEIT: Aber Ihre Reisen waren doch keine Vergnügungsreisen.
Handke: Eigentlich schon, ich bin ja zum Vergnügen auf der Welt.
ZEIT: Im Schneesturm durch Hokkaido zu wandern ist ein Vergnügen?
Handke: Aber natürlich. Wenn man dann in Sicherheit ist, die Schwelle
überschritten hat zur Wärme, wird es ein Vergnügen gewesen sein, um im
Futurum exaktum zu sprechen. Jedes Mal wenn man sich aus einer
brenzligen Situation befreit, wenn man denkt, es geht nicht weiter,
wenn man total minimalisiert ist als Mensch und dann über die Schwelle
kommt, merkt man plötzlich, was Leben ist. Diese Übergänge sind das
Fruchtbarste überhaupt. Das schöne Problem der Schwelle beschäftigt
mich seit über 30 Jahren, und es hilft mir immer noch weiter. Es
schubst mich weiter. Schon für mich als Schüler war das Lernen ein
Vergnügen, das Betrachten, Schauen, Übergehen in das Gesehene. Nein,
es ist nicht Vergnügen, es ist Freude. Manchmal ist es das Einswerden
mit den Formen. Man empfindet nicht mehr, dass man der Gefangene der
Historie ist. Man sieht die andere Geschichte, die mich seit je
beschäftigt hat.
ZEIT: Was ist die andere Geschichte?
Handke: Die Historie der Farben, des Versmaßes, der Formen,
japanischer Tuschzeichnungen etwa oder romanischer Skulpturen, auch
des Geschichtenerzählens. Das ist nicht zu realisieren, außer eben im
poetischen Machen.
ZEIT: Ist Ihnen das einmal gelungen?
Handke: Ich erzähle davon. Darauf geht alles hin, was ich schreibe. Es
ist nicht nur Utopie, es ist auch real, das Realste überhaupt. Es ist
ein Vorschlag, ein Traum von Geschichte. Sonst gäbe es ja auch die
Evangelien nicht, gäbe es das Buch Hiob nicht, wenn das Erzählen nicht
auf eine andere Welt zuginge, auf eine Hinterwelt im besseren Sinne,
wie eine Hinterglasmalerei.
ZEIT: Eine Revolte gegen Geschichtsphilosophie?
Handke: Ich bin fast der Überzeugung, ich betone das Wort fast, dass
der philosophische Begriff von Geschichte ein Euphemismus ist.
Geschichte ist nicht zu denken. Hegel hat daraus einen Denkbegriff
gemacht, das ist für mich ein Schmäh. So wird Geschichte nur zum
ewigen Kreislauf von Schweinereien. Ja, es gibt Fortschritte,
Fortschritte der Menschenrechte, auch technische Fortschritte, aber
jeder Fortschritt erzeugt woanders eine Katastrophe. Ich glaube nicht,
dass die Urzeit schlimmer war. Heute ist es nur anders schlimm oder
anders gut.
ZEIT: Denken Sie an das Glücksrad der Fortuna?
Handke: Man könnte es eher ein Lichtrad nennen: Wenn das Licht hierhin
fällt, wird es anderswo umso finsterer. Ich mache daraus keine
Ideologie, aber ich spüre es in mir.
ZEIT: Kommt daher Ihr Wunsch, dem Augenblick Geltung zu verschaffen?
Handke: Das ist kein Vorsatz. So bin ich halt gemacht. Vielleicht ist
es eine Art Krankheit, aber ich mag meine Krankheit.
ZEIT: Wenn man Ihre Bücher liest, ertappt man sich bei seiner eigenen
Unaufmerksamkeit und denkt, das hättest du auch sehen können, wenn du
dir die Zeit genommen hättest. Aber die hat man oft nicht.
Handke: Das nehme ich Ihnen nicht ab. Jeder hat genug Zeit.
ZEIT: Man hat sie, aber man nimmt sie sich nicht.
Handke: Jeder hat eine andere Natur, Gott sei Dank. Ich bin nicht da,
um anderen ein Beispiel zu geben, ich will mich nur selber ermahnen,
mir selber die Bilder geben, den Rhythmus geben. Wenn ich zum Beispiel
einen Tag nicht gelesen habe, schreibe ich: »Tag ohne lesen«, und das
ist wie eine Sünde. Lesen verstanden als Entziffern, Nachspüren. Oder
ich notiere: »Tag ohne Gang in die Wälder.« Ich nehme extra den
Plural, weil der Wald hier sehr verschieden ist, sich für mich in
verschiedene Wälder aufteilt. Ein Tag ohne den Gang in die Wälder ist
ein Versäumnis.
ZEIT: Und Schreiben?
Handke: Ich bin kein fanatischer Schreiber. Nur wenn ich dann im Tun
bin, wird es ausschließlich. Vorher drücke ich mich, solange ich kann.
Indem Sie jetzt hier sind, berauben Sie mich der Wälder. Sonst wäre
ich längst unterwegs. Morgen werde ich schreiben: »Tag ohne Wälder,
nur gequasselt.«
ZEIT: Schade, dass es so früh dunkel wird, sonst hätten wir den Gang
durch die Wälder gemeinsam noch machen können.
Handke: Ich gehe nicht mehr mit anderen, außer mit meiner Tochter. Der
will ich die Wälder nicht gerade zeigen, aber doch anmuten lassen. Ich
mag nicht sagen: Schau mal das oder das, ich gehe mit ihr langsam, in
der Hoffnung, dass sie etwas wahrnimmt, und manchmal sieht sie sogar
besser als ich. Natürlich möchte ich ihr die Stellen, wo man
Steinpilze findet, zeigen, so wie früher die Großväter die Enkel in
die Wälder mitgenommen haben, damit sie, wenn die Großväter einmal
nicht mehr da sind, die Stellen kennen. Ich hatte einmal vor, einen
Plan der Wälder zu machen, wo die Kostbarkeiten aufzuspüren sind, so
wie der Plan der Schatzinsel von Stevenson. Diese Insel habe ich als
Kind total wörtlich genommen, ich dachte, das stimmt alles.
ZEIT: Manche glauben, dass es die Insel gegeben hat.
Handke: In der Hauptsache ist sie wohl erfunden. Es gibt nichts
Schöneres, als, wie Hesse gesagt hat, das Wagnis der Fiktion
einzugehen. Wenn das Schiff der Fiktion parallel zur Realität fährt …
das ist für mich ein universelles Erlebnis.
ZEIT: Dann erzählen Sie eine Geschichte.
Handke: Ich erfinde nicht nur Geschichten, auch Wörter. Und natürlich
spielen Träume eine Rolle. Die Träume sind ja verschwunden aus der
Literatur, dabei sind sie ihr Ursprung. Bei den meisten
Schriftstellern sehe ich keinen Traum mehr. Ich komme aus dem Traum.
ZEIT: Wandern, lesen, schreiben – machen Sie das vor allem für sich
selber, oder sehen Sie auch den Leser vor sich?
Handke: Als ich das aus der Luft herausgegriffen habe – um ein anderes
Wort für notieren zu nehmen –, habe ich keineswegs an irgendeinen
Leser gedacht. Vor einem Jahr ungefähr hatte ich gerade den Versuch
über das Gericht in Den Haag und den Besuch bei Milo∆eviƒ hinter mir,
und ich verspürte das Bedürfnis, weiterzutun im Schreiben, und da habe
ich mir die 15 Jahre alten Notizbücher hergenommen. Nach zwei, drei
Seiten war ich begeistert – nicht von mir, sondern von der Bewegung
der Reisestationen. Das hat mich lebendig gemacht, und zugleich habe
ich mir gesagt, das soll nicht dich lebendig machen, sondern andere,
und dann habe ich das Ganze kopiert, aber vieles weggelassen. Sonst
lese ich meine früheren Sachen nie, es sei denn, es kommt mal eine
fremdsprachige Ausgabe daher, dann schaut man hinein, und zu seiner
eigenen Schande bleibt man doch länger drin.
ZEIT: Warum Schande?
Handke: Ich bin dann immer gerührt von mir selbst.
ZEIT: Und das mögen Sie nicht.
Handke: Im Moment schon, aber dann geht's immer weiter, und ich bin
immer gerührter, es kommen mir die Tränen, über die Welt, über mein
Tun, was ich gemacht hab.
ZEIT: Es ist jetzt genau 40 Jahre her, dass Ihr erstes Buch erschienen
ist, Die Hornissen. Sie sind dann sehr schnell ein Star der
Literaturszene geworden.
Handke: Aber nicht durch die Hornissen. Durch Princeton, wo ich
blöderweise das Maul aufgerissen habe, und durch die
Publikumsbeschimpfung.
ZEIT: Sie haben damals einen Brief an Ihre Mutter geschrieben. »Mach
Dir keine Sorgen um mich, ich werde sicher weltberühmt.« Haben Sie das
geglaubt?
Handke: Ich habe nie gedacht, dass ich je eine Chance hätte, nie. Ich
habe mich mit den Hornissen einfach retten wollen. Im Studium habe ich
die schwarze Wolke des Nichts vor mir gesehen. Ich habe immer Kafka
bewundert, der es geschafft hat, sein Studium zu vollenden und in den
Beruf zu gehen. Ich konnte das nicht. Dabei war ich ein guter
Jurastudent, ich habe sehr viel auf eigene Faust gelernt, aber ich
habe keine Antwort bekommen von den Professoren. Man braucht ja
irgendwie eine Erotik. Dann habe ich die Hornissen geschrieben. Man
muss sich vorstellen, was das damals bedeutete, aus dem Winkel, aus
dem ich kam, ein Buch bei Suhrkamp zu machen.
ZEIT: Jedenfalls sind Sie sehr rasch erfolgreich geworden. Sie konnten
sich eine Wohnung leisten, Reisen unternehmen.
Handke: Ja, zum Glück. Der größte Erfolg war ganz einfach der, dass
ich schreiben konnte und publiziert wurde. Sich die Zeit zu nehmen,
sie fruchten zu lassen, das ist schon ein Erfolg. Und dann die Sache
zu Ende zu bringen. Die Hornissen zu schreiben war ja nicht leicht,
denn damals gab es eine große Krise. Man fragte zu Recht: Was ist
Schreiben, wie schreibt man, warum schreibt man, ist Schreiben noch
erlaubt? Heute fragt man das nicht mehr. Ich empfinde diese Schwelle
immer noch, den Gedanken, dass das Schreiben eigentlich nicht sein
darf. Heute ist eine ungeheure Geläufigkeit da, einerseits erfreulich,
andererseits fragwürdig. Diese Schwelle überwunden zu haben, das war
Erfolg. Das erste Buch, das einen Auflagenerfolg hatte, war die Angst
des Tormanns beim Elfmeter, vier Jahre später. Aber was ist Erfolg
beim In-die-Welt-Gehen der Bücher? Ich habe selten wirklich gespürt,
dass die Bücher gelesen wurden. Vielleicht der Kurze Brief und
Wunschloses Unglück – doch, ja, man spürt es an den Briefen von
Lesern. Ich habe den Eindruck, es werden immer weniger Briefe geschrieben.
ZEIT: Heute schreibt man meist E-Mails.
Handke: Damit habe ich nichts zu tun. Aber es gibt immer noch
herrliche Briefe von Lesern, und wenn ich ein oder zwei im Monat
erhalte… Nicht, dass ich davon lebe, aber die kann ich manchmal gar
nicht beantworten, so schön sind sie.
ZEIT: Leiden Sie unter dem Älterwerden?
Handke: Nein. Ich habe zwar nicht gerade heiter die Räume
durchschritten, wie Goethe das gerne von sich gehabt hätte, aber ich
habe die Räume durchstöbert. In meinen Büchern kann man das vergehende
und das sich entwerfende Leben ziemlich genau ahnen. Man kann sehen,
was ein Schriftsteller ist, was Schreiben ist, was Leben im Schreiben
ist. Sonst hätte das alles ja keinen Sinn. Ich bin nie ein Profi
geworden. Ich bin ein Handwerker nur in dem, was ich nicht tue, nur im
Vermeiden.
ZEIT: Lesen Sie gegenwärtige Autoren?
Handke: Ich lese gerne und bin neugierig. Ich bin zutraulich wie ein
Tier, das zum Futtertrog geht, ich freue mich, wenn ich Joseph Zoderer
lese oder Ralf Rothmann oder Walter Kappacher oder Florian Lipus. Das
sind wertvolle Sachen. Wertvoll ist ein dummer Ausdruck, ich weiß,
aber immer noch besser als das, was ihr Kritiker immer sagt,
»wunderbar« oder »großartig«. Solche Wörter müsste man euch verbieten.
ZEIT: Sie haben gesagt, eine Möglichkeit bestehe für Sie immer nur
einmal. Schreiben Sie mit jedem Buch etwas Neues?
Handke: Ein neuen Ansatz vielleicht. Man kann die Comédie humaine
nicht noch mal schreiben. Balzac hat den neuen Menschen des 19.
Jahrhunderts beschrieben, mit der Kraft eines Titanen, voller Sanftmut
und Unbarmherzigkeit. Dieses horizontale Gemälde geht nicht mehr,
heute muss man vertikal schreiben. Aber es wird dadurch vermutlich
enger, vielleicht auch tiefer. Auch ich habe, so kommt es mir vor,
eine Art Comédie humaine dahergestümpert, aber sie ist subjektiv.
Balzac wollte ja objektiv sein. Auch Flaubert, was nicht immer von
Vorteil war. Er hat sich in seinen späteren Büchern verirrt. Wer hat
sich nicht verirrt? Vielleicht Goethe nicht. Es hätte ihm nicht geschadet.
ZEIT: Sie haben sich lange nicht mehr mit ihm beschäftigt.
Handke: Ja, er muss bald wieder drankommen.
ZEIT: Mögen Sie ihn?
Handke: Nach ein paar Sätzen von ihm, ähnlich wie bei Hölderlin,
kriegt man Lichtadern eingezogen. Man spürt, wie sich's gehört. Aber
mögen? Ich kenne ihn nicht. Ich würde ihn gerne kennen lernen,
spiritistisch vielleicht.
ZEIT: Auch er hat gerne Wein getrunken. Ich glaube, keinen besonders
guten.
Handke: Wer weiß. Oft ist der alltägliche Wein der beste. Ich mag
Schriftsteller nicht bewundern. Aber ab und zu bin ich voller
Verehrung für Geschriebenes, voller Freude und auch Sportsgeist. Es
gibt so viele gute Bücher, die kein Mensch mehr liest.
ZEIT: Die meisten Romane heute sind irgendwie realistisch. Das sind
Ihre Bücher eigentlich nie.
Handke: Ich kann nicht nacherzählen, ich kann nur vorerzählen. Bei der
langen Geschichte vom Bildverlust wollte ich möglichst genau die
Geschichte der Sierra de Gredos erzählen. Je näher ich ihr kam, desto
klarer wurde mir: Ich muss alles erfinden.
ZEIT: Warum müssen Sie erfinden?
Handke: Das Erfinden gibt mir ein Triumphgefühl. Wenn ich spüre, es
gibt eine Gegenwelt, die nicht unbedingt der tagtäglichen Welt
widerspricht, aber sie beleuchtet, dann habe ich ein Gefühl von…
ZEIT: …Macht?
Handke: …nicht Macht, sondern von Etwas-gemacht-Haben. Und letzten
Endes das Gefühl, jetzt habe ich das Recht zu leben, zu schreiben. Nur
durch die Erfindung habe ich dieses Recht. Bei Gestern unterwegs habe
ich dieses Gefühl nicht, es ist, als ob es gar nicht von mir wäre, es
mir zugeflogen, durch mich durchgeflogen und wieder aus mir
herausgeflogen wäre.
ZEIT: Der Realismus ist auch eine Erfindung.
Handke: Ja, schon, aber ich bin kein Realist. Cervantes ist auch kein
Realist. Die mittelalterlichen Epen sind auch nicht realistisch. Sie
sind märchenhaft, aber märchenhaft in einem schneidenden Sinn. In der
Abwesenheit habe ich den Parzival fast kopiert. Als ich ihn damals
las, dachte ich, das ist die Form, so lässt die Welt sich erzählen,
so, wie ich sie sehe, fühle und vor allem träume. Denken kann man die
Welt eh nicht. Die Abwesenheit ist im Grunde die gekürzte Fassung von
Wolframs Parzival.
ZEIT: Das habe ich, offen gestanden, nicht gemerkt.
Handke: Soll man ja auch nicht. Bei euch in der ZEIT stand neulich ein
Interview mit dem Sekretär der Schwedischen Akademie. Der Herr sagte,
die Literatur habe sich geändert, Fiktion sei zweitrangig geworden.
Ohne Fiktion aber kann man die Literatur abschaffen. Es sind
ehrenwerte Schreiber, die er genannt hat, wie etwa Kapuczynski, der
aufschlussreiche Reportagen schreibt, aber das kann man doch nicht
Literatur nennen. Man darf nicht alles vermischen, das ist skandalös.
Man muss nur eine Seite von einem Buch lesen, und man sieht: Das ist
Sprache oder eben nicht. Sprache, nicht Stil, das ist ein Unterschied.
Sie lesen eine Seite und wissen: endlich Sprache, endlich Zittern,
aber auch die Sprachlosigkeit in der Sprache. Beides.
ZEIT: Kann man das lernen?
Handke: Es ist kein Handwerk. Das kommt später dazu. Aber der Anfang
ist nie mit Handwerk zu schaffen. Ich verstehe nicht, wie man das
Schreiben in Schreibschulen lernen will.
ZEIT: Korrigieren Sie viel?
Handke: Sehr viel. Ich schreibe seit fünfzehn Jahren mit Bleistift –
außer die Theaterstücke, die ich mit der Maschine tippe. Wenn
gesprochen wird, dann muss irgendetwas knallen. Die Prosa schreibe ich
mit Bleistift, und da radiere ich viel. Die Gefahr, mit Bleistift zu
schreiben, besteht darin, dass man in der Stille des Schreibens
vergisst abzusetzen, also Absätze zu machen. Sie hinterher einzufügen
ist nicht gut. Dafür ist die Maschine oder der Computer besser. Aber
die Chance ist eben, dass es eine ganz andere epische Bewegung gibt.
Es spielt auch eine Rolle, dass ich die beiden letzten dicken Bücher,
Die Niemandsbucht und den Bildverlust, oftmals im Freien geschrieben
habe. Im Freien haben sich mir immer wieder neue Räume gezeigt, die
ich nur antupfen musste. Ich habe das als ungeheuer erfreulich
empfunden. Dass es ausschwingen kann in die Räume, die sich im Freien
auftun.
ZEIT: Was war denn die Grundfigur beim Bildverlust? Ich habe das nicht
verstanden.
Handke: Sie haben einen großen Blödsinn darüber geschrieben, so
achtlos, fahrlässig. Bevor Sie kamen heute, habe ich gedacht: Es ist
eigentlich eine Schande, dass dieser Mensch mein Haus betritt. Ich
habe ja immer von Bildern gelebt, von Traumbildern, von Anschauung,
und mit der Zeit bekam ich das Gefühl, dass die Bilder ihre
Gültigkeit, ihre Realität verlieren. Dem wollte ich nachspüren. Ich
erinnerte mich an junge Leute voller Enthusiasmus, voller Unschuld,
denen ich zwanzig Jahre später wieder begegnet bin, und ich sah, dass
diese Begeisterung verschwunden war.
ZEIT: Weil sie älter geworden waren.
Handke: Ja, ich habe mich für Momente wiedererkannt. Es hat mich zu
der Frage gebracht: Wo ist eigentlich die Begeisterung unserer Jugend
geblieben, als wir geschrien haben vor Freude: Wir sind doch alle
aufgebrochen, irgendwohin. Und da habe ich die Geschichte dieser Frau
geschrieben, die die Leute wiederfindet, mit denen sie zusammen war
und deren Begeisterung verschwunden ist, aber vielleicht wieder
geweckt werden kann.
ZEIT: Woher kommen die Kriegsbilder?
Handke: Das hat auch etwas mit Jugoslawien zu tun. Ich hatte die
Vorstellung, dass sich die letzten Menschen da oben im Hochgebirge
sammeln und eine Art Kolonie bilden.
ZEIT: Die Menschen fangen noch einmal von vorn an?
Handke: Ja, die Menschen dort wollen keine Bilder mehr haben, die
Geschichte der Menschheit wird hier wirklich Geschichte. Es geht um
den Konflikt zwischen Bilderglauben und Bildersturm. Ich spüre
manchmal, dass ein neuer Bildersturm an der Zeit wäre. Es geht nicht
so weiter, es ist eine Beleidigung, eine Entseelung, eine
Entleiblichung, was die Bilder mit uns machen. Die Menschen meines
Buchs sind auf der Suche: Wie kann man sich vor den Bildern retten?
ZEIT: Ich als Leser bin verwirrt, weil es in Ihrem Roman keine
Orientierung gibt. Jeder Ort ist zugleich ein anderer.
Handke: Sie sollten nicht sagen: Ich als Leser. Sondern: Der Leser als
Ich. Ja, das glaube ich Ihnen. Wenn Sie Faulkner lesen oder Cervantes,
das ist ab und zu steinig, mühsam. Aber sobald man Vertrauen fasst,
geht man durch die Bewegung hindurch. Das ist Literatur, das ist
Lesen, nicht etwas, was so glatt daherkommt. Ich bemühe mich um
Klarheit, ich möchte nicht dunkel sein. Als ich noch ein junger
Schriftsteller war, stand in irgendeiner Rezension »Der dunkle
Handke«, es hat mir geschmeichelt. Aber das ist lange vorbei. Ich will
Licht sein. Aber ich möchte forschen im Schreiben. Ich will nicht
amerikanisch aufbereitet schreiben. Die deutsche Sprache hat ihr
eigenes Recht, aber auch ihre Schlingen. Wenn man sich ihren
Assoziationen, ihren Klängen völlig hingibt, kann man sich leicht
verlieren. Nicht wenigen Schriftstellern ist das ja passiert.
Andererseits sind wir eben deutschsprachige Schriftsteller, und das
muss man auch merken. Wir können nicht schreiben wie die Amerikaner,
wie die Franzosen. Hätte Eichendorff schreiben sollen wie Flaubert
oder Stendhal?
ZEIT: Eichendorff kann man sich eigentlich in einer anderen Literatur
gar nicht vorstellen.
Handke: Ja, der ist herrlich, die deutsche Literatur hat ihre eigenen
Geschichten, ihren eigenen Fortgang. Das muss man bewahren. Das müssen
Kretins wie ich praktizieren. Und das ist spannend, ist herrlich.
Prosaschreiben ist meine Heimat. Einmal habe ich zwei Jahre lang fast
nur übersetzt. Mit einer bitteren Sehnsucht bin ich zwei Jahre lang um
meinen Schreibtisch herumgeschlichen und dachte, du musst endlich
wieder Prosa schreiben. Aber für mich ist es wichtig, monate- oder
auch mal zwei Jahre lang ohne Schreiben auszukommen, damit Lust und
Bedürfnis sich wieder vereinen.
ZEIT: Ist es nicht so, dass nach langer Pause die Fertigkeit verloren
gehen kann?
Handke: Das nicht, aber eine Geschichte, eine Idee, die man hatte,
kann in dieser Zeit vermodern. Dann kann es passieren, dass man den
Pfingsttag versäumt, um den Anfang zu machen.
ZEIT: Sie haben viele Autoren entdeckt oder wiederentdeckt, Emmanuel
Bove oder Hermann Lenz zum Beispiel.
Handke: Ja, das hatte eine große Wirkung, aber wenn ich heute einen
solchen Autor in der SZ oder der ZEIT vorstellen würde, hätte das fast
keine Wirkung mehr.
ZEIT: Warum?
Handke: Die Aufmerksamkeit ist erschöpft. Die Hinweise auf vergessene
Autoren, die Wiederentdeckungen sind Mode, und der Nutzen wird immer
geringer. Auch habe ich nicht mehr die Stimme wie früher.
ZEIT: Vielleicht liegt das an Ihrer Verteidigung der Serben im
jugoslawischen Krieg.
Handke: Vorsicht, Sie sind hier in meinem Haus.
ZEIT: Ich habe zwar gerade das Messer hier genommen, aber wirklich
nur, um mir ein Stück Käse abzuschneiden.
Handke: Sie werden mich nicht in eine Verteidigung bringen. Ich habe
da nichts zu erklären.
ZEIT: Es gibt viele Buchhandlungen in Österreich, die Ihre Bücher
nicht mehr führen.
Handke: Nicht nur in Österreich, auch in der Schweiz und Deutschland.
Daran seid auch ihr Kritiker schuld. Auf der einen Seite macht ihr im
Feuilleton, wenn ich jetzt mal im Plural reden darf, einen Text wie
den über meinen Besuch bei Milo∆eviƒ oder über meine Reise zu den
Flüchtlingen in Serbien nieder, noch bevor ihr ihn gelesen habt, ihr
blockt ab; und auf der anderen Seite, wenn Gestern unterwegs
erscheint, seid ihr ganz offen und zeigt euch als feine, aufmerksame,
sprachbewusste Leser. Vorher aber habt ihr den Weg zu den Lesern
abgeschnitten, also zu den Buchhandlungen. Die Buchhändler werden
zunehmend moralistisch und gebärden sich als Richter. Eine Bekannte
erzählte mir, sie habe in vier Buchhandlungen gehen müssen, bis sie
endlich Gestern unterwegs erhielt. Ein Buchhändler sagte mir voller
Stolz, er habe alle meine Bücher, als die Winterliche Reise erschien,
aus seinem Laden entfernt.
ZEIT: Das ist idiotisch, das muss ich zugeben, obwohl ich in der Sache
anderer Meinung bin.
Handke: Sie müssen gar nichts zugeben, es geht auch nicht um Meinung.
Meinung haben hat nichts mit Schreiben zu tun. Hat jemals jemand in
einer westlichen Zeitung von den Flüchtlingen, mehr als einer halben
Million, in Serbien erzählt? Nie habe ich etwas darüber gelesen, wie
die vegetieren. Und zum ersten Mal habe ich deren Geschichte erzählt.
Warum geht nicht einer der Reporter der ZEIT, die die Geschichte vom
serbischen Adolf zum siebzigsten Mal als Dossier aufmöbeln, wo doch
die bosnischen Muselmanen und die Kroaten genauso viel Blut am Stecken
haben, zu den serbischen Flüchtlingen? Die kommen aus dem Kosovo, aus
Kroatien, aus Bosnien und werden von den eigenen Landsleuten in
Serbien verachtet. Ich habe darüber geschrieben, ohne irgendeine
Ideologie damit zu verbinden, und ich werde dafür niedergemacht. Zum
ersten Mal kommt einer wie ich nach Srebrenica und erzählt von einer
Mutter, nicht von den Müttern. Ja, es ist ein unverzeihlicher
Racheakt, was die serbische Armee da veranstaltet hat. Aber es ist
eine Rache gewesen an den zerstörten Dörfern rund um Srebrenica. Für
mich habt ihr Deutschen eine große Schuld auf euch geladen, schon mit
der Anerkennung Kroatiens. Euer Herausgeber Joffe hat gesagt, dass das
Wort Auschwitz als Schlagwort verwendet wurde. Aber wer hat damit
angefangen? Es war euer Außenminister Fischer. Scharping hat von KZs
in Prishtina geredet, was ein Unsinn ist. Die Knüppelwörter stammen
von euren Offiziellen. Und die haben den Knüppel benützt, indem sie
den Bombenkrieg mitverantwortet haben.
ZEIT: Es gibt viele Kriege auf der Welt, warum regen Sie sich gerade
über den in Jugoslawien auf?
Handke: Jeder hat sein Land. Der Schriftsteller Péter Esterházy, der
für den Bombenkrieg war, hat gesagt: Ach, dem Peter Handke hat man
sein Spielzeug weggenommen, deswegen ist er so beleidigt. Und der
Esterházy kriegt den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.
Verkehrte Welt. Serbien wurde nie erzählt, und ich habe nur erzählt,
was ich in Serbien gesehen habe.
ZEIT: Mussten Sie den Büchnerpreis zurückgeben?
Handke: Der Büchnerpreis hat ja nichts mit Büchner zu tun, das ist ein
repräsentativer Preis der Bundesrepublik Deutschland.
ZEIT: Was haben Sie gegen die Deutschen?
Handke: Mein Vater war ein Deutscher, er stammte aus einer
Bäckerfamilie im Harz. Ich habe keinen Hass auf Deutschland. Es gibt
viele Deutschlands, das krachlederne Großdeutschland und das
Deutschland der Provinzen, das Deutschland »nebendraußen«, um es mit
einem Wort von Hermann Lenz zu sagen. Das ist mein Deutschland und
wird es bleiben.
ZEIT: Warum sind Sie aus der Kirche ausgetreten?
Handke: Was mich auf die Palme oder vielmehr auf die Serbische Fichte
gebracht hat, war ein Sendschreiben des Bischofs von Amiens. Er hat
den Bombenkrieg gegen Jugoslawien gerechtfertigt mit dem Satz: Wenn
ein Waldbrand herrsche, genüge es nicht, mit dem Eimer zu kommen, man
benötige Löschflugzeuge. Ich scheue mich, mich einen Christen zu
nennen. Aber ich fühle mich in der Nachfolge Christi, ohne dass ich
sein Nachfolger wäre. Er ist für mich die größte Gestalt in der
Geschichte. Der war kein Nazarener, der hatte auch seinen Zorn.
ZEIT: In Gestern unterwegs stößt man immer wieder auf Zitate aus dem
Neuen Testament.
Handke: In der ersten Fassung standen da Seiten um Seiten auf
Griechisch. Ich habe nur weniges übernommen, vor allem, um Lust zu
machen, Griechisch zu lernen. – Es ist fast dunkel geworden, soll ich
ein Licht machen?
ZEIT: Nein, so kann ich besser den Garten sehen, die schöne Zeder.
Handke: Es sind zwei, die eine ist eine Libanon-Zeder, die andere eine
Atlantik-Zeder. Links Libanon, rechts Atlantik. – Machen wir jetzt
Schluss, ich hole noch einen Wein.
Das Gespräch führte Ulrich Greiner
© DIE ZEIT 01.02.2006 Nr.6
AUS DEM ARCHIV
ZEIT 24/1999: Ein lieber Gast
Peter Handke findet in Serbien andersgelbe Nudelnester und redet
seinen Freunden nach dem Mund ...
http://www.zeit.de/1999/24/199924.handke_.xml
ZEIT 16/1999: Kriegsschauplatz Handke
Der Schriftsteller Michael Scharang fürchtet, daß die poltitischen
Attacken auf Handke dessen Werk beschädigen sollen ...
http://www.zeit.de/1999/16/199916.handke_.xml
Due interviste sulla condizione degli sloveni in Italia ed Austria
Sull'argomento del revanscismo italiano e austriaco contro le
rispettive minoranze slovene, riceviamo e giriamo due interviste di
Angelo Floramo a Lipej Kolenik e a Boris Pahor, apparse sull'ultimo
numero di Paginazero (letterature di confine).
Le opinioni qui espresse non sono necessariamente da noi tutte
condivise. Si noti in particolare la posizione molto diversa, tra
Kolenik e Pahor, sulla salvaguardia delle identità nazionali nella
Jugoslavia federativa e socialista, e sulla natura della attuale
Repubblica di Slovenia. (CNJ)
--- LIPEJ KOLENIK ---
Scheda sull'autore
Lipej Kolenik è nato a Šmarjeti pri Pliberku nel 1925. Vive a
Schilterndorf /Cirkovce, un piccolo villaggio della minoranza slovena
in Carinzia. Nel 1943 fu costretto ad arruolarsi nei ranghi
dell'esercito tedesco, e mandato in Italia. Partecipò alle battaglie
di Montecassino e dopo essere rimasto ferito disertò ed entrò a far
parte della Resistenza, combattendo assieme alle bande partigiane che
operavano in Carinzia, coordinandosi con il movimento di liberazione
sloveno. Alla fine della guerra, durante l'occupazione militare
inglese (1945-1955), subì nuove angherie e discriminazioni a motivo
della sua militanza partigiana. Per l'atteggiamento di diffidenza e di
aperta ostilità dimostratogli dalle autorità rimase disoccupato fino
al 1954. La casa Editrice Drava di Klagenfurt ha creduto in lui,
pubblicandogli nel 1988 l'intenso libro di memorie relative agli anni
della guerra: "Mali ljudje na veliki poti", che ormai è già giunto
alla terza edizione, con una traduzione in lingua tedesca, e il più
recente (2004): "Po zmagi - zatiranje in zapori. Spomini na angleško
zasedbeno oblast 1945-1955 Slowenisch", che invece si riferisce agli
anni difficili dell'amministrazione militare inglese della Carinzia.
Uomo di grande cultura e di rara sensibilità è tra gli organizzatori
dell'importante cerimonia che ogni anno, il 17 luglio, riunisce sul
monte Kömmel/Komelj i reduci partigiani che si opposero al nazismo. In
quell'occasione vengono ricordate le vittime di una delle più feroci
repressioni avvenute in Carinzia per mano fascista praticamente a
guerra già conclusa.
Piove. Sono gocce fitte, pesanti, fredde, che appannano i vetri della
macchina. Anche se luglio è appena iniziato qui sembra già autunno. La
strada insegue la Drava, tradendola a tratti per lasciarsi inghiottire
dalle macchie verdi dei tigli, che hanno foglie brillanti come
ramarri. Sono già le due del pomeriggio ma pare che il fiume non si
voglia ancora svegliare dal torpore della notte. Forse per questo
lascia che il buio ristagni in pozze di ombra nelle fosse che
delimitano il suo letto. C'è bruma dappertutto. E' Carinzia, ma
ovunque ti giri è la Slovenia che vedi: nei tetti dei villaggi, nel
modo di costruire le case, per come si raccoglie il fieno sui graticci
di legno. E' terra di confine. Bilingue. Tutto fluttua dall'asprezza
germanica alla rotondità slava: Bleiburg, Edling, Neuhaus, Rinkenberg
diventano più dolci anche sul percorso della mappa: Pliberk, Kazaze,
Suha, Vogrče. Vale per i nomi dei luoghi come per le donne. Hanno
occhi che sanno già d'oriente, direbbe Paolo Rumiz. Segui la Drava e
sconfini senza accorgertene. E ti viene da pensare che un confine
attraversato dal corso di un fiume non è un vero confine. Non lo è per
la geografia. Non dovrebbe esserlo nemmeno per gli uomini. Oltre è
tutta pianura: il Kobansko Pohorje, dolce di campi ben coltivati e
vigneti. Se la mente ne insegue i profumi arrivi a Maribor in un
sorso. Ed è già odore di Ungheria. La magia di queste terre ! Qui
realizzi che il cuore dell'Europa è per forza meticcio, ibridato di
innesti. Ricchissimo di suggestioni, salvato dalle minoranze che si
incuneano dentro i nazionalismi, come i dubbi minano i dogmi e le
certezze. Mi guardo attorno e capisco che ha proprio ragione Peter
Handke quando parla dell'amore che l'uomo slavo nutre per la terra in
cui è nato. Un amore che sa diventare nostalgia o rabbia, furore o
canto. La guerra partigiana, in queste contrade, è stata anche un atto
d'amore per ogni vallata, ogni villaggio, ogni cresta alpina. Questo
dice Handke che è nato a Griffen, sull'altra riva del fiume. Lo
ricordiamo mentre lasciamo il suo villaggio stampigliato per qualche
secondo nello specchietto retrovisore, proseguendo in direzione
Bleiburg/ Pliberk. Non viaggio da solo. Mi accompagna Sara. E' una
giovane donna windisch della Valcanale, nata e cresciuta in una terra
in cui ci si parla in un miscuglio di "theutsch e crainerisch": un
ibrido musicale di tedesco- carinziano e sloveno, un dialetto che
fonde in sé l'anima stessa del confine, trasformando in musica le sue
apparenti dissonanze. Ora sta completando un dottorato di ricerca
all'università di Klagenfurt. Da studentessa ha seguito le lezioni di
Hans Kitzmüller a Udine. Un corso monografico su Handke. Tanto denso
da fare invidia. Da rimpiangere di non averlo frequentato. Mi è
sembrata da subito la guida ideale per questo mio "attraversamento" di
terre, memorie e suggestioni alla ricerca di Lipej Kolenik, nome di
battaglia "Stanko", partigiano e scrittore, uomo da sempre impegnato a
rivendicare la libertà come valore supremo di ogni essere umano.
"Soprattutto una persona gentile". Così lo definisce Helga Mracnikar,
della casa editrice Drava, di Klagenfurt, che ha pubblicato tutti i
suoi libri, agevolandoci il contatto, con rara cortesia e preziosa
disponibilità. Kolenik venne arruolato, in quanto carinziano, nelle
fila della Wehrmacht. Era il 1943. L'anno terribile. Dovette indossare
l'uniforme di quel popolo che stava schiacciando la libertà delle sue
genti. E di infinite altre ancora. Combatté a Montecassino. Poi decise
di disertare. Scelse la lotta partigiana. I morti non sono tutti
uguali. Cirkovce è un villaggio raccolto nell'abbraccio di poche case;
in tedesco lo chiami Schilterndorf , ma il risultato, per quanto forte
lo chiami, non cambia: quasi si nasconde agli occhi dei forestieri. Se
ti sfugge l'imboccatura della strada puoi ripetere il tragitto diverse
volte, da Pliberk ad Aich, prima di trovare la direzione giusta. A noi
è capitato. Piove e non c'è nessuno per strada. Nessuno a cui chiedere
informazioni. Ma una macchina di targa italiana che viaggia a
rallentatore bordeggiando orti, recinti per animali e silos per i
cereali a lungo andare desta curiosità, se non proprio sospetti.
Finalmente qualcuno esce da un ricovero per gli attrezzi: "Chi?
Kolenik lo scrittore? L'altra casa, quella dietro la stalla". Ci sta
aspettando. E siamo incredibilmente puntuali. Lipej. In sloveno Lipa è
il tiglio. L'uomo che ci sta davanti, a suo modo, è proprio un tiglio
sloveno. Lo è davvero, nella mia immaginazione. Un tiglio enorme,
dalle profonde radici, con un tronco solcato dagli anni. Ma la stretta
di mano è generosa, sicura. Un sorriso che non diresti da guerriero,
ma da uomo di pace. La casa è ospitale, coccolata dalla penombra. Il
tavolo della cucina ricoperto di riviste, album di vecchie foto color
seppia, libri glossati, appuntati, sottolineati. Sono aperti o
impilati un po' ovunque. E alle pareti rimbalzano memorie. Attestati.
Riconoscimenti. Non esibiti. Tuttaltro. Lipej Kolenik è uno Sloveno di
confine. Uno Sloveno di Carinzia. Una terra in cui i fremiti
nazionalistici sono molto forti. E il signor Haider, il governatore,
non aiuta certo il dialogo con le minoranze: " Quello? Oh, quello è un
nazista!". Scuote il capo, il partigiano Stanko. Mi chiedo quanto sia
difficile essere sloveni oggi a Cirkovce, che anno dopo anno,
generazione dopo generazione diventa sempre più Schilterndorf. Quando
siamo scesi al bar sulla strada, poco prima di arrivare in paese, alle
nostre domande in sloveno hanno preferito risponderci in tedesco:
abbiamo chiesto se avessero qualcosa da mangiare" Oprostite, imate ze
jesti?" e ci hanno risposto con un certo imbarazzo, quello di chi
vuole tagliare corto: "Nixt ferstien". Già. Incomprensibile. Davvero !
Cosa ha significato per lei appartenere a una minoranza? E' difficile
essere sloveno? E soprattutto lo è stato in passato (penso in
particolare all'epoca nazista, alle camicie brune, alla lunga notte
del Reich) ?
Molte cose sono cambiate, nel corso degli anni. Innanzi tutto la
maggioranza: non lo siamo più, nella nostra terra. Ora apparteniamo a
una minoranza. Che si è sempre più ridotta a partire dagli anni '70.
Il Reich nazista, le persecuzioni, gli arresti, le deportazioni, e poi
la Resistenza: prenda il nostro villaggio, ad esempio. Un centinaio di
case. In passato solo in quattro famiglie parlavano in tedesco. Oggi
chi parla in sloveno si è ridotto a neanche la metà. La scuola qui non
fa nulla per la tutela della lingua. Poi è inutile che la si insegni
come una materia fra le altre. Se non la parli più nemmeno a casa tua,
è finita. I ragazzi migliori se ne vanno. Attratti da città più
grandi. Luoghi lontani, diversi dalla terra in cui sono nati. Nel
periodo nazista era vietato parlare in sloveno. Ovviamente anche a
scuola. I libri. Hanno bruciato i libri. Ci si doveva esprimere in
tedesco. Noi il tedesco non lo conoscevamo affatto. Lo abbiamo
imparato quel tanto che bastava per seguire le lezioni. Tra di noi
parlavamo sempre in sloveno.
C'era un Kulturni Dom qui?
No, non un vero Kulturni Dom... direi piuttosto un'osteria. Il
proprietario ci aveva messo a disposizione una sala in cui ci
incontravamo. Avevamo messo assieme una piccola biblioteca di libri in
sloveno. Potevamo leggere, giocare, studiare. Ma no, non c'era
ovviamente un Kulturni Dom, come quello odierno.
Ma questa chiusura nei confronti degli sloveni esisteva anche prima
dell'Anschluss?
Già prima, già prima. C'era un'associazione di studenti – esiste
ancora oggi – organizzati militarmente. Veniva detta Purschenschaft.
Avevano il compito di "germanizzare queste terre". L'acquisto di
proprietà per cittadini di nazionalità tedesca era facilitato in
queste zone. Hanno iniziato con le buone... poi hanno adottato altri
sistemi. Vorrei aggiungere che la Chiesa ha appoggiato questa
trasformazione, agevolando in tutto l'ascesa di Hitler al potere.
Certo, c'è da dire che nel '43 alcuni preti carinziani hanno sostenuto
la guerra partigiana, ma la maggioranza di loro non faceva più di
tanto. Il Vescovo invece, quello sì era molto attivo: quando nel 1938
è arrivato Hitler ci trovavamo in chiesa. E ci è stato chiesto di
uscire e di seguire il corteo. Una vera azione di propaganda.
C'è una grande similarità fra lei e Boris Pahor, lo scrittore sloveno
triestino che ha raccontato la sua vita e quella della sua comunità
negli anni difficili della guerra, e anche prima, durante il ventennio
fascista, in cui ogni diritto veniva negato alla minoranza slovena, a
ogni minoranza... e poi la sua esperienza partigiana... entrambi avete
toccato, ciascuno a suo modo, gli stessi temi, attraversando percorsi
di vita davvero molto vicini. Vi conoscete personalmente? Ha letto
qualcosa di Pahor ? Cosa vi lega... cosa vi diversifica ?
Certo. Ho letto i libri di Pahor ! Ma le problematiche degli sloveni
in Italia sono molto diverse dalle nostre, qui. Voi eravate meglio
organizzati, come posso dire, vi siete svegliati prima, forse perché
il Fascismo lo avete conosciuto già alla fine della prima Guerra
Mondiale. La Primorska (comunità degli sloveni "del litorale", dunque
oggi in Italia, ndCNJ) ha quindi conosciuto e combattuto il Fascismo
molto prima di noi.
Lo conosce personalmente, Boris Pahor ?
Gli sono stato vicino una volta, durante una conferenza. Ma non ho mai
avuto l'occasione di scambiare qualche parola con lui.
E' interessante che entrambi abbiano avuto esperienze come sloveni di
minoranza, prima nella lotta di opposizione al Nazismo ed al Fascismo
e poi nella letteratura !
Ognuno di noi prende le mosse dalle esperienze che vive in prima
persona. La Storia esiste solo per come noi la sappiamo narrare. Per
questo ho iniziato a pensare che se non avessi scritto le mie
esperienze quella storia sarebbe stata presto dimenticata. Così alla
sera mi capitava di pensare a fatti e momenti della mia vita che
valesse la pena di raccontare. Chiedevo consigli, pareri, opinioni a
chi mi era vicino. Ho letto molto, ho compiuto ricerche personali.
Alla fine di questo lungo percorso sono giunto alla pubblicazione. A
quanto pare è stata una buona idea: il mio libro è ormai giunto alla
terza edizione. Pensi che lo hanno anche pubblicato in tedesco! Chi lo
ha letto lo ha apprezzato.
"Mali ljudje na veliki poti": piccola gente lungo un grande cammino...
un libro intenso, che ha suscitato notevole interesse nei lettori e
nella critica. E non da ultima anche una recensione entusiastica da
parte di Peter Handke. C'è una famiglia di contadini sloveni, a
Šmarjeta... la guerra, combattuta dal protagonista in terra straniera
indossando la divisa tedesca, a Montecassino: la divisa di un regime
che in qualche modo ha sempre soffocato le minoranze, compresa la sua;
e poi la diserzione (o meglio la scelta coraggiosa della verità), la
decisione di aderire alla Resistenza... e ancora tutto l'amore che uno
sloveno prova per la sua terra, i fiumi, l'Alpe, i villaggi... Temi
importanti... a lei molto cari, vicini alla sua biografia... Come si
intrecciano nella sua narrativa ? Nella sua vita ?
La mia esperienza di vita d'allora... beh, da una parte c'era il
Nazismo, dall'altra la Resistenza. Il Nazismo con i suoi
saccheggiatori, i suoi predoni, gli stupratori. Sul fronte opposto i
partigiani. Mi attraeva il mondo della Resistenza, fin da quando avevo
quindici, sedici anni. Avevo contatti con quel mondo fin da allora.
Ben prima di iniziare la lotta al loro fianco. Prima di essere
costretto ad arruolarmi nell'esercito tedesco. Ma non avevo ancora
l'età giusta. Nel 1942 si sono fatti vivi loro. Li abbiamo seguiti in
molti. Nell'estate del '42 ero un soldato. Mi ossessionava il pensiero
di mia madre. Pensavo a quanta paura avesse per me. Per quello che
avrebbe potuto capitarmi. Cosa mi avrebbero fatto, dove mi avrebbero
rinchiuso. Mia madre mi faceva pena. Fu solo l'inizio di una specie di
via crucis. Non è stato per nulla facile. Nel cuore ero antifascista,
mi sentivo vicino ai partigiani. Ma ero costretto a indossare proprio
l'uniforme dei nazisti. Una ribellione che bruciava dentro di me.
Voglio aggiungere che i partigiani qui dovevano cavarsela da soli,
arrangiarsi. Non eravamo organizzati come voi, nella Primorska o in
Slovenia. Ci aiutavamo a vicenda. Ma non c'era nulla che assomigliasse
nemmeno da vicino all'azione di propaganda dell'Osvobodilne Fronte
(Fronte della Liberazione, n.d.r.), che fosse in grado di organizzare
nuove leve per la Resistenza.
Qual è stato il valore della guerra partigiana in questa terra di
frontiera ? Sappiamo molto poco noi italiani dei movimenti
resistenziali in Germania (perché tale era l'Austria dopo l'Anschluss
nel 1938). Cos'ha significato per la sua generazione ? Per lei in
particolare, sloveno e combattente... intendo dire: cosa l'ha motivata
profondamente a scegliere di diventare un partigiano?
Per me è stato un vero e proprio terremoto interiore. Quando hanno
cominciato a deportare le intere famiglie, ad arrestare la gente...
allora abbiamo capito che non potevamo più attendere. Ci saremmo
opposti. Non era più possibile rimanere agli ordini di Hitler. A casa
nostra poi deportavano le persone per metterle nei campi di
concentramento. E' così che è nata la nostra Resistenza. E quelli che
hanno appoggiato le bande partigiane sono stati sempre più numerosi.
Era un modo per salvare la nostra terra. Conoscevamo quella gente fin
dal 1934, fin dai tempi dell' Hitlerputsch. Nel '38 erano sempre loro,
sempre gli stessi fascisti. Loro prima, loro dopo.
Dunque è stata una presa di coscienza matura, una scelta ragionata la
vostra?
Che dire... ho potuto raccogliere tante testimonianze negli anni. La
vita ci insegna. La vita è la nostra scuola. Il Fascismo si svelava
poco alla volta. Ma era possibile capire subito cosa volesse fare
della gente. Avrebbe liquidato tutte quelle persone che non gli
andavano a genio, attraverso uccisioni di massa, arresti... è così che
ha preso forza. Devo dire che alla fine della guerra l'80% della
popolazione dei villaggi, qui, era a favore di un'annessione alla
Jugoslavia. Non credevano che l'Austria ci avrebbe mai potuto dare
altro da quello che ci aveva da sempre elargito: solo promesse e
oppressione.
Ma cosa ha comportato per lei, così giovane, una scelta tanto radicale?
Per prima cosa è stato necessario trovare molto coraggio. E poi una
forte dose di autoconvincimento. Quelli che come me hanno subito
l'oppressione nazista, per quanto ancora molto giovani e privi di
esperienza, si sono lasciati guidare dalle loro coscienze. Ho pensato
a lungo cosa, in questi anni, sia stato maggiormente motivo di
angoscia, per tutti noi. Eravamo considerati dei traditori, quando
abbiamo risposto a Hitler "un fico secco", mettendoci di fatto contro
di lui. Anche la Chiesa ci ha considerato dei traditori, perché
stavamo dalla parte dei "banditi sloveni". Ancora oggi in molti ci
chiamano venduti, traditori dell'Austria. Poco tempo fa, da Vienna, mi
ha chiamato Portisch, quello che sta scrivendo la storia dell'Austria.
Mi ha chiesto perché mai avessimo deciso di combattere sotto la
bandiera di Tito. Gli ho risposto: "Mi dica il nome di un solo
austriaco che in quegli anni sarebbe stato disposto a guidare la lotta
di liberazione contro il Nazismo!". In pochi altri luoghi, come da
noi, si sono raccolti dopo la guerra nazisti fuggitivi provenienti da
molte altre nazioni. Sono stati momenti drammatici, di grande
tensione. Avevamo tutti contro qui: gli Ustaša, i Belagardisti, i
Fascisti... tutti contro di noi. Crede che ora sia cambiato qualcosa?
Non c'è mai stata dopo la guerra una vera e propria
denazistificazione. Non hanno trovato nessun altro da mettere al loro
posto. Così si sono semplicemente cambiati i berretti. Ma le persone
sono rimaste sempre le stesse. E così i loro cervelli. Io non ho mai
avuto una pensione per la mia scelta di libertà. Ma i camerati che
hanno assediato Stalingrado... beh, quelli sì, e anche qualche
menzione ufficiale!
Sono passati 60 anni da allora... come vengono vissuti oggi quei
fatti? In un momento in cui pericolosamente il revisionismo storico
(penso alle tesi dello storico tedesco Ernst Nolte o dell'italiano
Renzo De Felice) porta a riconsiderare gli eventi, a relativizzare il
valore delle scelte di allora, ad insinuare che a diciotto anni una
scelta non può essere consapevole (e quindi in fondo i giovani che
combattevano per i partigiani o per le SS erano uguali, travolti tutti
dalla tragedia della storia)?
Posso dire che oggi guardo con molta preoccupazione allo sviluppo
degli eventi. A sessant'anni di distanza. Sembra che la gente stia
dormendo. Pensi che hanno eretto un monumento agli Ustaša, a
conclusione della guerra. Lo hanno eretto a Lobuški Polje. Arrivano
qui ogni anno da tutte le nazioni quei fuggitivi, quegli assassini, i
macellai di Hitler, per onorarlo. Abbiamo protestato, ma non è servito
a niente. Il monumento è sempre lì. Le autorità dicono che ci
penseranno, ma intanto non prendono provvedimenti. Così ogni anno,
quindicimila, ventimila persone si danno appuntamento sotto quel
monumento. Indossano divise, sventolano bandiere, come ai tempi di
Hitler. E i nostri restano a guardare. Sono convinto che se ci
andassimo noi, lì, con le nostre bandiere... ci arresterebbero subito.
Noi quel periodo lo abbiamo vissuto. Ci siamo dovuti unire in bande. E
abbiamo contribuito a sconfiggere il Nazifascismo. Per noi, per tutti
coloro che si sono ribellati, l'8 maggio è la festa più grande della
Storia. In quel giorno è stato sconfitto il Nazifascismo. L'Austria
non lo celebra volentieri. Ricorda con dispiacere questa ricorrenza.
In fin dei conti ha perso. Qui sentono molto di più le celebrazioni di
ottobre. Ma in realtà non hanno una festa vera e propria. Credono di
essere ancora al comando, come ai tempi di Hitler.
E' dunque così forte il senso di opposizione alla guerra partigiana qui?
E' ancora molto forte. E ogni anno si rinnova. L'anno scorso hanno
diffuso la notizia che alla fine della guerra sono stati uccisi per
rappresaglia 40.000 Ustaša. Ma non è vero. E' una notizia falsa.
Diffusa dall'America ha fatto in breve il giro del mondo. Secondo
questa versione sono stati i partigiani a macchiarsi degli orrori.
Sappia che qui in Carinzia ci sono 53 cimiteri partigiani. Ma mai
nessuna autorità vi ha deposto ufficialmente una corona di fiori. Ce
ne occupiamo noi privati.
Il 17 luglio del 1945 sul monte Kömmel/Komelj i nazisti, a guerra
ormai finita, trucidarono numerosi civili accusati di essere
partigiani. Oggi quella ricorrenza è diventata un appuntamento civile,
di grande urgenza e dignità, celebrato puntualmente ogni anno. Il
valore della memoria si fonda sempre nella sottolineatura della
libertà. E in questo interviene anche la letteratura, intesa come voce
di quella memoria, arte che nobilita quell'impegno. Ce ne vuole parlare?
E' una data importante. Per non dimenticare. Noi che abbiamo vissuto
quella tragedia abbiamo il dovere morale di avvertire gli altri.
Quando l'incendio è divampato è ormai troppo tardi. Non possiamo
dimenticare tutti quei milioni di vittime. È nostro dovere fare in
modo che i giovani non ne perdano la memoria. Solo rimanendo sempre di
sentinella potremo evitare di essere sorpresi per la seconda volta. Da
ogni regione in cui i partigiani hanno combattuto i reduci verranno
qu, sul monte Komelj. Lo scorso anno c'era anche Peter Handke. Lo
ammiro molto perché è una persona semplice innanzi tutto. E poi per il
modo in cui esprime le sue idee: non gli interessa se quello che
scrive può dare fastidio a qualcuno. Spesso mi viene a trovare, come
fosse uno qualsiasi dei miei amici. È stato lui a fare in modo che il
mio libro venisse tradotto. Lo riteneva importante perché questa
storia non fosse dimenticata.
Nel 1943 lei aveva 18 anni... E' stato capace di scegliere. Pensi ai
diciottenni di adesso. Come vivono oggi i giovani della minoranza
slovena di Carinzia ? Le nuove generazioni... Come le vede davanti
alle scelte che l'Europa e il mondo inevitabilmente imporranno loro di
fare ?
Questa è una domanda difficile. La vita oggi è molto diversa da quella
di allora. Oggi la gente è viziata, ha un lavoro, ha di che mangiare.
Cose che non si potevano certo dare per scontato in quegli anni. Per
questo il Fascismo ha potuto diffondersi velocemente. Accade sempre
quando non c'è il pane... E poi perché mai oggi dovrebbero fare una
scelta ? A loro non interessa affatto che il nuovo padrone sia russo o
che sia Hitler o che sia americano. Quello che conta sono i soldi. E
una vita tranquilla.
Esistono dei contatti con la Slovenia ? Vi sentite aiutati in qualche
modo?
Nei confronti della Slovenia nutro una speciale forma di delusione.
Quella non è la terra per la quale ci siamo battuti. Hanno distrutto
la Jugoslavia, che era modello per l'Europa Unita. Uno stato forte che
aveva un certo prestigio a livello internazionale. Capace di rimanere
neutrale e libero dalle politiche dei due blocchi. Oggi sono tutti
divisi, ognuno per conto suo. Non so davvero cosa accadrà. Adesso la
Slovenia è già nell'Unione Europea, tra poco entrerà anche la Croazia,
poi sarà certamente la volta dei Serbi. Quindi tutto tornerà proprio
uguale a prima; ma ci sono dovute essere tante vittime... Questo è ciò
che più spaventa le minoranze. L'Unione europea. Chi non saprà nuotare
in un mare così grande... sarà condannato a sparire per sempre. Gli
aiuti dice? Non ne vediamo, né finanziari né politici.
La scrittura... lei ne ha fatta una ragione di vita. Perché scrivere
? Per l'urgenza di non perdere la memoria, forse?
Allora: la tradizione orale dura a lungo. Ma se scrivi qualcosa, dura
per sempre. Resta! Pensi al plebiscito del 1918. Quanto materiale è
stato raccolto su come abbiano tiranneggiato la gente comune, su come
gli Sloveni siano stati derubati, arrestati? Nessuno ha mai scritto
niente di queste cose. Se solo ci fosse stato uno storico... No, a
dire il vero forse no; perché gli storici scrivono più volentieri
quando oramai non ci sono più superstiti o testimoni vivi. Alle volte
hai quest'impressione. Sai, negli anni vieni a sapere cose che prima
non conoscevi... Festeggiando i sessant'anni dalla fine della guerra,
a Poljane hanno pubblicato un libro, in cui si parla dell'ordine dato
da Tito e Kardelj a Majnik di ritirarsi dalla Carinzia. Invece nel `49
ci spronarono alla lotta per l'annessione. Che senso ha tutto questo?
Noi per averci creduto siamo stati anche rinchiusi, abbiamo subito le
perquisizioni in casa, siamo stati etichettati come Titocomunisti, un
marchio che ci rimane appiccicato addosso ancora oggi. È meglio dire
la verità anche se la strada della verità è sempre più lunga e più
difficile.
In Italia è molto difficile promuovere la diffusione di testi che
provengono dal mondo sloveno. Lo stesso Boris Pahor ha incontrato
molta difficoltà a pubblicare presso un editore italiano. Accade lo
stesso anche in Austria? E quali sono, se ci sono, le possibilità di
vedere finalmente tradotta la sua opera anche in lingua italiana?
Penso che sia una soprattutto questione di soldi. Poi bisogna trovare
qualcuno che crede in quello che stai facendo. A me è successo proprio
con Handke, che mi ha aiutato, e molto: perché se una persona come lui
parla bene di un libro, è già un buon inizio. Così è stata stampata
una prima edizione di "Mali ljudje na veliki poti". Per la seconda
c'erano ancora dei dubbi, non sapevamo se l'opera avrebbe potuto
destare ancora qualche interesse, così ho dovuto aggiungere io dei
soldi. Ma poi il libro è stato pubblicato addirittura per la terza
volta. E' inutile, bisogna fare un po' di pubblicità, vendere il pane
finche è caldo... Il libro che uscirà a novembre si occupa invece
della vita in Carinzia durante l'occupazione Inglese, tra il '45 e il
'55: quanti arresti, quante perquisizioni ! Non ho niente contro gli
inglesi, ma devo dire che qui da noi si sono comportati esattamente
come nelle loro colonie, ne possedevano molte, in mezzo mondo e le
hanno sfruttate... A Bleiburg c'era un poliziotto che indossava la
divisa inglese. Era tedesco ed ebreo, e si accaniva contro i partigiani...
Speriamo che la letteratura possa aiutare la lotta contro le guerre...
Si, ma non sarà di nessun aiuto, se i libri verranno stampati e poi
stivati nei magazzini in pile alte fino ai soffitti. Il loro posto è
qui... devono andare tra la gente...
Kolenik scompare per un attimo dalla nostra vista, per rientrare da
una porta, alle nostre spalle, silenzioso come un partigiano. Ha per
le mani un vassoio di dolcissimi kolaci: "Sono buoni. Li ha fatti mia
figlia!". Una nipotina ogni tanto occhieggia dalla cucina. E' curiosa,
ma troppo timida per fraternizzare. Basta guardarla negli occhi per
capire chi è suo nonno. "Parla lo sloveno?" chiedo temendo una
delusione. "E cos'altro? E' la nostra lingua". La risposta mi
riconcilia anche con la pioggia.
(a cura di Angelo Floramo)
--- BORIS PAHOR ---
Scheda sull'autore
Boris Pahor è nato a Trieste nel 1913, citta in cui ancora oggi vive,
medita e scrive. Laureatosi in Lettere all'università di Padova si è
dedicato all'insegnamento e alla scrittura. Ha pubblicato moltissimo,
e i suoi scritti sono stati tradotti dallo sloveno in francese,
inglese, tedesco e perfino in esperanto, ma in lingua italiana sono
stati editi solamente "Necropoli", Consorzio Culturale del
Monfalconese, Begliano 1997; "Il rogo nel porto", Nicolodi, Rovereto
2001 e "La villa sul lago", Nicolodi, Rovereto 2002. Sempre per i tipi
di Nicolodi è uscito quest'anno "Il petalo giallo" (titolo originale:
"Zibelka sveta", la culla del mondo). Per l'autorevolezza della sua
voce e il valore della sua produzione letteraria è attualmente membro
dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Ljubljana e
Vice-presidente dell'Associazione Internazionale per la difesa delle
lingue e delle culture minoritarie. E' redattore e direttore della
rivista "Zaliv" (il Golfo), che ha sempre dimostrato forte impegno per
la tutela della minoranza slovena e per il processo della
democratizzazione della Slovenia. E' tra gli scrittori candidati al
premio Nobel per la Letteratura.
Anno secondo della rivoluzione fascista. E' una trasparente mattinata
di fine autunno, già quasi in odore d'inverno. L'aula scolastica sa di
gesso e di legno impregnato d'inchiostro. Tutto regolare, non fosse
per Julka. Perché oggi ha occhi umidi di pianto la piccola Julka, che
il maestro si ostina a chiamare Giulia. Il maestro: un omino dai
capelli neri e lucidi come il catrame e il distintivo con il fascio
littorio bene in evidenza all'occhiello della giacca. "Danilo, pej
sem". Tre parole soltanto indirizzate a un compagno. Ma bastano
all'omino del fascio littorio per una condanna senza possibilità di
appello. Siamo nel 1924 e Julka ha parlato in sloveno. Perché nella
sua ignoranza etnica e caparbiamente sciava non ha ancora capito che
si chiama Giulia e che deve parlare in italiano. Non certo in
quell'altra brutta lingua. E' un reato grave, insomma, che offende i
patri confini, e la bandiera, e l'italico suolo. Ora i piccoli piedi
di Julka non toccano terra: rimane sospesa per le lunghe trecce
all'attaccapanni, dove l'omino l'ha trascinata mosso da educativo
furore. Così forse le entrerà in testa che italiani, se non lo si
nasce, lo si diventa. Appesa come un vestito sgualcito Julka sembra
una piccola farfalla dalle ali spiegate. Boris Pahor è il cantore di
questa atroce novella, "La farfalla sull'attaccapanni", ed è il
paradigma di tante altre atrocità, grandi e piccole, di cui egli è
stato testimone, suo malgrado, e che costituiscono la trama di una
prolifica vena letteraria che ancora non si è estinta, visto che
l'autore continua a scrivere, a produrre, a studiare. Le sue
narrazioni si intrecciano alla lunga memoria di una vita altrettanto
lunga, intensa, imprigionata dalle maglie di troppe libertà soffocate,
negate, sottratte. E dal bisogno esistenziale di affermare, al
contrario, il diritto di ogni essere umano alla sua inalienabile
libertà. Questa è la poetica che vivifica la sua letteratura. "Hanno
detto di me che Pahor è tutto memoria del campo di concentramento o
voce della minoranza slovena. Ma non è così. E' un'affermazione
riduttiva. Il valore etico che anima la mia scrittura è l'insofferenza
per la non libertà, di qualunque genere essa sia". Protagonista vigile
e lucidissimo del "secolo breve", sloveno Triestino classe 1913, il
che significa novant'anni indossati con affilata e arguta
intelligenza, Pahor resta ancora quasi del tutto sconosciuto
all'editoria e al mondo intellettuale italiano, che lo hanno
volutamente ignorato, a cominciare da Primo Levi che stroncò fin da
subito "Necropoli", la dolorosa esperienza del campo di concentramento
di Struthof, nei Vosgi, in cui l'autore venne internato dai
nazifascisti nel 1944. Un'opera che rimase anche per questo
totalmente sconosciuta in Italia mentre nel resto d'Europa riscuoteva
ammirati consensi e critiche lusinghiere, che definivano il suo autore
come uno degli scrittori europei più interessanti, certamente la
migliore voce vivente nella lingua di Ljubljana. Ci sono voluti
ventitrè anni e il coraggio del Consorzio Culturale del Monfalconese
perché il romanzo – che nel 1995 vinse il premio Kosovel - uscisse
finalmente anche in lingua italiana. Oggi, per unanime consenso, è
considerato un capolavoro. Eppure ancora Pahor rimane misconosciuto
dalla cultura di casa nostra, sempre più mondana e salottiera, così
poco europea da rischiare la stigmate di un sonnacchioso chic
provincialismo fatto più di mode che di sostanza. Unica gradita
eccezione l'intelligente editore Claudio Nicolodi, che ha recentemente
acquistato i diritti d'autore per l'Opera omnia di Pahor, anche per
quei romanzi (quasi tutti) che ancora non sono stati tradotti in
italiano. E forse ha avuto buon fiuto, dal momento che da più parti
giungono segnalazioni per un Nobel alla letteratura che finalmente
riconosca il valore di questa voce tanto orgogliosa della sua
"minorità". Ma chi è in definitiva Boris Pahor ? Ogni buona antologia
slovena lo pone tra le voci più rappresentative del Novecento. Nel
2001 la Germania ha inserito "Necropoli" a pieno diritto nella famosa
Bestenliste, il prestigioso elenco dei dodici libri più belli
pubblicati nell'anno. La Francia lo adora, lo coccola, lo sente quasi
suo. Gli editori parigini Phébus e Le Rocher hanno pubblicato gran
parte dei suoi lavori. E in Francia partecipa frequentemente a simposi
e pubbliche letture. E' infatti appena rientrato da St. Malo, dove
assieme ad altri 150 scrittori europei, in 3 giorni di intensa
attività, ha vivacemente animato ben cinque tavole rotonde, discutendo
di letteratura, di appartenenza, di lingue minoritarie, di libertà
negate. La rassegna si intitola: "Etonnants voyagers": viaggiatori
meravigliosi. E davvero la vita di Pahor è stata un viaggio
meraviglioso. Perché dolore e meraviglia sono emozioni che fanno
grande l'essere umano, tanto da renderlo capace di letteratura.
"A St. Malo ho parlato del Fascismo, di quello che ha fatto. Dei suoi
tanti crimini che sono spesso stati sottaciuti. E questo per non dare
troppa materia al Comunismo, che in Italia era davvero forte dopo la
seconda guerra mondiale. Per questo hanno preferito che non si
raccontasse mai la verità su quello che i fascisti hanno fatto qui a
Trieste, in Slovenia, in Croazia. E non parlo della guerra, ma del
periodo tra le due guerre mondiali. Ci hanno annientati. Ci hanno
trattato peggio degli schiavi neri. Quelli, almeno, parlavano la loro
lingua, mantenevano le loro tradizioni. A noi hanno negato tutto: la
lingua, la cultura, l'identità. Se parlavi in sloveno per strada a
Trieste in quegli anni rischiavi che qualcuno ti allungasse uno
schiaffo!"
Eppure c'è stato un tempo in cui Trieste era orgogliosa delle sue
molte anime, delle sue differenze...
"No, a Trieste non è mai interessato un granchè delle sue anime. Ci
credevano gli intellettuali come Svevo e Joyce. Ma a Trieste Svevo e
Joyce non sono mai piaciuti davvero. Certo la città aveva un nome
all'estero. Qui i bastimenti andavano e venivano da ogni parte del
mondo. E i commercianti sapevano bene che passare all'Italia avrebbe
significato la morte di tutto questo. Eppure gli irredentisti andavano
dicendo: cresca l'erba nel porto, ma vogliamo Trieste italiana ! Così
noi sloveni e croati abbiamo dovuto soccombere. Le nostre etnie, o per
meglio dire le nostre nazioni, sono state immolate ai sacri confini
della regione orientale. L'Istria era a maggioranza croata, c'è poco
da fare. C'erano gli italiani sulla costa, nessuno dice di no. Ma
l'interno dell'Istria era ed è croato. Noi in quegli anni abbiamo
pagato l'imperialismo interno dell'Italia, lo stesso che si è espresso
all'estero sui Balcani o sulla Libia, lo stesso che Bretoni,
Provenzali e Alsaziani hanno dovuto soffrire in Francia, o i Catalani
sotto il regime di Franco".
Ma come è cominciata a Trieste la persecuzione ?
"Già nel 1920. In quell'anno vennero dati alle fiamme tre centri di
cultura sloveni, uno a Trieste città, uno a Barcola e uno a San
Giovanni, assieme a molti studi di nostri avvocati, a tipografie,
teatri. Ma l'incendio dei centri culturali è stato un atto molto
forte, perché noi sloveni siamo sempre stati legati ai nostri centri
di cultura. In ogni borgo, per quanto piccolo, sorge anche oggi una
kulturni dom. E' questa consapevolezza della nostra identità che ci ha
aiutato a sopravvivere nei secoli. Nel `30, a dieci anni
dall'incendio, Francesco Giunta, uno dei fondatori delle squadre
d'azione triestine, celebrò in un libro l'evento come la prova che la
rivoluzione fascista era nata proprio a Trieste".
Lei ricorda quei momenti nella sua opera Il rogo nel porto. Che
impressione le resta di quei giorni ?
"Ho personalmente vissuto la distruzione del teatro di San Giacomo.
Era la festa di San Nicolò e il Santo, accompagnato di diavoli,
distribuiva piccoli regali ai bambini. Poi sono arrivati i diavoli
veri, quelli con il fez e i manganelli. Avevo sette anni. Ero lì con
mio padre e le mie due sorelline. Hanno gettato tutto dalle
finestre... appiccato il fuoco. Era un teatro coi fiocchi... La città
è rimastra neutra. Ha assistito senza esprimere alcun parere."
E in casa quale clima si era venuto a creare in conseguenza al fatto?
"Mio padre bestemmiava, mia mamma piangeva... e poi piangeva anche
perché mio padre bestemmiava. Era un uomo buonissimo mio padre, ma
quando si scaldava... vendeva burro, miele e ricotta a Ponterosso. Un
mestiere molto duro. D'inverno rischiavi che la bora buttasse tutto in
canale. C'era tanto freddo che mio padre si metteva un giornale sotto
la giacca, per proteggersi in qualche modo dal gelo. E d'estate invece
il burro si scioglieva per il gran calore. Pensi che sotto l'Austria
era fotografo della polizia scientifica. Poi il nuovo governo italiano
pensò bene di allontanare tutti gli amministrativi e lo trasferirono
in Sicilia. Ma mio padre preferì mettersi in pensione. E per vivere
andò ad aiutare mio nonno su questo banco a Ponterosso. Era tenace, ci
teneva alla sua identità. Volle che sulla tomba di famiglia, in
cimitero, ci fosse una croce con su scritto Drusina Pahor, famiglia
Pahor, in sloveno. In quegli anni cambiavano i nomi anche ai morti. Ma
quella croce è rimasta lì... chissà, forse perché non eravamo
importanti, non ci conosceva nessuno e così nemmeno la notarono".
Lei allora era un ragazzino...
"Ho vissuto malissimo quegli anni. Il passaggio alla classe quinta
elementare è stato drammatico. Dopo quattro anni di scuola in sloveno
dover diventare improvvisamente italiano... E' stato un disastro
completo. Ovviamente andavo malissimo a scuola. E mio padre lo visse
come un fallimento personale. Tanto che qualcuno suggerì in famiglia
di farmi entrare in seminario. Fui mandato così a Koper, Capodistria.
Una città istriana, ma abitata da lattaie e contadine croate e
slovene, come Gorizia, come Trieste. E qui ho incontrato moltissimi
altri giovani croati e sloveni, come me. Sono stati anni
importantissimi. Ho preso coscienza di me stesso. Mi sono ricostruito
psicologicamente. Ma non era certo la mia strada, quella del
seminario. Così dopo altri due anni di teologia sono uscito e appena
fuori mi hanno arruolato: era la Campagna di Libia. Un'esperienza
strana. Facevo il militare per una nazione che voleva annullare la mia
identità. Ho combattuto per quella Nazione e ho guadagnato anche due
medaglie".
E' una situazione paradossale davvero: scommetto che sulle medaglie
l'iscrizione non era in lingua slovena !
"Oh no ! Ma ero contento, in un certo senso, di essere lontano dal
groviglio Triestino. Il deserto poi mi suggeriva una vastezza di
orizzonti che non avevo mai potuto vivere prima. E gli arabi: li
sentivo a me molto vicini, una nazione oppressa dall'Italia, come lo
era anche la mia nazione. Dall'esperienza di quegli anni è nato un
libro: "Nomadi senza oasi". E poi in Libia ho potuto prendere il
diploma di maturità classica, al liceo Carducci di Bengasi. Mi ero
portato dietro tutti i libri che potevo, infilandoli in ogni tasca
disponibile. Il mio comandante infatti non mi poteva sopportare. Era
uno che aveva combattuto in Spagna per Franco... e dal momento che io
non mi interessavo proprio ai suoi cannoni, mi aveva fatto lasciare
gran parte dei miei libri a Tripoli... per ripicca".
Beh, un fatto singolare... uno sloveno che in Libia consegue la
maturità classica in un Liceo Italiano !
"E' stata una specie di riscatto. Dei trentacinque ufficiali italiani
che hanno sostenuto l'esame ne sono stati promossi soltanto sei. E tra
quelli l'unico otto in italiano è stato il mio, quello di Boris Pahor,
sloveno triestino!".
E poi l'esperienza terribile del campo di concentramento, dalla quale
nasce il romanzo Necropoli...
"Le mie simpatie per i partigiani erano evidenti. Assieme ad altri
avevo costituito nel 1944 un comitato triestino di opposizione ai
nazifascisti. Ma una settimana dopo ero già nelle loro mani. Trovarono
in casa mia dei documenti compromettenti. Avevo scritto da qualche
parte che i nazisti si sarebbero rotti la testa sulle scogliere di
Trieste. Questo è bastato. Era il 28 febbraio del 1944. Assieme a me
sono partiti altri seicento disgraziati come me".
Ma la sua voce è sempre stata pronta a condannare ogni tipo di non
libertà, da qualunque parte venisse l'oppressione...
"La mia letteratura si è sempre interessata alle storie semplici della
povera gente. La mia poetica è e resterà l'insofferenza per la
mancanza di libertà. Sono stato sempre un non allineato. Per questo
non ho mai riscosso grandi simpatie, né da una parte né dall'altra. La
lotta di liberazione partigiana è stata pluralistica, animata da un
fortissimo valore etico: comunisti, liberali e cristiano sociali hanno
lottato assieme per la libertà. Poi le cose sono cambiate. Pensi a
quello che è accaduto a Edvard Kocbek: un cristiano sociale che ha
combattuto assieme a Tito, un intellettuale di grande levatura e
apertura culturale, autore tra l'altro di un libro importantissimo e
non adeguatamente valorizzato, La Compagnia (ed. Cseo, Bologna 1979,
n.d.r.), che andrebbe rivalutato; uno che è diventato vicepresidente
del Parlamento iugoslavo... beh, è stato liquidato politicamente
perché non allineato con le scelte della Iugoslavia di allora. E gli
eccidi compiuti nel '45 contro gente disarmata non possono essere
considerati lotta di liberazione ! Io non potevo non pronunciarmi su
tutto questo. Per questo la mia è ancora oggi considerata una voce
scomoda."
E poi la fine della guerra, il ritorno a casa...
"E ancora il dramma della non libertà: in quegli anni Trieste, oltre a
Berlino, è il luogo in cui si è giocato con maggiore ferocia lo
scontro tra Oriente e Occidente. Due delle opere che compongono la mia
trilogia, come l'hanno chiamata i critici, "Labirinto" e "Primavera
difficile" (la terza opera della trilogia è "Oscuramento"; nessuna
delle tre è ancora stata tradotta in italiano, n.d.r.), sono
ambientate in quegli anni così difficili. Si parla di un amore
contrastato, della malattia di TBC contratta dal protagonista, delle
difficoltà di adattamento di un ex deportato".
Dunque ancora gabbie, ancora confini. Confini che forse l'Europa che
sta nascendo potrà cancellare. Crede che l'Europa unita, di cui anche
la Slovenia entrerà a far parte, permetterà di abbattere queste
barriere ?
"Il Presidente della Repubblica Slovena mi ha invitato a partecipare
come ospite gradito alla celebrazione della festa dell'Indipendenza
della Repubblica, il 25 giugno scorso. Ma non ci sono andato perché la
comunicazione mi è giunta troppo tardi. La lettera ci ha messo sette
giorni per arrivare da Ljubljana a Trieste. Sette giorni per
attraversare una distanza di sessanta chilometri. Come vede l'Europa
dei confini resta".
E la Slovenia, cosa potrà portare all'Europa ?
"Per prima cosa l'esempio di come si possa restare fedeli alla propria
identità senza armate, senza generali e senza ammiragli. Un'identità
bastata sulla cultura. E questo gli sloveni hanno imparato a farlo
sopravvivendo a una storia che da sempre ha cercato di assorbirli, di
omologarli: prima la germanizzazione dell'Impero Asburgico, poi il
Fascismo e l'Italianizzazione forzata e infine gli anni iugoslavi,
serbizzanti, orientalizzanti. L'internazionalismo di Tito è sempre
stato contrario alla salvaguardia delle identità nazionali. Una
posizione molto lontana da quella del Partito Comunista Italiano, che
appunto è sempre stato fiero della sua identità nazionale: prima
comunisti ma poi anche italiani. E poi la Slovenia ha una grande
tradizione letteraria. Una letteratura di valore, per quanto
espressione di un piccolo popolo, è sempre motivo di ricchezza per
tutti".
E dedicandosi a questa ricchezza lei continua a pensare, a scrivere, a
raccontare...
"L'ultimo libro che ho scritto si intitola "Zibelka sveta", la Culla
del mondo, che in Francia è stato edito da Le Rocher nel 2002. Qui in
Italia è edito da Nicolodi. E' uscito quest'anno con il titolo: "Il
petalo giallo". E' la storia di un incesto perpetrato per anni da un
padre sulla propria figlia. La protagonista si innamorerà di un
sessantenne sopravvissuto ai campi di sterminio. E i loro dolori, le
loro prigionie, così diverse ma tanto simili, si incontreranno nella
ricerca di se stessi attraverso un sentimento molto forte che dalla
conoscenza passa alla convivenza, quindi alla comprensione per
sbocciare infine nell'amore".
La donna che redime il dolore attraverso l'amore dunque ?
"La donna è la culla del mondo".
(a cura di Angelo Floramo)
Sull'argomento del revanscismo italiano e austriaco contro le
rispettive minoranze slovene, riceviamo e giriamo due interviste di
Angelo Floramo a Lipej Kolenik e a Boris Pahor, apparse sull'ultimo
numero di Paginazero (letterature di confine).
Le opinioni qui espresse non sono necessariamente da noi tutte
condivise. Si noti in particolare la posizione molto diversa, tra
Kolenik e Pahor, sulla salvaguardia delle identità nazionali nella
Jugoslavia federativa e socialista, e sulla natura della attuale
Repubblica di Slovenia. (CNJ)
--- LIPEJ KOLENIK ---
Scheda sull'autore
Lipej Kolenik è nato a Šmarjeti pri Pliberku nel 1925. Vive a
Schilterndorf /Cirkovce, un piccolo villaggio della minoranza slovena
in Carinzia. Nel 1943 fu costretto ad arruolarsi nei ranghi
dell'esercito tedesco, e mandato in Italia. Partecipò alle battaglie
di Montecassino e dopo essere rimasto ferito disertò ed entrò a far
parte della Resistenza, combattendo assieme alle bande partigiane che
operavano in Carinzia, coordinandosi con il movimento di liberazione
sloveno. Alla fine della guerra, durante l'occupazione militare
inglese (1945-1955), subì nuove angherie e discriminazioni a motivo
della sua militanza partigiana. Per l'atteggiamento di diffidenza e di
aperta ostilità dimostratogli dalle autorità rimase disoccupato fino
al 1954. La casa Editrice Drava di Klagenfurt ha creduto in lui,
pubblicandogli nel 1988 l'intenso libro di memorie relative agli anni
della guerra: "Mali ljudje na veliki poti", che ormai è già giunto
alla terza edizione, con una traduzione in lingua tedesca, e il più
recente (2004): "Po zmagi - zatiranje in zapori. Spomini na angleško
zasedbeno oblast 1945-1955 Slowenisch", che invece si riferisce agli
anni difficili dell'amministrazione militare inglese della Carinzia.
Uomo di grande cultura e di rara sensibilità è tra gli organizzatori
dell'importante cerimonia che ogni anno, il 17 luglio, riunisce sul
monte Kömmel/Komelj i reduci partigiani che si opposero al nazismo. In
quell'occasione vengono ricordate le vittime di una delle più feroci
repressioni avvenute in Carinzia per mano fascista praticamente a
guerra già conclusa.
Piove. Sono gocce fitte, pesanti, fredde, che appannano i vetri della
macchina. Anche se luglio è appena iniziato qui sembra già autunno. La
strada insegue la Drava, tradendola a tratti per lasciarsi inghiottire
dalle macchie verdi dei tigli, che hanno foglie brillanti come
ramarri. Sono già le due del pomeriggio ma pare che il fiume non si
voglia ancora svegliare dal torpore della notte. Forse per questo
lascia che il buio ristagni in pozze di ombra nelle fosse che
delimitano il suo letto. C'è bruma dappertutto. E' Carinzia, ma
ovunque ti giri è la Slovenia che vedi: nei tetti dei villaggi, nel
modo di costruire le case, per come si raccoglie il fieno sui graticci
di legno. E' terra di confine. Bilingue. Tutto fluttua dall'asprezza
germanica alla rotondità slava: Bleiburg, Edling, Neuhaus, Rinkenberg
diventano più dolci anche sul percorso della mappa: Pliberk, Kazaze,
Suha, Vogrče. Vale per i nomi dei luoghi come per le donne. Hanno
occhi che sanno già d'oriente, direbbe Paolo Rumiz. Segui la Drava e
sconfini senza accorgertene. E ti viene da pensare che un confine
attraversato dal corso di un fiume non è un vero confine. Non lo è per
la geografia. Non dovrebbe esserlo nemmeno per gli uomini. Oltre è
tutta pianura: il Kobansko Pohorje, dolce di campi ben coltivati e
vigneti. Se la mente ne insegue i profumi arrivi a Maribor in un
sorso. Ed è già odore di Ungheria. La magia di queste terre ! Qui
realizzi che il cuore dell'Europa è per forza meticcio, ibridato di
innesti. Ricchissimo di suggestioni, salvato dalle minoranze che si
incuneano dentro i nazionalismi, come i dubbi minano i dogmi e le
certezze. Mi guardo attorno e capisco che ha proprio ragione Peter
Handke quando parla dell'amore che l'uomo slavo nutre per la terra in
cui è nato. Un amore che sa diventare nostalgia o rabbia, furore o
canto. La guerra partigiana, in queste contrade, è stata anche un atto
d'amore per ogni vallata, ogni villaggio, ogni cresta alpina. Questo
dice Handke che è nato a Griffen, sull'altra riva del fiume. Lo
ricordiamo mentre lasciamo il suo villaggio stampigliato per qualche
secondo nello specchietto retrovisore, proseguendo in direzione
Bleiburg/ Pliberk. Non viaggio da solo. Mi accompagna Sara. E' una
giovane donna windisch della Valcanale, nata e cresciuta in una terra
in cui ci si parla in un miscuglio di "theutsch e crainerisch": un
ibrido musicale di tedesco- carinziano e sloveno, un dialetto che
fonde in sé l'anima stessa del confine, trasformando in musica le sue
apparenti dissonanze. Ora sta completando un dottorato di ricerca
all'università di Klagenfurt. Da studentessa ha seguito le lezioni di
Hans Kitzmüller a Udine. Un corso monografico su Handke. Tanto denso
da fare invidia. Da rimpiangere di non averlo frequentato. Mi è
sembrata da subito la guida ideale per questo mio "attraversamento" di
terre, memorie e suggestioni alla ricerca di Lipej Kolenik, nome di
battaglia "Stanko", partigiano e scrittore, uomo da sempre impegnato a
rivendicare la libertà come valore supremo di ogni essere umano.
"Soprattutto una persona gentile". Così lo definisce Helga Mracnikar,
della casa editrice Drava, di Klagenfurt, che ha pubblicato tutti i
suoi libri, agevolandoci il contatto, con rara cortesia e preziosa
disponibilità. Kolenik venne arruolato, in quanto carinziano, nelle
fila della Wehrmacht. Era il 1943. L'anno terribile. Dovette indossare
l'uniforme di quel popolo che stava schiacciando la libertà delle sue
genti. E di infinite altre ancora. Combatté a Montecassino. Poi decise
di disertare. Scelse la lotta partigiana. I morti non sono tutti
uguali. Cirkovce è un villaggio raccolto nell'abbraccio di poche case;
in tedesco lo chiami Schilterndorf , ma il risultato, per quanto forte
lo chiami, non cambia: quasi si nasconde agli occhi dei forestieri. Se
ti sfugge l'imboccatura della strada puoi ripetere il tragitto diverse
volte, da Pliberk ad Aich, prima di trovare la direzione giusta. A noi
è capitato. Piove e non c'è nessuno per strada. Nessuno a cui chiedere
informazioni. Ma una macchina di targa italiana che viaggia a
rallentatore bordeggiando orti, recinti per animali e silos per i
cereali a lungo andare desta curiosità, se non proprio sospetti.
Finalmente qualcuno esce da un ricovero per gli attrezzi: "Chi?
Kolenik lo scrittore? L'altra casa, quella dietro la stalla". Ci sta
aspettando. E siamo incredibilmente puntuali. Lipej. In sloveno Lipa è
il tiglio. L'uomo che ci sta davanti, a suo modo, è proprio un tiglio
sloveno. Lo è davvero, nella mia immaginazione. Un tiglio enorme,
dalle profonde radici, con un tronco solcato dagli anni. Ma la stretta
di mano è generosa, sicura. Un sorriso che non diresti da guerriero,
ma da uomo di pace. La casa è ospitale, coccolata dalla penombra. Il
tavolo della cucina ricoperto di riviste, album di vecchie foto color
seppia, libri glossati, appuntati, sottolineati. Sono aperti o
impilati un po' ovunque. E alle pareti rimbalzano memorie. Attestati.
Riconoscimenti. Non esibiti. Tuttaltro. Lipej Kolenik è uno Sloveno di
confine. Uno Sloveno di Carinzia. Una terra in cui i fremiti
nazionalistici sono molto forti. E il signor Haider, il governatore,
non aiuta certo il dialogo con le minoranze: " Quello? Oh, quello è un
nazista!". Scuote il capo, il partigiano Stanko. Mi chiedo quanto sia
difficile essere sloveni oggi a Cirkovce, che anno dopo anno,
generazione dopo generazione diventa sempre più Schilterndorf. Quando
siamo scesi al bar sulla strada, poco prima di arrivare in paese, alle
nostre domande in sloveno hanno preferito risponderci in tedesco:
abbiamo chiesto se avessero qualcosa da mangiare" Oprostite, imate ze
jesti?" e ci hanno risposto con un certo imbarazzo, quello di chi
vuole tagliare corto: "Nixt ferstien". Già. Incomprensibile. Davvero !
Cosa ha significato per lei appartenere a una minoranza? E' difficile
essere sloveno? E soprattutto lo è stato in passato (penso in
particolare all'epoca nazista, alle camicie brune, alla lunga notte
del Reich) ?
Molte cose sono cambiate, nel corso degli anni. Innanzi tutto la
maggioranza: non lo siamo più, nella nostra terra. Ora apparteniamo a
una minoranza. Che si è sempre più ridotta a partire dagli anni '70.
Il Reich nazista, le persecuzioni, gli arresti, le deportazioni, e poi
la Resistenza: prenda il nostro villaggio, ad esempio. Un centinaio di
case. In passato solo in quattro famiglie parlavano in tedesco. Oggi
chi parla in sloveno si è ridotto a neanche la metà. La scuola qui non
fa nulla per la tutela della lingua. Poi è inutile che la si insegni
come una materia fra le altre. Se non la parli più nemmeno a casa tua,
è finita. I ragazzi migliori se ne vanno. Attratti da città più
grandi. Luoghi lontani, diversi dalla terra in cui sono nati. Nel
periodo nazista era vietato parlare in sloveno. Ovviamente anche a
scuola. I libri. Hanno bruciato i libri. Ci si doveva esprimere in
tedesco. Noi il tedesco non lo conoscevamo affatto. Lo abbiamo
imparato quel tanto che bastava per seguire le lezioni. Tra di noi
parlavamo sempre in sloveno.
C'era un Kulturni Dom qui?
No, non un vero Kulturni Dom... direi piuttosto un'osteria. Il
proprietario ci aveva messo a disposizione una sala in cui ci
incontravamo. Avevamo messo assieme una piccola biblioteca di libri in
sloveno. Potevamo leggere, giocare, studiare. Ma no, non c'era
ovviamente un Kulturni Dom, come quello odierno.
Ma questa chiusura nei confronti degli sloveni esisteva anche prima
dell'Anschluss?
Già prima, già prima. C'era un'associazione di studenti – esiste
ancora oggi – organizzati militarmente. Veniva detta Purschenschaft.
Avevano il compito di "germanizzare queste terre". L'acquisto di
proprietà per cittadini di nazionalità tedesca era facilitato in
queste zone. Hanno iniziato con le buone... poi hanno adottato altri
sistemi. Vorrei aggiungere che la Chiesa ha appoggiato questa
trasformazione, agevolando in tutto l'ascesa di Hitler al potere.
Certo, c'è da dire che nel '43 alcuni preti carinziani hanno sostenuto
la guerra partigiana, ma la maggioranza di loro non faceva più di
tanto. Il Vescovo invece, quello sì era molto attivo: quando nel 1938
è arrivato Hitler ci trovavamo in chiesa. E ci è stato chiesto di
uscire e di seguire il corteo. Una vera azione di propaganda.
C'è una grande similarità fra lei e Boris Pahor, lo scrittore sloveno
triestino che ha raccontato la sua vita e quella della sua comunità
negli anni difficili della guerra, e anche prima, durante il ventennio
fascista, in cui ogni diritto veniva negato alla minoranza slovena, a
ogni minoranza... e poi la sua esperienza partigiana... entrambi avete
toccato, ciascuno a suo modo, gli stessi temi, attraversando percorsi
di vita davvero molto vicini. Vi conoscete personalmente? Ha letto
qualcosa di Pahor ? Cosa vi lega... cosa vi diversifica ?
Certo. Ho letto i libri di Pahor ! Ma le problematiche degli sloveni
in Italia sono molto diverse dalle nostre, qui. Voi eravate meglio
organizzati, come posso dire, vi siete svegliati prima, forse perché
il Fascismo lo avete conosciuto già alla fine della prima Guerra
Mondiale. La Primorska (comunità degli sloveni "del litorale", dunque
oggi in Italia, ndCNJ) ha quindi conosciuto e combattuto il Fascismo
molto prima di noi.
Lo conosce personalmente, Boris Pahor ?
Gli sono stato vicino una volta, durante una conferenza. Ma non ho mai
avuto l'occasione di scambiare qualche parola con lui.
E' interessante che entrambi abbiano avuto esperienze come sloveni di
minoranza, prima nella lotta di opposizione al Nazismo ed al Fascismo
e poi nella letteratura !
Ognuno di noi prende le mosse dalle esperienze che vive in prima
persona. La Storia esiste solo per come noi la sappiamo narrare. Per
questo ho iniziato a pensare che se non avessi scritto le mie
esperienze quella storia sarebbe stata presto dimenticata. Così alla
sera mi capitava di pensare a fatti e momenti della mia vita che
valesse la pena di raccontare. Chiedevo consigli, pareri, opinioni a
chi mi era vicino. Ho letto molto, ho compiuto ricerche personali.
Alla fine di questo lungo percorso sono giunto alla pubblicazione. A
quanto pare è stata una buona idea: il mio libro è ormai giunto alla
terza edizione. Pensi che lo hanno anche pubblicato in tedesco! Chi lo
ha letto lo ha apprezzato.
"Mali ljudje na veliki poti": piccola gente lungo un grande cammino...
un libro intenso, che ha suscitato notevole interesse nei lettori e
nella critica. E non da ultima anche una recensione entusiastica da
parte di Peter Handke. C'è una famiglia di contadini sloveni, a
Šmarjeta... la guerra, combattuta dal protagonista in terra straniera
indossando la divisa tedesca, a Montecassino: la divisa di un regime
che in qualche modo ha sempre soffocato le minoranze, compresa la sua;
e poi la diserzione (o meglio la scelta coraggiosa della verità), la
decisione di aderire alla Resistenza... e ancora tutto l'amore che uno
sloveno prova per la sua terra, i fiumi, l'Alpe, i villaggi... Temi
importanti... a lei molto cari, vicini alla sua biografia... Come si
intrecciano nella sua narrativa ? Nella sua vita ?
La mia esperienza di vita d'allora... beh, da una parte c'era il
Nazismo, dall'altra la Resistenza. Il Nazismo con i suoi
saccheggiatori, i suoi predoni, gli stupratori. Sul fronte opposto i
partigiani. Mi attraeva il mondo della Resistenza, fin da quando avevo
quindici, sedici anni. Avevo contatti con quel mondo fin da allora.
Ben prima di iniziare la lotta al loro fianco. Prima di essere
costretto ad arruolarmi nell'esercito tedesco. Ma non avevo ancora
l'età giusta. Nel 1942 si sono fatti vivi loro. Li abbiamo seguiti in
molti. Nell'estate del '42 ero un soldato. Mi ossessionava il pensiero
di mia madre. Pensavo a quanta paura avesse per me. Per quello che
avrebbe potuto capitarmi. Cosa mi avrebbero fatto, dove mi avrebbero
rinchiuso. Mia madre mi faceva pena. Fu solo l'inizio di una specie di
via crucis. Non è stato per nulla facile. Nel cuore ero antifascista,
mi sentivo vicino ai partigiani. Ma ero costretto a indossare proprio
l'uniforme dei nazisti. Una ribellione che bruciava dentro di me.
Voglio aggiungere che i partigiani qui dovevano cavarsela da soli,
arrangiarsi. Non eravamo organizzati come voi, nella Primorska o in
Slovenia. Ci aiutavamo a vicenda. Ma non c'era nulla che assomigliasse
nemmeno da vicino all'azione di propaganda dell'Osvobodilne Fronte
(Fronte della Liberazione, n.d.r.), che fosse in grado di organizzare
nuove leve per la Resistenza.
Qual è stato il valore della guerra partigiana in questa terra di
frontiera ? Sappiamo molto poco noi italiani dei movimenti
resistenziali in Germania (perché tale era l'Austria dopo l'Anschluss
nel 1938). Cos'ha significato per la sua generazione ? Per lei in
particolare, sloveno e combattente... intendo dire: cosa l'ha motivata
profondamente a scegliere di diventare un partigiano?
Per me è stato un vero e proprio terremoto interiore. Quando hanno
cominciato a deportare le intere famiglie, ad arrestare la gente...
allora abbiamo capito che non potevamo più attendere. Ci saremmo
opposti. Non era più possibile rimanere agli ordini di Hitler. A casa
nostra poi deportavano le persone per metterle nei campi di
concentramento. E' così che è nata la nostra Resistenza. E quelli che
hanno appoggiato le bande partigiane sono stati sempre più numerosi.
Era un modo per salvare la nostra terra. Conoscevamo quella gente fin
dal 1934, fin dai tempi dell' Hitlerputsch. Nel '38 erano sempre loro,
sempre gli stessi fascisti. Loro prima, loro dopo.
Dunque è stata una presa di coscienza matura, una scelta ragionata la
vostra?
Che dire... ho potuto raccogliere tante testimonianze negli anni. La
vita ci insegna. La vita è la nostra scuola. Il Fascismo si svelava
poco alla volta. Ma era possibile capire subito cosa volesse fare
della gente. Avrebbe liquidato tutte quelle persone che non gli
andavano a genio, attraverso uccisioni di massa, arresti... è così che
ha preso forza. Devo dire che alla fine della guerra l'80% della
popolazione dei villaggi, qui, era a favore di un'annessione alla
Jugoslavia. Non credevano che l'Austria ci avrebbe mai potuto dare
altro da quello che ci aveva da sempre elargito: solo promesse e
oppressione.
Ma cosa ha comportato per lei, così giovane, una scelta tanto radicale?
Per prima cosa è stato necessario trovare molto coraggio. E poi una
forte dose di autoconvincimento. Quelli che come me hanno subito
l'oppressione nazista, per quanto ancora molto giovani e privi di
esperienza, si sono lasciati guidare dalle loro coscienze. Ho pensato
a lungo cosa, in questi anni, sia stato maggiormente motivo di
angoscia, per tutti noi. Eravamo considerati dei traditori, quando
abbiamo risposto a Hitler "un fico secco", mettendoci di fatto contro
di lui. Anche la Chiesa ci ha considerato dei traditori, perché
stavamo dalla parte dei "banditi sloveni". Ancora oggi in molti ci
chiamano venduti, traditori dell'Austria. Poco tempo fa, da Vienna, mi
ha chiamato Portisch, quello che sta scrivendo la storia dell'Austria.
Mi ha chiesto perché mai avessimo deciso di combattere sotto la
bandiera di Tito. Gli ho risposto: "Mi dica il nome di un solo
austriaco che in quegli anni sarebbe stato disposto a guidare la lotta
di liberazione contro il Nazismo!". In pochi altri luoghi, come da
noi, si sono raccolti dopo la guerra nazisti fuggitivi provenienti da
molte altre nazioni. Sono stati momenti drammatici, di grande
tensione. Avevamo tutti contro qui: gli Ustaša, i Belagardisti, i
Fascisti... tutti contro di noi. Crede che ora sia cambiato qualcosa?
Non c'è mai stata dopo la guerra una vera e propria
denazistificazione. Non hanno trovato nessun altro da mettere al loro
posto. Così si sono semplicemente cambiati i berretti. Ma le persone
sono rimaste sempre le stesse. E così i loro cervelli. Io non ho mai
avuto una pensione per la mia scelta di libertà. Ma i camerati che
hanno assediato Stalingrado... beh, quelli sì, e anche qualche
menzione ufficiale!
Sono passati 60 anni da allora... come vengono vissuti oggi quei
fatti? In un momento in cui pericolosamente il revisionismo storico
(penso alle tesi dello storico tedesco Ernst Nolte o dell'italiano
Renzo De Felice) porta a riconsiderare gli eventi, a relativizzare il
valore delle scelte di allora, ad insinuare che a diciotto anni una
scelta non può essere consapevole (e quindi in fondo i giovani che
combattevano per i partigiani o per le SS erano uguali, travolti tutti
dalla tragedia della storia)?
Posso dire che oggi guardo con molta preoccupazione allo sviluppo
degli eventi. A sessant'anni di distanza. Sembra che la gente stia
dormendo. Pensi che hanno eretto un monumento agli Ustaša, a
conclusione della guerra. Lo hanno eretto a Lobuški Polje. Arrivano
qui ogni anno da tutte le nazioni quei fuggitivi, quegli assassini, i
macellai di Hitler, per onorarlo. Abbiamo protestato, ma non è servito
a niente. Il monumento è sempre lì. Le autorità dicono che ci
penseranno, ma intanto non prendono provvedimenti. Così ogni anno,
quindicimila, ventimila persone si danno appuntamento sotto quel
monumento. Indossano divise, sventolano bandiere, come ai tempi di
Hitler. E i nostri restano a guardare. Sono convinto che se ci
andassimo noi, lì, con le nostre bandiere... ci arresterebbero subito.
Noi quel periodo lo abbiamo vissuto. Ci siamo dovuti unire in bande. E
abbiamo contribuito a sconfiggere il Nazifascismo. Per noi, per tutti
coloro che si sono ribellati, l'8 maggio è la festa più grande della
Storia. In quel giorno è stato sconfitto il Nazifascismo. L'Austria
non lo celebra volentieri. Ricorda con dispiacere questa ricorrenza.
In fin dei conti ha perso. Qui sentono molto di più le celebrazioni di
ottobre. Ma in realtà non hanno una festa vera e propria. Credono di
essere ancora al comando, come ai tempi di Hitler.
E' dunque così forte il senso di opposizione alla guerra partigiana qui?
E' ancora molto forte. E ogni anno si rinnova. L'anno scorso hanno
diffuso la notizia che alla fine della guerra sono stati uccisi per
rappresaglia 40.000 Ustaša. Ma non è vero. E' una notizia falsa.
Diffusa dall'America ha fatto in breve il giro del mondo. Secondo
questa versione sono stati i partigiani a macchiarsi degli orrori.
Sappia che qui in Carinzia ci sono 53 cimiteri partigiani. Ma mai
nessuna autorità vi ha deposto ufficialmente una corona di fiori. Ce
ne occupiamo noi privati.
Il 17 luglio del 1945 sul monte Kömmel/Komelj i nazisti, a guerra
ormai finita, trucidarono numerosi civili accusati di essere
partigiani. Oggi quella ricorrenza è diventata un appuntamento civile,
di grande urgenza e dignità, celebrato puntualmente ogni anno. Il
valore della memoria si fonda sempre nella sottolineatura della
libertà. E in questo interviene anche la letteratura, intesa come voce
di quella memoria, arte che nobilita quell'impegno. Ce ne vuole parlare?
E' una data importante. Per non dimenticare. Noi che abbiamo vissuto
quella tragedia abbiamo il dovere morale di avvertire gli altri.
Quando l'incendio è divampato è ormai troppo tardi. Non possiamo
dimenticare tutti quei milioni di vittime. È nostro dovere fare in
modo che i giovani non ne perdano la memoria. Solo rimanendo sempre di
sentinella potremo evitare di essere sorpresi per la seconda volta. Da
ogni regione in cui i partigiani hanno combattuto i reduci verranno
qu, sul monte Komelj. Lo scorso anno c'era anche Peter Handke. Lo
ammiro molto perché è una persona semplice innanzi tutto. E poi per il
modo in cui esprime le sue idee: non gli interessa se quello che
scrive può dare fastidio a qualcuno. Spesso mi viene a trovare, come
fosse uno qualsiasi dei miei amici. È stato lui a fare in modo che il
mio libro venisse tradotto. Lo riteneva importante perché questa
storia non fosse dimenticata.
Nel 1943 lei aveva 18 anni... E' stato capace di scegliere. Pensi ai
diciottenni di adesso. Come vivono oggi i giovani della minoranza
slovena di Carinzia ? Le nuove generazioni... Come le vede davanti
alle scelte che l'Europa e il mondo inevitabilmente imporranno loro di
fare ?
Questa è una domanda difficile. La vita oggi è molto diversa da quella
di allora. Oggi la gente è viziata, ha un lavoro, ha di che mangiare.
Cose che non si potevano certo dare per scontato in quegli anni. Per
questo il Fascismo ha potuto diffondersi velocemente. Accade sempre
quando non c'è il pane... E poi perché mai oggi dovrebbero fare una
scelta ? A loro non interessa affatto che il nuovo padrone sia russo o
che sia Hitler o che sia americano. Quello che conta sono i soldi. E
una vita tranquilla.
Esistono dei contatti con la Slovenia ? Vi sentite aiutati in qualche
modo?
Nei confronti della Slovenia nutro una speciale forma di delusione.
Quella non è la terra per la quale ci siamo battuti. Hanno distrutto
la Jugoslavia, che era modello per l'Europa Unita. Uno stato forte che
aveva un certo prestigio a livello internazionale. Capace di rimanere
neutrale e libero dalle politiche dei due blocchi. Oggi sono tutti
divisi, ognuno per conto suo. Non so davvero cosa accadrà. Adesso la
Slovenia è già nell'Unione Europea, tra poco entrerà anche la Croazia,
poi sarà certamente la volta dei Serbi. Quindi tutto tornerà proprio
uguale a prima; ma ci sono dovute essere tante vittime... Questo è ciò
che più spaventa le minoranze. L'Unione europea. Chi non saprà nuotare
in un mare così grande... sarà condannato a sparire per sempre. Gli
aiuti dice? Non ne vediamo, né finanziari né politici.
La scrittura... lei ne ha fatta una ragione di vita. Perché scrivere
? Per l'urgenza di non perdere la memoria, forse?
Allora: la tradizione orale dura a lungo. Ma se scrivi qualcosa, dura
per sempre. Resta! Pensi al plebiscito del 1918. Quanto materiale è
stato raccolto su come abbiano tiranneggiato la gente comune, su come
gli Sloveni siano stati derubati, arrestati? Nessuno ha mai scritto
niente di queste cose. Se solo ci fosse stato uno storico... No, a
dire il vero forse no; perché gli storici scrivono più volentieri
quando oramai non ci sono più superstiti o testimoni vivi. Alle volte
hai quest'impressione. Sai, negli anni vieni a sapere cose che prima
non conoscevi... Festeggiando i sessant'anni dalla fine della guerra,
a Poljane hanno pubblicato un libro, in cui si parla dell'ordine dato
da Tito e Kardelj a Majnik di ritirarsi dalla Carinzia. Invece nel `49
ci spronarono alla lotta per l'annessione. Che senso ha tutto questo?
Noi per averci creduto siamo stati anche rinchiusi, abbiamo subito le
perquisizioni in casa, siamo stati etichettati come Titocomunisti, un
marchio che ci rimane appiccicato addosso ancora oggi. È meglio dire
la verità anche se la strada della verità è sempre più lunga e più
difficile.
In Italia è molto difficile promuovere la diffusione di testi che
provengono dal mondo sloveno. Lo stesso Boris Pahor ha incontrato
molta difficoltà a pubblicare presso un editore italiano. Accade lo
stesso anche in Austria? E quali sono, se ci sono, le possibilità di
vedere finalmente tradotta la sua opera anche in lingua italiana?
Penso che sia una soprattutto questione di soldi. Poi bisogna trovare
qualcuno che crede in quello che stai facendo. A me è successo proprio
con Handke, che mi ha aiutato, e molto: perché se una persona come lui
parla bene di un libro, è già un buon inizio. Così è stata stampata
una prima edizione di "Mali ljudje na veliki poti". Per la seconda
c'erano ancora dei dubbi, non sapevamo se l'opera avrebbe potuto
destare ancora qualche interesse, così ho dovuto aggiungere io dei
soldi. Ma poi il libro è stato pubblicato addirittura per la terza
volta. E' inutile, bisogna fare un po' di pubblicità, vendere il pane
finche è caldo... Il libro che uscirà a novembre si occupa invece
della vita in Carinzia durante l'occupazione Inglese, tra il '45 e il
'55: quanti arresti, quante perquisizioni ! Non ho niente contro gli
inglesi, ma devo dire che qui da noi si sono comportati esattamente
come nelle loro colonie, ne possedevano molte, in mezzo mondo e le
hanno sfruttate... A Bleiburg c'era un poliziotto che indossava la
divisa inglese. Era tedesco ed ebreo, e si accaniva contro i partigiani...
Speriamo che la letteratura possa aiutare la lotta contro le guerre...
Si, ma non sarà di nessun aiuto, se i libri verranno stampati e poi
stivati nei magazzini in pile alte fino ai soffitti. Il loro posto è
qui... devono andare tra la gente...
Kolenik scompare per un attimo dalla nostra vista, per rientrare da
una porta, alle nostre spalle, silenzioso come un partigiano. Ha per
le mani un vassoio di dolcissimi kolaci: "Sono buoni. Li ha fatti mia
figlia!". Una nipotina ogni tanto occhieggia dalla cucina. E' curiosa,
ma troppo timida per fraternizzare. Basta guardarla negli occhi per
capire chi è suo nonno. "Parla lo sloveno?" chiedo temendo una
delusione. "E cos'altro? E' la nostra lingua". La risposta mi
riconcilia anche con la pioggia.
(a cura di Angelo Floramo)
--- BORIS PAHOR ---
Scheda sull'autore
Boris Pahor è nato a Trieste nel 1913, citta in cui ancora oggi vive,
medita e scrive. Laureatosi in Lettere all'università di Padova si è
dedicato all'insegnamento e alla scrittura. Ha pubblicato moltissimo,
e i suoi scritti sono stati tradotti dallo sloveno in francese,
inglese, tedesco e perfino in esperanto, ma in lingua italiana sono
stati editi solamente "Necropoli", Consorzio Culturale del
Monfalconese, Begliano 1997; "Il rogo nel porto", Nicolodi, Rovereto
2001 e "La villa sul lago", Nicolodi, Rovereto 2002. Sempre per i tipi
di Nicolodi è uscito quest'anno "Il petalo giallo" (titolo originale:
"Zibelka sveta", la culla del mondo). Per l'autorevolezza della sua
voce e il valore della sua produzione letteraria è attualmente membro
dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Ljubljana e
Vice-presidente dell'Associazione Internazionale per la difesa delle
lingue e delle culture minoritarie. E' redattore e direttore della
rivista "Zaliv" (il Golfo), che ha sempre dimostrato forte impegno per
la tutela della minoranza slovena e per il processo della
democratizzazione della Slovenia. E' tra gli scrittori candidati al
premio Nobel per la Letteratura.
Anno secondo della rivoluzione fascista. E' una trasparente mattinata
di fine autunno, già quasi in odore d'inverno. L'aula scolastica sa di
gesso e di legno impregnato d'inchiostro. Tutto regolare, non fosse
per Julka. Perché oggi ha occhi umidi di pianto la piccola Julka, che
il maestro si ostina a chiamare Giulia. Il maestro: un omino dai
capelli neri e lucidi come il catrame e il distintivo con il fascio
littorio bene in evidenza all'occhiello della giacca. "Danilo, pej
sem". Tre parole soltanto indirizzate a un compagno. Ma bastano
all'omino del fascio littorio per una condanna senza possibilità di
appello. Siamo nel 1924 e Julka ha parlato in sloveno. Perché nella
sua ignoranza etnica e caparbiamente sciava non ha ancora capito che
si chiama Giulia e che deve parlare in italiano. Non certo in
quell'altra brutta lingua. E' un reato grave, insomma, che offende i
patri confini, e la bandiera, e l'italico suolo. Ora i piccoli piedi
di Julka non toccano terra: rimane sospesa per le lunghe trecce
all'attaccapanni, dove l'omino l'ha trascinata mosso da educativo
furore. Così forse le entrerà in testa che italiani, se non lo si
nasce, lo si diventa. Appesa come un vestito sgualcito Julka sembra
una piccola farfalla dalle ali spiegate. Boris Pahor è il cantore di
questa atroce novella, "La farfalla sull'attaccapanni", ed è il
paradigma di tante altre atrocità, grandi e piccole, di cui egli è
stato testimone, suo malgrado, e che costituiscono la trama di una
prolifica vena letteraria che ancora non si è estinta, visto che
l'autore continua a scrivere, a produrre, a studiare. Le sue
narrazioni si intrecciano alla lunga memoria di una vita altrettanto
lunga, intensa, imprigionata dalle maglie di troppe libertà soffocate,
negate, sottratte. E dal bisogno esistenziale di affermare, al
contrario, il diritto di ogni essere umano alla sua inalienabile
libertà. Questa è la poetica che vivifica la sua letteratura. "Hanno
detto di me che Pahor è tutto memoria del campo di concentramento o
voce della minoranza slovena. Ma non è così. E' un'affermazione
riduttiva. Il valore etico che anima la mia scrittura è l'insofferenza
per la non libertà, di qualunque genere essa sia". Protagonista vigile
e lucidissimo del "secolo breve", sloveno Triestino classe 1913, il
che significa novant'anni indossati con affilata e arguta
intelligenza, Pahor resta ancora quasi del tutto sconosciuto
all'editoria e al mondo intellettuale italiano, che lo hanno
volutamente ignorato, a cominciare da Primo Levi che stroncò fin da
subito "Necropoli", la dolorosa esperienza del campo di concentramento
di Struthof, nei Vosgi, in cui l'autore venne internato dai
nazifascisti nel 1944. Un'opera che rimase anche per questo
totalmente sconosciuta in Italia mentre nel resto d'Europa riscuoteva
ammirati consensi e critiche lusinghiere, che definivano il suo autore
come uno degli scrittori europei più interessanti, certamente la
migliore voce vivente nella lingua di Ljubljana. Ci sono voluti
ventitrè anni e il coraggio del Consorzio Culturale del Monfalconese
perché il romanzo – che nel 1995 vinse il premio Kosovel - uscisse
finalmente anche in lingua italiana. Oggi, per unanime consenso, è
considerato un capolavoro. Eppure ancora Pahor rimane misconosciuto
dalla cultura di casa nostra, sempre più mondana e salottiera, così
poco europea da rischiare la stigmate di un sonnacchioso chic
provincialismo fatto più di mode che di sostanza. Unica gradita
eccezione l'intelligente editore Claudio Nicolodi, che ha recentemente
acquistato i diritti d'autore per l'Opera omnia di Pahor, anche per
quei romanzi (quasi tutti) che ancora non sono stati tradotti in
italiano. E forse ha avuto buon fiuto, dal momento che da più parti
giungono segnalazioni per un Nobel alla letteratura che finalmente
riconosca il valore di questa voce tanto orgogliosa della sua
"minorità". Ma chi è in definitiva Boris Pahor ? Ogni buona antologia
slovena lo pone tra le voci più rappresentative del Novecento. Nel
2001 la Germania ha inserito "Necropoli" a pieno diritto nella famosa
Bestenliste, il prestigioso elenco dei dodici libri più belli
pubblicati nell'anno. La Francia lo adora, lo coccola, lo sente quasi
suo. Gli editori parigini Phébus e Le Rocher hanno pubblicato gran
parte dei suoi lavori. E in Francia partecipa frequentemente a simposi
e pubbliche letture. E' infatti appena rientrato da St. Malo, dove
assieme ad altri 150 scrittori europei, in 3 giorni di intensa
attività, ha vivacemente animato ben cinque tavole rotonde, discutendo
di letteratura, di appartenenza, di lingue minoritarie, di libertà
negate. La rassegna si intitola: "Etonnants voyagers": viaggiatori
meravigliosi. E davvero la vita di Pahor è stata un viaggio
meraviglioso. Perché dolore e meraviglia sono emozioni che fanno
grande l'essere umano, tanto da renderlo capace di letteratura.
"A St. Malo ho parlato del Fascismo, di quello che ha fatto. Dei suoi
tanti crimini che sono spesso stati sottaciuti. E questo per non dare
troppa materia al Comunismo, che in Italia era davvero forte dopo la
seconda guerra mondiale. Per questo hanno preferito che non si
raccontasse mai la verità su quello che i fascisti hanno fatto qui a
Trieste, in Slovenia, in Croazia. E non parlo della guerra, ma del
periodo tra le due guerre mondiali. Ci hanno annientati. Ci hanno
trattato peggio degli schiavi neri. Quelli, almeno, parlavano la loro
lingua, mantenevano le loro tradizioni. A noi hanno negato tutto: la
lingua, la cultura, l'identità. Se parlavi in sloveno per strada a
Trieste in quegli anni rischiavi che qualcuno ti allungasse uno
schiaffo!"
Eppure c'è stato un tempo in cui Trieste era orgogliosa delle sue
molte anime, delle sue differenze...
"No, a Trieste non è mai interessato un granchè delle sue anime. Ci
credevano gli intellettuali come Svevo e Joyce. Ma a Trieste Svevo e
Joyce non sono mai piaciuti davvero. Certo la città aveva un nome
all'estero. Qui i bastimenti andavano e venivano da ogni parte del
mondo. E i commercianti sapevano bene che passare all'Italia avrebbe
significato la morte di tutto questo. Eppure gli irredentisti andavano
dicendo: cresca l'erba nel porto, ma vogliamo Trieste italiana ! Così
noi sloveni e croati abbiamo dovuto soccombere. Le nostre etnie, o per
meglio dire le nostre nazioni, sono state immolate ai sacri confini
della regione orientale. L'Istria era a maggioranza croata, c'è poco
da fare. C'erano gli italiani sulla costa, nessuno dice di no. Ma
l'interno dell'Istria era ed è croato. Noi in quegli anni abbiamo
pagato l'imperialismo interno dell'Italia, lo stesso che si è espresso
all'estero sui Balcani o sulla Libia, lo stesso che Bretoni,
Provenzali e Alsaziani hanno dovuto soffrire in Francia, o i Catalani
sotto il regime di Franco".
Ma come è cominciata a Trieste la persecuzione ?
"Già nel 1920. In quell'anno vennero dati alle fiamme tre centri di
cultura sloveni, uno a Trieste città, uno a Barcola e uno a San
Giovanni, assieme a molti studi di nostri avvocati, a tipografie,
teatri. Ma l'incendio dei centri culturali è stato un atto molto
forte, perché noi sloveni siamo sempre stati legati ai nostri centri
di cultura. In ogni borgo, per quanto piccolo, sorge anche oggi una
kulturni dom. E' questa consapevolezza della nostra identità che ci ha
aiutato a sopravvivere nei secoli. Nel `30, a dieci anni
dall'incendio, Francesco Giunta, uno dei fondatori delle squadre
d'azione triestine, celebrò in un libro l'evento come la prova che la
rivoluzione fascista era nata proprio a Trieste".
Lei ricorda quei momenti nella sua opera Il rogo nel porto. Che
impressione le resta di quei giorni ?
"Ho personalmente vissuto la distruzione del teatro di San Giacomo.
Era la festa di San Nicolò e il Santo, accompagnato di diavoli,
distribuiva piccoli regali ai bambini. Poi sono arrivati i diavoli
veri, quelli con il fez e i manganelli. Avevo sette anni. Ero lì con
mio padre e le mie due sorelline. Hanno gettato tutto dalle
finestre... appiccato il fuoco. Era un teatro coi fiocchi... La città
è rimastra neutra. Ha assistito senza esprimere alcun parere."
E in casa quale clima si era venuto a creare in conseguenza al fatto?
"Mio padre bestemmiava, mia mamma piangeva... e poi piangeva anche
perché mio padre bestemmiava. Era un uomo buonissimo mio padre, ma
quando si scaldava... vendeva burro, miele e ricotta a Ponterosso. Un
mestiere molto duro. D'inverno rischiavi che la bora buttasse tutto in
canale. C'era tanto freddo che mio padre si metteva un giornale sotto
la giacca, per proteggersi in qualche modo dal gelo. E d'estate invece
il burro si scioglieva per il gran calore. Pensi che sotto l'Austria
era fotografo della polizia scientifica. Poi il nuovo governo italiano
pensò bene di allontanare tutti gli amministrativi e lo trasferirono
in Sicilia. Ma mio padre preferì mettersi in pensione. E per vivere
andò ad aiutare mio nonno su questo banco a Ponterosso. Era tenace, ci
teneva alla sua identità. Volle che sulla tomba di famiglia, in
cimitero, ci fosse una croce con su scritto Drusina Pahor, famiglia
Pahor, in sloveno. In quegli anni cambiavano i nomi anche ai morti. Ma
quella croce è rimasta lì... chissà, forse perché non eravamo
importanti, non ci conosceva nessuno e così nemmeno la notarono".
Lei allora era un ragazzino...
"Ho vissuto malissimo quegli anni. Il passaggio alla classe quinta
elementare è stato drammatico. Dopo quattro anni di scuola in sloveno
dover diventare improvvisamente italiano... E' stato un disastro
completo. Ovviamente andavo malissimo a scuola. E mio padre lo visse
come un fallimento personale. Tanto che qualcuno suggerì in famiglia
di farmi entrare in seminario. Fui mandato così a Koper, Capodistria.
Una città istriana, ma abitata da lattaie e contadine croate e
slovene, come Gorizia, come Trieste. E qui ho incontrato moltissimi
altri giovani croati e sloveni, come me. Sono stati anni
importantissimi. Ho preso coscienza di me stesso. Mi sono ricostruito
psicologicamente. Ma non era certo la mia strada, quella del
seminario. Così dopo altri due anni di teologia sono uscito e appena
fuori mi hanno arruolato: era la Campagna di Libia. Un'esperienza
strana. Facevo il militare per una nazione che voleva annullare la mia
identità. Ho combattuto per quella Nazione e ho guadagnato anche due
medaglie".
E' una situazione paradossale davvero: scommetto che sulle medaglie
l'iscrizione non era in lingua slovena !
"Oh no ! Ma ero contento, in un certo senso, di essere lontano dal
groviglio Triestino. Il deserto poi mi suggeriva una vastezza di
orizzonti che non avevo mai potuto vivere prima. E gli arabi: li
sentivo a me molto vicini, una nazione oppressa dall'Italia, come lo
era anche la mia nazione. Dall'esperienza di quegli anni è nato un
libro: "Nomadi senza oasi". E poi in Libia ho potuto prendere il
diploma di maturità classica, al liceo Carducci di Bengasi. Mi ero
portato dietro tutti i libri che potevo, infilandoli in ogni tasca
disponibile. Il mio comandante infatti non mi poteva sopportare. Era
uno che aveva combattuto in Spagna per Franco... e dal momento che io
non mi interessavo proprio ai suoi cannoni, mi aveva fatto lasciare
gran parte dei miei libri a Tripoli... per ripicca".
Beh, un fatto singolare... uno sloveno che in Libia consegue la
maturità classica in un Liceo Italiano !
"E' stata una specie di riscatto. Dei trentacinque ufficiali italiani
che hanno sostenuto l'esame ne sono stati promossi soltanto sei. E tra
quelli l'unico otto in italiano è stato il mio, quello di Boris Pahor,
sloveno triestino!".
E poi l'esperienza terribile del campo di concentramento, dalla quale
nasce il romanzo Necropoli...
"Le mie simpatie per i partigiani erano evidenti. Assieme ad altri
avevo costituito nel 1944 un comitato triestino di opposizione ai
nazifascisti. Ma una settimana dopo ero già nelle loro mani. Trovarono
in casa mia dei documenti compromettenti. Avevo scritto da qualche
parte che i nazisti si sarebbero rotti la testa sulle scogliere di
Trieste. Questo è bastato. Era il 28 febbraio del 1944. Assieme a me
sono partiti altri seicento disgraziati come me".
Ma la sua voce è sempre stata pronta a condannare ogni tipo di non
libertà, da qualunque parte venisse l'oppressione...
"La mia letteratura si è sempre interessata alle storie semplici della
povera gente. La mia poetica è e resterà l'insofferenza per la
mancanza di libertà. Sono stato sempre un non allineato. Per questo
non ho mai riscosso grandi simpatie, né da una parte né dall'altra. La
lotta di liberazione partigiana è stata pluralistica, animata da un
fortissimo valore etico: comunisti, liberali e cristiano sociali hanno
lottato assieme per la libertà. Poi le cose sono cambiate. Pensi a
quello che è accaduto a Edvard Kocbek: un cristiano sociale che ha
combattuto assieme a Tito, un intellettuale di grande levatura e
apertura culturale, autore tra l'altro di un libro importantissimo e
non adeguatamente valorizzato, La Compagnia (ed. Cseo, Bologna 1979,
n.d.r.), che andrebbe rivalutato; uno che è diventato vicepresidente
del Parlamento iugoslavo... beh, è stato liquidato politicamente
perché non allineato con le scelte della Iugoslavia di allora. E gli
eccidi compiuti nel '45 contro gente disarmata non possono essere
considerati lotta di liberazione ! Io non potevo non pronunciarmi su
tutto questo. Per questo la mia è ancora oggi considerata una voce
scomoda."
E poi la fine della guerra, il ritorno a casa...
"E ancora il dramma della non libertà: in quegli anni Trieste, oltre a
Berlino, è il luogo in cui si è giocato con maggiore ferocia lo
scontro tra Oriente e Occidente. Due delle opere che compongono la mia
trilogia, come l'hanno chiamata i critici, "Labirinto" e "Primavera
difficile" (la terza opera della trilogia è "Oscuramento"; nessuna
delle tre è ancora stata tradotta in italiano, n.d.r.), sono
ambientate in quegli anni così difficili. Si parla di un amore
contrastato, della malattia di TBC contratta dal protagonista, delle
difficoltà di adattamento di un ex deportato".
Dunque ancora gabbie, ancora confini. Confini che forse l'Europa che
sta nascendo potrà cancellare. Crede che l'Europa unita, di cui anche
la Slovenia entrerà a far parte, permetterà di abbattere queste
barriere ?
"Il Presidente della Repubblica Slovena mi ha invitato a partecipare
come ospite gradito alla celebrazione della festa dell'Indipendenza
della Repubblica, il 25 giugno scorso. Ma non ci sono andato perché la
comunicazione mi è giunta troppo tardi. La lettera ci ha messo sette
giorni per arrivare da Ljubljana a Trieste. Sette giorni per
attraversare una distanza di sessanta chilometri. Come vede l'Europa
dei confini resta".
E la Slovenia, cosa potrà portare all'Europa ?
"Per prima cosa l'esempio di come si possa restare fedeli alla propria
identità senza armate, senza generali e senza ammiragli. Un'identità
bastata sulla cultura. E questo gli sloveni hanno imparato a farlo
sopravvivendo a una storia che da sempre ha cercato di assorbirli, di
omologarli: prima la germanizzazione dell'Impero Asburgico, poi il
Fascismo e l'Italianizzazione forzata e infine gli anni iugoslavi,
serbizzanti, orientalizzanti. L'internazionalismo di Tito è sempre
stato contrario alla salvaguardia delle identità nazionali. Una
posizione molto lontana da quella del Partito Comunista Italiano, che
appunto è sempre stato fiero della sua identità nazionale: prima
comunisti ma poi anche italiani. E poi la Slovenia ha una grande
tradizione letteraria. Una letteratura di valore, per quanto
espressione di un piccolo popolo, è sempre motivo di ricchezza per
tutti".
E dedicandosi a questa ricchezza lei continua a pensare, a scrivere, a
raccontare...
"L'ultimo libro che ho scritto si intitola "Zibelka sveta", la Culla
del mondo, che in Francia è stato edito da Le Rocher nel 2002. Qui in
Italia è edito da Nicolodi. E' uscito quest'anno con il titolo: "Il
petalo giallo". E' la storia di un incesto perpetrato per anni da un
padre sulla propria figlia. La protagonista si innamorerà di un
sessantenne sopravvissuto ai campi di sterminio. E i loro dolori, le
loro prigionie, così diverse ma tanto simili, si incontreranno nella
ricerca di se stessi attraverso un sentimento molto forte che dalla
conoscenza passa alla convivenza, quindi alla comprensione per
sbocciare infine nell'amore".
La donna che redime il dolore attraverso l'amore dunque ?
"La donna è la culla del mondo".
(a cura di Angelo Floramo)