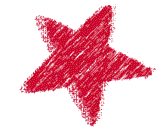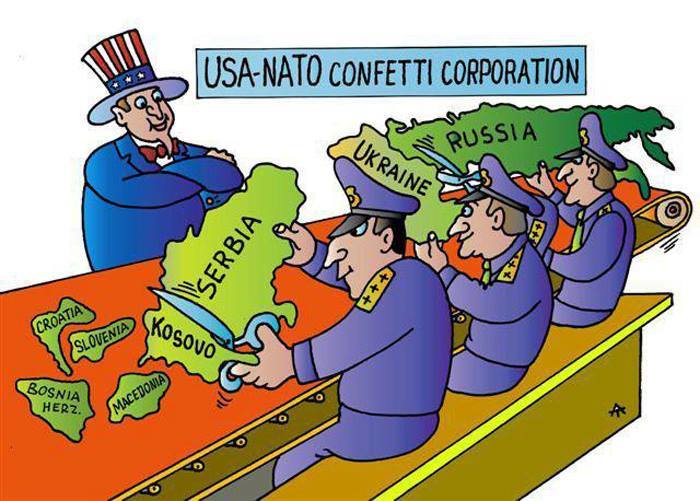Informazione
Peter Handke: Die Geschichte des Dragoljub Milanović (Die Presse)
Die Geschichte des Dragoljub Milanovic
€ 9,– / Sfr 13,50, WG 1112
[978-3-902144-93-2]
Erstverkaufstag: 25. 8. 2011
In der Nacht des 23. April 1999 um 2:04 Uhr
Rolf Becker
Zur genannten Zeit zerstörten Bomben der NATO den Belgrader Rundfunk- und Fernsehsender RTS (Radio-Televizija Srbije) – punktgenau abgeworfen wie auf Brücken (Varvarin), Wasser- und Elektrizitätswerke, Automobil- und Chemiefabriken (Kragujevac, Novi Sad, Pancevo), Krankenhäuser, Schulen und Hochschulen, Wohnviertel, sogar auf den belebten Marktplatz von Nis – die Liste ließe sich fortsetzen. Sie zerfetzten 16 der zu dieser späten Stunde noch Beschäftigten und verletzten, zum Teil schwer, eine mindestens gleiche Anzahl. Zur Rechenschaft gezogen für diesen »speziellen Krieg – der nicht ›Krieg‹ heißen durfte, obwohl die Sieger sich ›Sieger‹ nannten«, wurden weder Täter noch Staaten der vereinigten Aggressoren, sondern einzig und allein der damalige Direktor des Senders. »Die Geschichte des Dragoljub Milanovic« – Peter Handke hat sie in den ersten Monaten dieses Jahres aufgeschrieben, vor wenigen Wochen wurde sie veröffentlicht.
Nur 32 kleinformatige, dabei großzügig gesetzte Druckseiten. Aber was für eine Geschichte. Vor wenigen Wochen erreichte mich der Anruf serbischer Freunde, Peter Handke zu fragen, ob er bereit sei und Zeit habe, die von mehr als 700 allein in Deutschland unterzeichnete Petition zur Freilassung von Dragoljub Milanovic der Regierung in Belgrad zu übergeben – anders sei die Aufmerksamkeit der Medien dafür kaum zu gewinnen. Seine Antwort liegt jetzt vor, schwarz auf weiß, statt des vermutlich vergeblichen Bittganges zu den neuen, den Siegermächten hörigen Herren; veröffentlicht zunächst in deutscher, vielleicht auch bald in serbischer Sprache, wünschenswert in allen NATO-Sprachen. Anmerkung Handkes zur Petition: »... die aber keiner der ›führenden westlichen Intellektuellen‹ unterschrieben hat – außer Harold Pinter (aus dem Jenseits).«
Nein – kein politisches Pamphlet, keine Kampfschrift, kein moralischer Appell, auch wenn diese Geschichte Peter Handkes seitens einiger auf vermeintlich politische Korrektheit bedachter Wächter in den Feuilleton-Redaktionen als Rückfall des Autors in seine Rolle als »echtester Erbwalter alter jugoslawischer Kultur und Tradition« (Welt online) gewertet wird. Auffallend aber zugleich, daß die Summe der Tatsachen, die in den zehn seit dem Überfall vergangenen Jahren ans Licht gekommen sind, sogar Blätter wie die FAZ zu ein wenig differenzierterer Stellungnahme veranlaßt: »Man mag zu Peter Handke stehen, wie man will, speziell aufgrund seiner umstrittenen Haltung zu Serbien: Er ist nun einmal das ›Nein‹, das hinschaut, das sich mit einfachen Wahrheiten nicht zufriedengibt. Das zeichnet ihn aus.« Und über Dragoljub Milanovic sogar: »Er wurde verurteilt und ins Gefängnis gesteckt für eine Tat, die andere begangen haben: nämlich wir. Seit neun Jahren ist er Häftling in einem Gefängnis seines eigenen Landes, wegen der nächtlichen Bombardierung seiner Fernsehanstalt durch die NATO.« Das Eingeständnis wird allerdings wenige Zeilen später relativiert durch Gemeinplätze wie: »Der bedrängte Staat funkt Durchhalteparolen, der andere will Aufgabe: Konflikt programmiert« mit der entsprechenden Folgerung: »Wenn man sich just an der Stelle aufhält, an der das Skalpell angesetzt wird, dann fließt Blut.« 16 Tote, 16 Verletzte, drei davon schwer – so einfach ist das aus der Sicht mancher Redaktionsstuben.
Bei allem, was Peter Handke infrage stellt, wird ihm die Version der Siegermächte und der von ihnen geschaffenen Einrichtungen wie dem Haager Tribunal entgegengehalten. So stellt sich für das österreichische Fernsehen »die Frage, ob das serbische Fernsehen tatsächlich nur Kriegspropaganda betrieben hat oder, wie Handke meint – und er bezieht sich auf seine subjektive Wahrnehmung der gesendeten Bilder 1999 – eben nicht. Denn daß den Bildern von den angerichteten Schäden und den Opfern des NATO-Einsatzes Bilder mit blühenden Landschaften eines unzerstörten Landes entgegengestellt wurden, das will der Erzähler nicht als Propaganda sehen« (ORF). Fazit: Bestätigung der NATO-Version – der Sender mußte ausgeschaltet werden, punktgenau. Handkes Zweifel, Einwände und Belege werden wie bei seinem in diesem Sommer bei den Salzburger Festspielen uraufgeführtem Stück »Immer noch Sturm« vom ORF »seiner träumerischen Auseinandersetzung mit der eigenen Kärntner-slowenischen Familiengeschichte« zugeordnet. Anders die Neue Zürcher Zeitung: »Es stimmt schon: Die Sieger dieses Krieges maßen sich mit andern Ellen als die Verlierer, und in Bezug auf die Bombardierung hängt über dem Haager Kriegsverbrechertribunal der Verdacht der Siegerjustiz.« Nachsatz allerdings, um die NATO-Mächte, darunter schließlich auch die benachbarte BRD, nicht als Aggressor zu bestätigen: »Aber exkulpiert dies automatisch die Verlierer? ... Handkes Wut ist dort produktiv, wo sie westliche Heuchelei demaskiert. Doch sie vernebelt ihm den Blick, wenn es um die serbischen Zustände jener Jahre geht.«
Wie umgehen mit einem Autor, der sich von seinem Bemühen um geschichtliche Wahrheit nicht abbringen läßt und sich samt seinen Lesern dem Mainstream verweigert? Die Autorin der bereits zitierten Online-Ausgabe des Springer-Verlages scheint zu glauben, Peter Handke (ausgerechnet ihn!) auch ästhetisch abwerten zu können: »Halb Literatur, halb literarisch entgleisende Realfiktion. Und stellenweise auch Kitsch, wenn er Milanovic beschreibt: ›Die Hände des seit fast zehn Jahren Eingesperrten lagen während des ganzen Gesprächs bewegungslos auf dem Besucherzellentisch, eine still über der anderen, bis am Ende der Stunden für einen Augenblick sich noch eine dritte Hand darüberlegte.‹« Als wäre der Eindruck, den Handke beschreibt, falsch, wenn Milanovic im Laufe des mehrstündigen Gespräches tatsächlich mal seine Hände bewegt hätte; falsch wie all das, was er zur Zerschlagung Jugoslawiens und zum Bombenterror gegen die serbische Bevölkerung geäußert hat: »Handke taugt nicht zum politischen Agitator, zu sehr läßt er Wut, Trauer, Trotz und Sarkasmus ineinander fließen. Wie bei jedem, der aus der Emotion heraus Politik betreibt, entstehen Fehler, Ungenauigkeiten. Handke interessiert sich nicht für das präzise Geschehen. Er fügt an: ›wenn ich mich recht erinnere‹ und: ›oder so ähnlich‹. Die literarische Form ermöglicht die Rettung ins Ungefähre.« Bild lesen statt Handke, denn: »Als literarisches Werk bietet das Buch, bis auf ein paar Seiten, wenig Genuß.«
Ein vergleichbar erhellender Rundumschlag findet sich im Berliner Tagesspiegel: »Liebe Literaturpreisjurys, vergeßt Peter Handke! Es bringt euch nur Ärger und Peinlichkeiten, wenn ihr versucht, den österreichischen Autor auszuzeichnen. Eigentlich ist das ja seit dem Eklat um den Heinrich-Heine-Preis der Stadt Düsseldorf vor fünf Jahren klar. Damals sperrten sich die Stadtoberen gegen die Entscheidung der unabhängigen Jury. Jetzt gibt es eine verkleinerte Neuauflage dieser Posse. Es ist ein Skandälchen mit Ansage: Peter Handke bekommt den Candide-Preis, aber nicht das Preisgeld von 15 000 Euro. Denn dem Sponsor – ein Buchbindemaschinenhersteller – paßt die Wahl der fünfköpfigen Jury nicht. Er weigert sich, die Summe zur Verfügung zu stellen … Grund für den Konflikt ist wie schon 2006 Handkes Engagement für Serbien. Sein Werk hat der 1942 in Kärnten geborene Schriftsteller dadurch tief beschädigt.«
»Es ist hier eine Geschichte zu erzählen« – so beginnt Peter Handke, und er löst ein, was er wie einen Auftrag ankündigt, nicht mehr und nicht weniger. Was den Zorn der Herren des Mainstreams auslöst, ist der Wahrheitsgehalt dieser Geschichte, ist das Fragen und Hinterfragen, auch Provozieren ihres Autors, der seine Wahrnehmungen und Erfahrungen gegen das von Politik und Medien verbreitete Bild verteidigt, gegen »die von vornherein festgestandenhabenden Sieger, beziehungsweise Gewinner ... Eine Geschichte demnach, erzählt allein den toten Fischen in der toten Donau, den leeren Maiskolben auf den leeren Feldern der Vojvodina, einem vertrockneten Blumenstrauß in einer verrosteten Konservendose auf dem Friedhof von, sagen wir, Porodin, und zuletzt dem Schädel, oder was von ihm übrig ist, im Grab von Ivo Andric.«
Resignation? Keineswegs, sonst würde Peter Handke die Geschichte nicht publizieren. Bitter gelegentlich, zynisch sogar angesichts der Kräfteverhältnisse, die es trotzdem zu verändern gilt. Provokation zum Nachdenken, Überprüfen und entsprechenden Eingreifen, zu dem er, der Einzelne, schreibend seinen Beitrag leistet: »...was für eine Art von Krieg. Devise: Ein Hirngespinst, wenn es amtlich wird und Arm der Macht, findet immer einen Gesetzesparagraphen, welcher es auf die Sprünge bringt – es realisiert; mit anderen Worten: in den Schein eines Rechts setzt.«
Über diesen Krieg »gegen den Staat, welcher damals noch ›Bundesrepublik Jugoslawien‹ hieß« hat er in zahlreichen Romanen, Theaterstücken, Berichten geschrieben. Hier beschränkt er sich – scheinbar – auf das Beispiel eines Senders: »Dem Tony und dem Bill genügte es, daß das serbische Fernsehen dokumentarische Bilder, unterlegt mit einem Berichtston, von den ›Luftschlägen‹ sendete, samt all den zivilen Kollateralopfern – es gab fast nur solche, zu guter Letzt an die 2.000 (zweitausend) –, und das völkerrechtlich geschützte Zivilobjekt RTS gab ein berechtigtes ›Ziel‹ ab; es brauchte nicht einmal der übliche Kollateralirrtum fingiert zu werden.« Den im Mainstream dahintreibenden Medien stellt er nicht mehr – und nicht weniger! – als seine eigene Wahrnehmung entgegen: Ich bezeuge, daß nicht ein einziges der damals gezeigten Bilder und/oder Tonbilder, auf eine beinah unfaßbare Weise bei allen den zentralen Zerstörungen und tangentialen Menschenzerfetzungen, etwas wie Tendenz oder Propaganda, geschweige denn Haß oder Rachsucht ausstrahlte.«
Handke wird zum Zeugen für Dragoljub Milanovic, »Häftling in einem Gefängnis seines eigenen Landes«, der »nicht imstande gewesen war, sich ›vorzustellen, daß in unserem Land absichtlich ein ziviles Ziel bombardiert würde ... am Eingang des dritten Jahrtausends‹,« und noch weniger, »daß danach die Repression solange weitergehen würde, ›bis wir zugeben, die Schuld an dem Angriff selber zu tragen‹.« Wie der ehemalige Bürgermeister von Varvarin, der vor Gericht gestellt werden soll, »weil er an dem bewußten Himmelfahrtstag, als zwei Bomben auf die kleine Brücke über die Morava – dort im Süden noch ein Flüßchen – abgefeuert worden sind, das Sperren der Brücke verabsäumt hatte; denn er hätte wissen müssen, daß von März bis Juni 1999 ausnahmslos jede, selbst die unbedeutendste öffentliche Einrichtung als Kriegsziel in Frage kam; daß durch die Bomben auf die Brücke von Varvarin die eigene Tochter des Bürgermeisters, des predsednik opštine, getötet worden ist, tut der Strafbarkeit keinen Abbruch.«
Mit Georg Büchner’schen Purzelbäumen hebt Handke gegen Ende seiner Geschichte Widersprüche, die unlösbar scheinen, auf. Wie jener die fürstlichen Popanze der Reiche von Pippi und Popo läßt er die Tonys und Bills der Imperien unserer Tage schlichtweg ungeschehen machen, was sie gestern angerichtet haben.
Handke lesen. Und sei es nur diese kleine Geschichte, in einer künftigen Gesellschaft der Weltliteratur zuzuordnen: »So höre, Schuhband, zerschlissenes. Hör zu, verrosteter Nußknacker. Hör zu, krumme Nähnadel. Höre, verstaubtes Stofftier. Höre, mein abgewetzter Fußabstreifer. Höre zu, Spiegelbild.«
Peter Handke: »Die Geschichte des Dragoljub Milanovic«, Jung und Jung Verlag, 37 Seiten, 9 €
Ossietzky, Ausgabe 24/2011
E' nata indoona : chiama, videochiama e messaggia Gratis.
Scarica indoona per iPhone, Android e PC
A Vukovar e ritorno
Giovedì 14 novembre 1991, Giovanni Minoli mi chiede di andare a Belgrado. Vorrebbe un pezzo sul conflitto serbo-croato visto dalla parte dei serbi. "Vanno tutti a Zagabria", mi dice "perché non tentiamo di vedere cosa succede sull'altro fronte?". Faccio un rapido conto di tutti i cronisti che in pochi mesi sono stati direttamente rimpatriati per degna sepoltura e mi chiedo "ma perché proprio io?", poi la risposta che mi do è quella che più mi conviene, cioè quella di avergli dimostrato di sapermi destreggiare rapidamente in Paesi a regime comunista e in situazioni piuttosto complesse, come la Cina, il Vietnam e la Cambogia. Mi invita ad essere cauta e a non espormi troppo "raccogli materiale alla TV di Belgrado e se valuti di avere sufficienti garanzie di protezione, raccogli qualche testimonianza dal fronte". La partenza è prevista per sabato 16. Verso l'est europeo non ho mai nutrito particolare curiosità e le faccende della Jugoslavia non erano il mio punto di interesse. Semplicemente non le capivo. Tutto quello che sapevo proveniva dalla cronaca dei giornali o dai servizi televisivi: pochi, confusi, con un dato chiaro — la Comunità europea permette la frammentazione della Federazione jugoslava, la Croazia vuole l'indipendenza, e la Serbia ha attaccato. Con la riluttanza di chi deve bussare alla porta dell'aggressore, mi leggo 240 pagine di rassegna stampa. Cronache e analisi troppo ravvicinate per capire l'insieme. Passo un pomeriggio a conversare con un professore di origine polacca dell'Università di Udine, esperto di storia dei popoli slavi, Richard Lewanski. Lui è filo-niente, semplicemente uno storico puro e ne ricavo una grande lezione sulla composizione etnica di quello strano Paese, con origini, conseguenze, fatti e dati.
Quando sbarco a Belgrado mi intoppo nella burocrazia comunista: niente permessi, tempi lunghissimi per accedere agli archivi della TV, problemi per avere una troupe. Aggiro l'ostacolo facendo un salto nel bar dove vengono reclutati i volontari. Belgrado è una città tranquilla che non dà segni di tensione, e i ragazzotti in tuta mimetica, che si aggirano fra le coppiette sedute ai tavolini del famoso bar, con mitragliatore e corredo di pistole infilati nel cinturone, mi sembrano francamente degli esaltati che giocano alla guerra. In mezzo a loro c'è il comandante Arkan, un tipo con la faccia più da barista che da guerriero, nonostante il suo torbido passato. Gli chiedo notizie su Vukovar (secondo la stampa italiana del giorno era caduta in mano ai serbi), lui mi dice che ci sono 2000 civili in ostaggio degli "ustascia" dentro una fabbrica di scarpe e che la situazione laggiù andrebbe vista per essere capita. Mi offrono un passaggio per il campo base di Erdut (20 Km. da Vukovar). E' mezzanotte e parto così come sono, con una video8 male equipaggiata (solo un paio di batterie e cassette) e una giacca a vento bianca (!), ma è meglio di niente. Mentre la jeep con il suo carico di soldati e un prete ortodosso viaggia verso Vukovar, mi compiaccio della mia rapida scelta: all'indomani girerò qualcosa mentre partono per il fronte, un paio di interviste ai soldati, altre due in un campo profughi, in serata di ritorno a Belgrado e la faccenda è chiusa. Quando imbocchiamo la statale in direzione di Vukovar, nei villaggi non c'è più luce e cominciano i posti di blocco; i federali vogliono vedere il mio permesso, ma la parola di Arkan sembra valere come un timbro ufficiale. Alle 3 mi dà un cuscino e una coperta. I tonfi sordi dei cannoni, a poca distanza dal campo base, non hanno su di me un effetto rilassante e quando alle 5 Arkan mi sveglia, l'occhio era ancora sbarrato. "Si va al fronte, se non hai paura puoi venire, a patto che tu stia dove c'è il centro di raccolta profughi e non ti metta a girare da sola come un'idiota". Tira un'aria decisamente diversa da quella di Belgrado e non mi entusiasma l'idea di muovermi di lì, ma l'orgoglio professionale supera la ragionevolezza. La strada taglia in due la pianura infinita della Krajina, ora seminata a cannoni e cani armati.
"Lo sai che da 10 anni è in corso una trattativa con la Germania per la costruzione di una centrale nucleare tedesca proprio qui" mi dice Arkan. "No, non lo so". "Allora informati!". Quando compaiono le prime case mi sembra di entrare nella memoria dei racconti di mia madre dei bombardamenti a Milano. "Voi avete fatto tutto questo?" chiedo ad Arkan. E lui mi risponde "Chi ha distrutto Anzio? Categoria infame, pensate sempre che la guerra si combatta su un fronte solo?". Mi scarica alle 6 del mattino in un quartiere di Vukovar (Borovo) e lì passo tutta la giornata su una strada fangosa, al freddo, insieme a una quarantina di soldati. Ogni tanto un camion scarica vecchi, 20, 30 per volta. Sono serbi e croati. Si ammassano in una delle tante case sulla quale si è abbattuta una punizione troppo grande per essere umana. Quando ci piombano addosso i colpi di mortaio, i soldati mi trascinano in un scantinato che normalmente usano come latrina. Ci rimaniamo 4 ore. Nel pomeriggio arriva l'autobus della stampa, scendono i cronisti, si mescolano ai profughi, registrano il loro "stand-up" e 10 minuti dopo se ne vanno. Vorrei andarmene anche io, ma senza il famoso permesso non si sale; così non posso fare altro che aspettare la sera, quando Arkan mi riporterà al campo base. Non ho mangiato, non ho bevuto, ho contato 25 camion che caricavano e scaricavano un'umanità trovata nascosta in qualche scantinato chissà da quanto tempo. Gente che non aveva nessuna voglia di schierarsi da una parte o dall'altra. Qualcuno mi mostra la sua vita: tutta dentro un sacchetto di plastica, un maglione, un cappotto, una mela. Come un indumento delicato passato attraverso l'alta temperatura di una centrifuga. Attorno alla fabbrica di scarpe si continua a sparare ferocemente, mentre dentro ci sono ostaggi sia serbi che croati. Quella sera nessuno torna a Belgrado, e il giorno dopo, replica. Un uomo viene accompagnato dentro un'ambulanza militare. Bisogna identificare un corpo decapitato e mutilato. E' suo figlio. Penso che mi infilerò a tutti i costi nell'autobus della stampa, che corromperò qualcuno, che me ne voglio andare. Ma quel giorno l'autobus non arriva. E di nuovo nessuna jeep va a Belgrado. Il 19 non è giornata di fronte. Seguo Arkan in un giro di routine: visite in ospedale ai suoi soldati feriti, torturati e a civili senza più famiglia che mi raccontano di essere sopravvissuti ai più efferati massacri. In un paese fra Novi Sad e Vukovar, Arkan si ferma ad una stazione radio; è considerato un idolo, ed ha un collegamento diretto con gli ascoltatori. Non mi pare che quel genere di "fan" meriti particolare attenzione, e vado a farmi un giro per le strade. Entro in uno stanzone dove una lunga coda di persone attende qualcosa, l'assistente sociale mostra un elenco: "Solo nomi, niente cognomi; non vogliamo sapere se siano serbi o croati, ma solo trovargli una sistemazione, perché non hanno più nulla!". Verso le 4 del pomeriggio si ritorna ad Erdut, e da lì finalmente a Belgrado. Ad un posto di blocco Arkan viene informato di un massacro di bambini a Borovo Naselje. Mi chiede se me la sento di filmarli. Durante il tragitto gli dico che preferirei parlare con qualche prigioniero, poiché scene di massacri ne abbiamo viste già troppe. In realtà vorrei evitare di vedere. Chissà quanti cronisti durante la giornata saranno già passati di là e le immagini saranno comunque reperibili. Durante il tragitto, interrotto da controlli di prigionieri, posti di blocco, cambi di jeep il mio pensiero è paralizzato. Non sto guardando la guerra da una prospettiva ampia, ci sono dentro e non posso allontanarmi. Un gruppo di volontari non ha cambiato la fascia di riconoscimento sulla divisa e si sono sparati addosso con i soldati federali. Arkan urla come un pazzo. Troppi profughi nelle strade, troppi arresti. Bisogna uscire rapidamente dalla jeep perché ci stanno sparando addosso dalle case. I soldati si riparano correndo da un muro all'altro, da un camion a un carro armato, loro mi spingono e io li seguo di corsa con la faccia a terra; dalle finestre delle case sventrate sparano in tutte le direzioni e noi stiamo in mezzo. Loro hanno il giubbotto antiproiettile e io una giacca a vento bianca che con il buio sembra un bersaglio. Do una cassetta ad un militare con la telecamera a tracolla e gli chiedo di girare qualcosa per me. Non sono un cameraman di guerra io, e la sola cosa che mi interessa è di riportarmi a casa la pelle e ho paura di doverla lasciare li per terra, dove i tre che tentano di farmi scudo mi buttano. Faccia contro il muro. Uno di loro mi indica di seguirlo strisciando lungo la parete. Qualche metro e un piccolo volto mi balza negli occhi. Accanto a lui altri, buttati lì come cose senza significato. I piccoli senza vita sembrano ancora più piccoli. Lo stomaco si ribella e le gambe si piegano sotto al terrore dei proiettili che bucano il muro sopra la mia testa. Devo filmare. Tre operazioni: togliere il tappo, camera, standby, pulsante rosso. Impiego troppo tempo e delle braccia mi trascinano via, dentro un trasporto truppe pieno di prigionieri. Vedo Arkan, che mi dice: "Devi andare con loro, perché poi li consegnamo ai federali " ma non c'è posto e i soldati mi spingono fuori. Lui mi pigia dentro e il portellone si chiude.
Il trasporto blindato parte velocemente, sbandando sul fango e io non ho appoggi e sbatto la testa e le ginocchia contro il ferro. Un tragitto di un'ora senza un pensiero, solamente l'attesa di un'esplosione improvvisa e una vampata di fuoco. Al campo base dei soldati mi dicono che ogni notte pregano Dio perché non li risvegli più. lo penso a mia figlia di 7 anni e a quelle madri a cui la pietà divina ha forse risparmiato l'orrore portandosele via prima. Non ho avuto il tempo di mettere nessuna protezione su quella parte fragile che vive candidamente in tutti gli uomini e così l'insopportabile è penetrato senza ostacoli. Piango come solo una madre può fare. Vorrei parlare con mio marito, ma mi sembra una crudeltà inutile. Telefono a Minoli, gli racconto la giornata e mi scuso per non essere stata in grado di fare il mio Iavoro, per aver scelto male stavolta il suo inviato. Al contrario di quel che si pensa di lui, mi ha pregato di non tornare più a Vukovar, che non gliene importava nulla e che un altro forse si sarebbe fermato a Belgrado. All'alba del giorno 20 chiedo se mi danno una scorta per ritornare sul luogo della sera prima. Arriva una jeep con una prigioniera, mi dicono che ha ammazzato una decina di persone con l'aiuto del fidanzato. Le chiedo perché, e lei mi risponde che il prete della sua parrocchia, durante la messa diceva sempre che appena la guerra sarebbe esplosa bisognava fare fuori i serbi. Sul luogo della sera prima non c'è più traccia dei bambini, l'esercito federale li ha portati via durante la notte. La storia di Vukovar è finita e quello che ha lasciato nei cortili, dentro ai forni delle cucine o attaccato ai pali della luce non è altro che l'impronta della guerra: una condizione nella quale nessuno si fa del bene. Anche se i nostri focolari si spaventano e ci persuadono della barbarie dell'Altro. Il 19/20/21 novembre l'Ufficio Informazione del Ministero della Difesa di Belgrado aveva bloccato i permessi di accesso a Vukovar e Borovo a tutti i cronisti. Il 21 novembre leggo in aeroporto la notizia del massacro. La fonte è l'agenzia Reuters. Qualche ora dopo, quando arrivo a Roma, è già stata diramata la smentita. Quale comportamento occorre adottare quando hai visto qualcosa che le fonti ufficiali smentiscono? Quando non hai prove e neppure autorevolezza? Io ho seguito, con convinzione, le indicazioni del Direttore della testata per cui stavo lavorando. Minoli non ha appreso la notizia dai giornali, ma due giorni prima da me, e il mio rapporto di collaborazione con Mixer non è mai sconfinato in eccessi. Ho fatto la cronaca del mio viaggio "casuale" (Mixer 2/12/91) e montato le interviste raccolte senza l'asetticità dell'inviato che morde e fugge, poiché la mia condizione era diversa. Il mio compito era chiaro e dichiarato in apertura di trasmissione "dalla parte dei serbi". Ero con i volontari serbi perché era il solo modo di arrivare in quei luoghi in quei giorni. Ho vissuto il loro odio, le loro paure, ho visto lo strazio di civili che hanno subito scelte senza condividerle, e ho cercato di esprimere tutto questo. In guerra anche i bambini muoiono, ma su quei corpi si era accanita una volontà precisa. Con quale coscienza avrei potuto ignorarlo? Ho avuto la percezione, solo la percezione, mai la certezza, che si trattasse di bambini serbi e ho lasciato che si intuisse. Non ho sposato nessuna causa, e credo che sia onestamente azzardato farlo in una guerra civile; ho solo seguito la linea editoriale che, in quel caso, proponeva il racconto di un'esperienza personale.
Da allora, e per lungo tempo, sconosciuti hanno subdolamente minacciato me e Minoli al telefono, mentre in forma ufficiale le Associazioni, e il Comitato Pro-Croazia, hanno iniziato una campagna di protesta indirizzata al Direttore e al Presidente della Rai e presentato un esposto alla Commissione Parlamentare di vigilanza sottolineando quanto segue:
"... mai una volta la Vostra "inviata" ha evidenziato la verità dei fatti e cioè che Vukovar è stata attaccata e distrutta e le popolazioni uccise e deportate dall'esercito serbo e dai sanguinari cetnici, violando la Convenzione di Ginevra. Neanche il sig. Goebbels avrebbe effettuato una così sfacciata manipolazione delle notizie come invece avete inteso fare Voi utilizzando una TV di Stato".
"... Dal punto di vista dell'etica giornalistica la Gabanelli ha fatto un pessimo servizio alla verità e alla sua rete Tv. La giornalista afferma di aver visto molti bambini sgozzati, ma non li ha filmati, non li ha contati e soprattutto non ha potuto verificare se si tratta di bambini croati o serbi. Tuttavia ha lasciato l'impressione che si tratti di bambini serbi. Non si è premurata di verificare chi sia in realtà il comandante "Arkan", un criminale. I bambini di Borovo Naselje erano tutti croati.... Disgustoso poi l'interrogatorio della povera ragazza, dai cui occhi traspariva il terrore di una prigioniera che attende dì essere scannata e che recita una parte che le è stata imposta. Dalla diocesi di Djakovo ci giunge la conferma che non esiste alcun sacerdote cattolico che risponde al nome detto dalla prigioniera. Chiediamo rettifica a nome dell'obiettività e dell'imparzialità".
"... per oltre 20 minuti mai una volta la Signora Milena Gabanelli ha riferito il vero, Vukovar è una città croata, attaccata e distrutta dai guerriglieri serbi, e la popolazione uccisa e deportata è di nazionalità croata".
Le suddette contestazioni, il cui obbiettivo era quello di ottenere una rettifica da pare del garante per l'editoria, hanno certamente una legittimità. Le persone che, in Italia, sostengono la causa croata, difficilmente accettano che venga messa in discussione l'innocenza del popolo croato, cioè di tutti i croati, nessuno escluso. Mi sembra inevitabile però fare un paio di precisazioni: Vukovar è una città a popolazione mista (secondo i croati a maggioranza croata e per i serbi a maggioranza serba), e tutto quello che ne consegue (distruzioni, omicidi e deportazioni) ha toccato entrambe le etnie. Io ero da parte serba e quindi parlavo di loro, né più né meno come i miei colleghi fanno quando si trovano da parte croata (cosa che succede molto più spesso). Non ho filmato il massacro. E a questo punto è legittimo il dubbio, ma la certezza mi sembra un po' azzardata, poiché io ero là, mentre chi mi accusa si trovava in Italia. Non li ho contati e non ho controllato i documenti per verificarne la nazionalità, è vero. Vorrei solo un altro esempio di collega diligente che in una situazione analoga abbia agito diversamente. Mi sembra opportuno ricordare che la paternità degli eccidi viene addebitata solamente al fronte opposto rispetto a quello in cui l'inviato si trova. Trattandosi di un terreno sul quale non è facile muoversi da soli, è evidente che in qualche modo la verità è sempre deformata. Io ho parlato di "percezione" e non di certezza. In altri casi (dal fronte croato) si parla sempre di certezze. Non esistendo in Italia un Comitato pro-Serbia, queste certezze non vengono mai contestate. Per quel che riguarda la prigioniera, io mi sono limitata a fare "un'intervista", avvenuta senza essere concordata con nessuno. La traduzione si è rivelata fedele alle mie domande, quindi non ho ragione di pensare che siano state fatte delle pressioni in quella circostanza. Comunque durante la trasmissione, dopo la testimonianza della prigioniera, il filmato è stato interrotto dalla seguente precisazione di Minoli: "La signora fa affermazioni molto pesanti, ma ricordiamoci di Moro, Cocciolone ecc. Si tratta di una prigioniera e quindi potrebbe sentirsi costretta a fare queste affermazioni per tentare di salvarsi". E a questo intervento io ho ribadito dicendo "la sola cosa che si può dire è che in una condizione di non libertà la prigioniera sostiene che il prete Borislav Petrovic incitava all'omicidio. Non possiamo dire che questa sia in assoluto la verità".
La cronaca ci ha mostrato in seguito e in varie occasioni un serbo prigioniero dei musulmani, che dichiarava di essersi a lungo allenato a sgozzare maiali, prima di eseguire la pratica su qualche decina di "nemici". Si è gridato all'orrore, senza valutare la sua condizione dì prigioniero.
Il 13 gennaio 1991, il garante per l'Editoria, Giuseppe Santaniello, con una pronuncia di 13 pagine, ordina alla Concessionaria per il servizio radiotelevisivo la rettifica adducendo le seguenti motivazioni:
"Appare accoglibile la richiesta a che venga rettificata l'affermazione che nell'ambito delle ostilità del conflitto jugoslavo vi sarebbe stata una strage di bambini, lasciando intendere, dal contesto della trasmissione, che i bambini fossero serbi e gli autori dell'eccidio croati. La verità appare smentita dalle deduzioni del Comitato Pro-Croazia e dalle risultanze documentali, ivi comprese notizie di cronaca di testate giornalistiche".
Però nell'ordinanza del garante c'è un riscontro interessante:
"Con riferimento alla notizia secondo cui tal sacerdote Borislav Petrovic avrebbe incitato dal pulpito eccetera,... la Sacra Congregazione per il Clero ha evidenziato le seguenti circostanze: nello schematismo della chiesa cattolica esiste un sacerdote di nome Borislav Petrovic [1], ma a giudizio dei suoi diretti Superiori, si tratta di un sacerdote assai pio e assolutamente alieno da ogni forma di fanatismo e nazionalismo. La notizia quindi riportata dalla rubrica Mixer va rettificata nel senso che non sussistono elementi oggettivi, idonei a dimostrare le circostanze dell'incitamento al massacro di serbi da parte di tal sacerdote Borislav Petrovic".
Sul piatto della bilancia pesano di più le deduzioni del Comitato Pro-Croazia della mia testimonianza, peraltro non supportata da alcunché. E' evidente. Per quel che riguarda le notizie di cronaca di testate giornalistiche, si basano essenzialmente sulla notizia diffusa dalla Reuters secondo la quale un fotografo jugoslavo ha prima denunciato il massacro e in seguito ha precisato: " Ho visto solo qualche corpo di bambino che veniva messo nei sacchi di plastica ".
Nessuno si è preoccupato di andare a verificare sul posto, tranne l'inviato del settimanale "Oggi", Andrea Biavardi. Ma il suo pezzo, nel quale venivano riportate testimonianze di sopravvissuti che dichiaravano di essere a conoscenza dell'eccidio, non è stato tenuto in considerazione. Invece Andrea Biavardi mi ha in seguito riferito di essere stato oggetto di pesanti diffamazioni.
Per quel che riguarda la testimonianza della prigioniera, ho già detto che è stata fatta una precisazione durante la trasmissione. Che altro si pretendeva? Che l'intervista venisse censurata perché alcuni argomenti infastidiscono? E' sufficiente l'opinione dei diretti Superiori del sacerdote per ordinare una rettifica? Evidentemente sì. I colleghi, ad esclusione del Corriere della Sera e di Repubblica non hanno perso l'opportunità di spargere un po' di facile veleno (poteva essere un'ottima occasione per smentirmi coi fatti, ma era un tantino rischioso e forse anche un po' complicato). Sul fronte dei quotidiani mi limito a citare l'Avvenire del 4 dicembre 1991: "Milena Gabanelli, serba, regista di professione, coniugata con un italiano, inviata a Vukovar da "Mixer'' come giornalista (sic!) ... è stata condotta in tarda serata in uno scantinato buio per farle intravedere cadaverini inesistenti di bimbi massacrati dai croati ... Quanto è stata disgustosa quell'intervista che la nostra "giornalista" ha effettuato a una povera donna croata prigioniera, con evidenti segni di violenza sul volto, torturata e costretta ad accusarsi di crimini non commessi. Quella di Milena Gabanelli è stata una sporca propaganda serba ...". L'articolo è firmato da Giovanna Sopianac e Maja Snajder. Io non ho pregiudizi verso i loro cognomi, ma sembrano indicare una origine diversa dalla mia, italiana da sempre, e che metteva piede in Jugoslavia per la prima volta nella sua vita [2]. Ma non è questo il punto, pare invece che essere serbi significhi "non diritto alla parola". Può darsi che le due signore abbiano ragione, ma forse non è il pulpito più adatto per calare una simile sentenza. Per quel che riguarda la mia professione, sempre messa in dubbio con virgolette o (sic!), sarebbe stato più corretto verificarla presso l'Ordine dei Giornalisti, visto che nello stesso articolo si accusa me di non aver verificato cose inverificabili. Il resto non merita commento.
Purtroppo la storia non si ferma qui. Continuo a fare il mio mestiere e oltre alla striscia di Gaza, il Nagorno Karabah, c'è anche un ritorno a Vukovar. In quell'occasione pubblico un pezzo su un settimanale nel quale non cito mai serbi o croati, ma descrivo semplicemente quello che rimane dopo una guerra. Al direttore di quel settimanale viene inviato il seguente telegramma: "... Protestiamo vivamente che sia consentito a questa signora, sotto accusa presso ordine professionale su nostra iniziativa per clamorose falsità... di poter aprire la bocca sui tragici avvenimenti di Vukovar obliando proprie gravissime responsabilità e sottacendo quanto compiuto in vile collaborazione con la politica di inganno difformativo promossa dai servizi segreti serbi. Ove trattasi di una Maddalena pentita bene sarebbe stato prima di tutto come la Maddalena evangelica confessare le colpe trascorse. Sicuri che non pubblicherete ma tanto per mettervi di fronte alle Vostre responsabilità e alla Vostra coscienza inviamo non cordiali saluti. Comitato Pro-Croazia. Professor Vittorio Menesini". In tutte le guerre ci sono sempre stati gli schieramenti, durante la guerra del Vietnam, nessun inviato è stato processato per aver raccontato le atrocità che compivano i vietnamiti ai danni degli americani. Sappiamo che è successo, e sappiamo anche che gli americani avevano torto. Nel caso della guerra in Jugoslavia la verità "deve" stare da una sola parte, altrimenti sei un "collaboratore dei servizi segreti serbi".
E la storia continua, e si ridiscute di fronte al Consiglio del mio Ordine Regionale. C'è l'esposto dell'Avvocato Menesini e quindi si avvia la procedura. "Signora Gabanelli, ci racconti cosa è successo quel giorno a Vukovar" mi chiede il presidente della Commissione, Luca Goldoni. La sottoscritta racconta, ancora una volta. E' umiliante, ma è la procedura. "Era mai stata precedentemente inviata su un fronte di guerra?".
"Ero stata in zone di guerriglia. La mia esperienza riguarda pezzi di approfondimento di politica estera. Doveva essere così anche stavolta, poi le cose sono andate diversamente. Con l'esperienza dell'inviato di guerra sarei stata più cauta e certamente testimone di nulla". "Signora Gabanelli, io non ho ragione di non credere a una sola parola di quello che ci ha raccontato. Purtroppo non possiamo sottovalutare l'esistenza di una pronuncia del Garante" mi dice Luca Goldoni.
Il mese dopo una raccomandata mi informa sulla decisione dell'Ordine. Nessuna sanzione disciplinare (come chiedeva l'esposto del Comitato Pro-Croazia facendo appello al codice di deontologia professionale), ma un innocuo "avvertimento". Dopo avermi concesso il beneficio della buona fede e l'oggettiva difficoltà del lavoro, il Consiglio dell'ordine concludeva così la propria sentenza "... inquadrando il caso nel clima di quanto sta accadendo nel vicino territorio, e dunque in un contesto stravolto da rivalse etniche, politiche, religiose, Mixer, forse con eccessiva precipitazione, ha calato Milena Gabanelli, giornalista senza una specifica scorza da inviato, in una realtà bellica 'anomala e confusa' che pertanto ha avuto come relatrice televisiva 'una cronista altrettanto anomala e sicuramente occasionale'"
Avrebbero potuto darmi una sospensione, (e poi saremmo finiti in tribunale) e invece mi hanno detto "attenta, non lo fare più". Infinitamente ringrazio. "Anomala e occasionale"? Considerando la piattezza che mi circonda non posso nemmeno offendermi. Come non mi offendono Riva e Ventura quando nel loro pregiatissimo libro "Jugoslavia, il Nuovo Medio Evo", scrivono: "... Mixer rilancia il massacro, ospitando la testimonianza ambigua di una collaboratrice da Belgrado" [3]. La grande accusa che in tutta questa faccenda mi è stata rivolta, è quella di non aver "verificato"; eppure coloro che hanno riempito pagine non si sono neppure degnati di controllare la mia nazionalità. Non mi risulta che un'informazione del genere rischi di essere sulle traiettorie delle pallottole. Per il resto, vorrei solo sottolineare che non ho speculato sulle disgrazie altrui affinché il mio nome emergesse. Era un'ottima occasione, eppure ho rifiutato il bombardamento della stampa e della televisione che è seguito alla trasmissione. Soprattutto ho voluto evitare di cadere nella facile trappola dalla quale si sarebbe a tutti i costi voluto far emergere una persona filo-serba. Avevo un compito, ho cercato di svolgerlo nel migliore dei modi. Poi, sono passata ad altro.
[1] Una posizione parecchio divergente da quella del Comitato Pro-Croazia, che, come abbiamo visto, dichiarava: “non esiste alcun sacerdote cattolico che risponde al nome ...”.
Tratto da: Marco Guidi, "La sconfitta dei media" (Bologna, Baskerville, 1993), pp.125-135.
IL DRAMMA BELLICO DI VUKOVAR
E' nata indoona : chiama, videochiama e messaggia Gratis.
Scarica indoona per iPhone, Android e PC
In The Land of Blood and Honey, a movie by Angelina Jolie
By William Dorich
I preface this review by admitting that I am not a film critic—however, I have written six books on Balkan history and as a journalist, many of my articles have been published dealing with the Balkans that have been reproduced in the International Herald Tribune, The Wall Street Journal, The Washington Times among others and published in the Serbian press for two decades.
In the Land of Blood and Honey, I wish to correct what I observed and relate my opinion as to the distortion of historic facts. I will leave the artistic side to those who are more qualified. Sex, violence and fabrication appear alive and well in Hollywood as cinematic tricks are used to distract and “entertain” us.
Angelina Jolie wrote, directed and produced Blood and Honey. I do not think many in Hollywood expect much from her film-directing debut. Jolie has unfortunately diverted our attention away from the facts regarding the Bosnian Civil War that she used as the backdrop for her exaggerated melodrama. She seems clueless that she plagiarized Shakespeare.
When Jolie went into this film production she was fully aware of the emotional scars and personal losses of many Bosnian families, especially those of mixed marriages who will view this film. Pretending that her film is just make-believe but based on actual events is a cop-out lacking responsibility—the kind of responsibility Jolie demands when human rights are violated.
Jolie arrogantly brushes aside the real Romeo & Juliet of Bosnia, sniper killed on May 19, 1993. He was Bosko Brkic, a Bosnian Serb, and she was Admira Ismic, a Bosnian Muslim—they were assassinated as they tried to escape the Muslim side of Sarajevo by crossing the Vrbanja Bridge for safety on the Serbian side of the city. In their dying embrace they remained on that bridge for several days. The media, like vultures, manipulated their deaths and the ugly visual image for the benefit of their front pages.
But Jolie’s newest Romeo, Danijel played by Serbian actor, Goran Kostic and Juliet, Ajla, played by Muslim actress Zana Marjanovic weaves a different story using sex, aggression and murder that perverts an audiences’ senses into believing that violence, mistreatment and enslavement are supposed to represent a romance in the midst of an ethnic war. Granted, this is the prerequisite for a successful film today in Hollywood and I acknowledge that the film was not intended to be a documentary, but, then again, propaganda always starts from this position.
The beginning of the film shows Ajla getting dressed for a date with a Serbian policeman. The following scene is of them dancing in a Sarajevo nightclub, meant to show a multi-ethnic city being shattered by a bomb blast, obviously launched by the Serbs. The next scene erupts with women being dragged onto a bus headed for what else? A Serb Rape Camp! Little footage is wasted before these women are taken from the bus and moments later a Serbian policeman throws one of them over the hood of a vehicle, pulls down her pants and rapes her. Next the policeman grabs Ajla and proceeds to rape her when Danijel, her Serb love interest, prevents the rape and tells his fellow officer that she is not to be touched. Ajla survives the story locked in a room and only sleeps with Danijel. Why a young man would spend a war defending a woman with whom he only had one date rings hollow in this plot. Turning that into another “Romeo & Juliet of Bosnia” comes off as rather naïve.
Jolie uses this Serbian bombing as the beginning of her film, ignoring the real start of the Bosnian Civil War when Muslim terrorists crashed into a Christian Serbian church during a wedding in Sarajevo, telling the guests that “Serbs were no longer allowed to display their centuries-old flag because Bosnia was now a Muslim country.” The thugs then shoot and kill the father of the groom and proceeded to seriously wound the Serbian Orthodox priest and a dozen of the wedding guests.
Jolie omits any reference to the more then 2,000 Muslim terrorists who came to Sarajevo from Osama bin Laden’s training camps in Afghanistan and who tortured and executed a dozen Serbian soldiers by roasting them on spits like animals and decapitated dozens more then carried their severed heads around Sarajevo as trophies. My files contain several of those hideous photographs.
Jolie also cleverly omits the fact that thousands of Serbs were fired from their jobs including my friend who worked for Sarajevo Television for over 25 years. Muslims went throughout Sarajevo’s apartment buildings evicting Serb tenants who lived in those units for decades. After tossing Serb families out they threw their possessions out of the windows into the street. Jolie never touches on the fact that 250,000 Serbs were cleansed from Sarajevo and were forbidden to return to cast their ballots in the first Bosnian election in which Alija Izetbegovic won the presidency by only 44,000 votes. Any rationale for the Serbian retaliation including self-defense in this film was obviously left on Jolie’s cutting-room floor.
The Croats who fought the Bosnian Muslims for 4 years escape notice and were made invisible in this film. The Bosnian Muslims were portrayed as innocent victims brutalized by overpowering Serb forces.
As I sat through this film I was reminded of Peter Brock’s outstanding book, Media Cleansing: Dirty Reporting—Journalism and Tragedy in Yugoslavia in which one chapter is entitled “Only Muslim victims, Only Serb perpetrators.” This movie, much like the contemptible record of the partisan press that covered this Civil War, keeps reinforcing the lie that“300,000 Bosnian Muslims were killed.” Like Goebbels during the Holocaust who preached “Tell a lie a hundred times and it becomes the truth,” the lie of 300,000 deaths and 60,000 rapes was repeated by the media for 7 years and the world was made to believed it.
Through reputable human rights organizations we now know that less than 97,000 victims were killed on all sides in these Balkan Civil Wars, hardly enough victims on any side to be considered “Genocide.” We also know that Jolie was fully aware of the 800,000 victims hacked to death in Rwanda two years earlier that Jolie managed to ignore. However, it appears she embraced any Bosnian propaganda that fit into her melodrama.
The dialogue does briefly acknowledge Serb victims at The Battle of Kosovo in 1389, an historical event that will escape 99% of any audience viewing this film. Also the casual mention of the Croatian Ustashe Nazi forces in WWII who liquidated 1.4 million Serbs, 60,000 Jews and 78,000 Roma Gypsies is connected with a “Chetnik” remark (Serb Chetniks fought the Nazis) that will escape her audience as well.
While the Serbian Orthodox church received its share of blame in the media and in this film, no connection is made to the late Serbian Patriarch Pavle who not only led over a million Serbs in protest marches that were the largest and longest in decades against the Milosevich government, but also during an interview with the Swiss Federal Parliament on December 10, 1992 the Patriarch told officials: “800 Serb women were documented as repeated rape victims in 20 camps operated by Muslims and Croats.” The patriarch also cited the Yugoslav State Commission for War Crimes on August 2, 1992—the same day Newsday’s “death camp” stories went on American newsstands that identified locations at Sarajevo, Tuzla, Bugojno, Bihac and Slavonski Brod where Serb women were confined, raped and murdered by Croat and Muslim soldiers.
The Romeo & Juliet “love story” wears thin before the film finally puts the audience out of its misery when Danijel shoots his Muslim lover Ajla in the head at point blank range. The last scene of the film provides a final opportunity for Jolie to demonize the Serbian people as Danijel craws to his knees before UN police and claims several times: “I am a War Criminal, I am a War Criminal,” a remark designed to remain in the minds of the audience as they leave the theater.
The film however, does not embrace an audience; it stuns and bludgeons them with the rape issue. Jolie does not waste a good opportunity for full-blown propaganda by ending her film credits with various war-related statistics. In bold type one reads: “50,000 Bosnian rape victims,” a number that has long been discredited numerous times over the past dozen years. If this film is being presented as fiction, these statistical records were used for political reasons.
The fabrications, partisan journalism and crude propaganda of the Bosnian Civil War by the international media can be summed up by one lone account from French journalist Jerome Bony, who described in a February 4, 1993 broadcast about his trek to Tuzla, which gained notoriety as the most prominent Bosnian town for finding Muslim rape victims:
“When I was fifty kilometers from Tuzla I was told to ‘go to the
Tuzla gymnasium (high school) (where) there are 4,000 raped
women.’ At twenty kilometers this figure dropped to 400. At ten
kilometers only forty were left. Once at the site, I found only four
women willing to testify.”
The Land of Blood and Honey hemorrhages vulgarity with no “honey” to sweeten the pain of multi-ethnic violence in which all sides were responsible for inhuman war crimes in a three-sided Civil War.
Like the Kangaroo court in The Hague, Angelina Jolie’s film continues the process of condemning the Serbian people with collective guilt—denying them equal rights and equal justice as international political leaders continue to amputate portions of Serbian territory against her will and in violation of the UN Charter in which Serbia was a founding member; the Geneva Conventions; the Helsinki Final Act, and the NATO Treaty including violating UN Resolution #1244 that guaranteed Kosovo as sovereign Serbian territory as part of the peace agreement arranged by Richard Holbrooke. Surely, Jolie cannot be this ignorant?
If this film was meant to portray Ms. Jolie’s impressions of the war, sadly she did not take advantage of her public persona to give the wounded and divided people of Bosnia a reason to heal. As a Serb, I left the showing alarmed that once again the word “Serb” has been made synonymous with evil—It appears then that Blood and Honey is Angelina Jolie’s attempt at verbal genocide.
__________________
William Dorich is the author of 6 books on Balkan history including his 1991 book, Serbian Genocide 1941-45 and his 1992 book, Kosovo. He is the recipient of The Order of St. Sava, the highest recognition given to a layperson by the Holy Synod of Serbian Orthodox Bishops; An Award of Merit from the Serbian Bar Association of America and a Freedom Award by RAS—The International Serbian Organization.
E' nata indoona : chiama, videochiama e messaggia Gratis.
Scarica indoona per iPhone, Android e PC